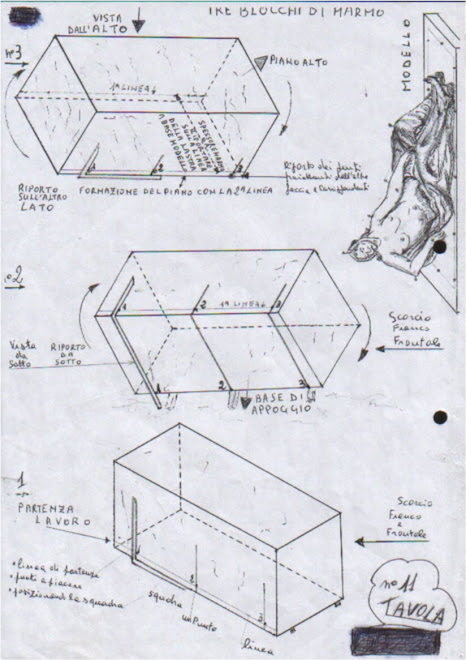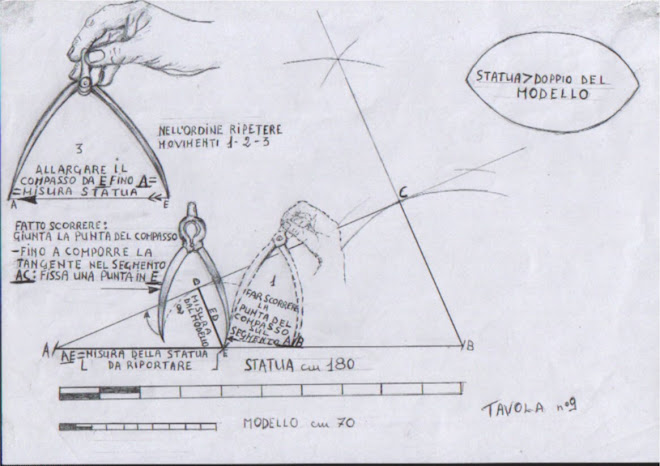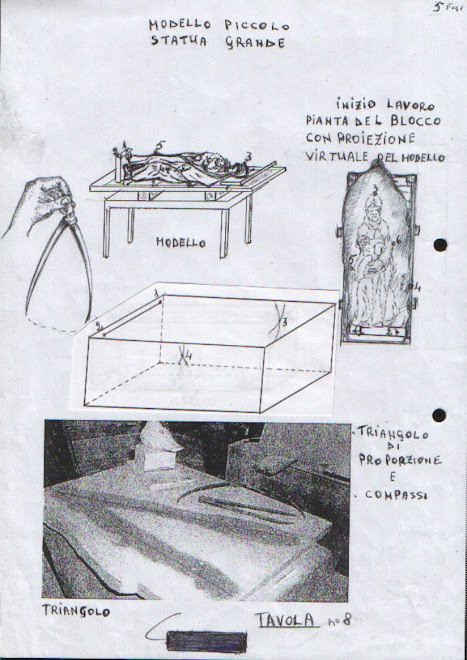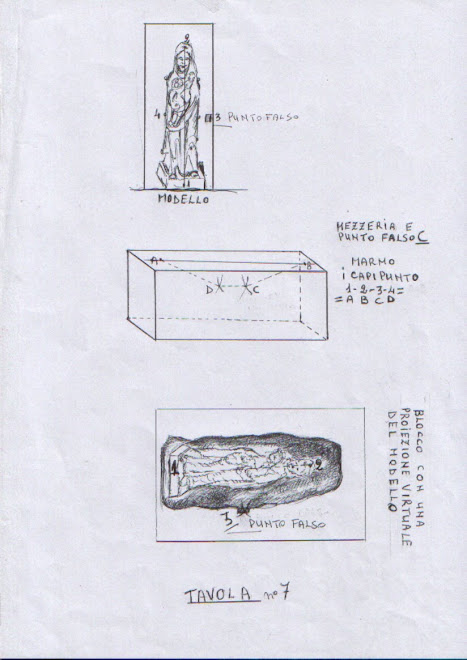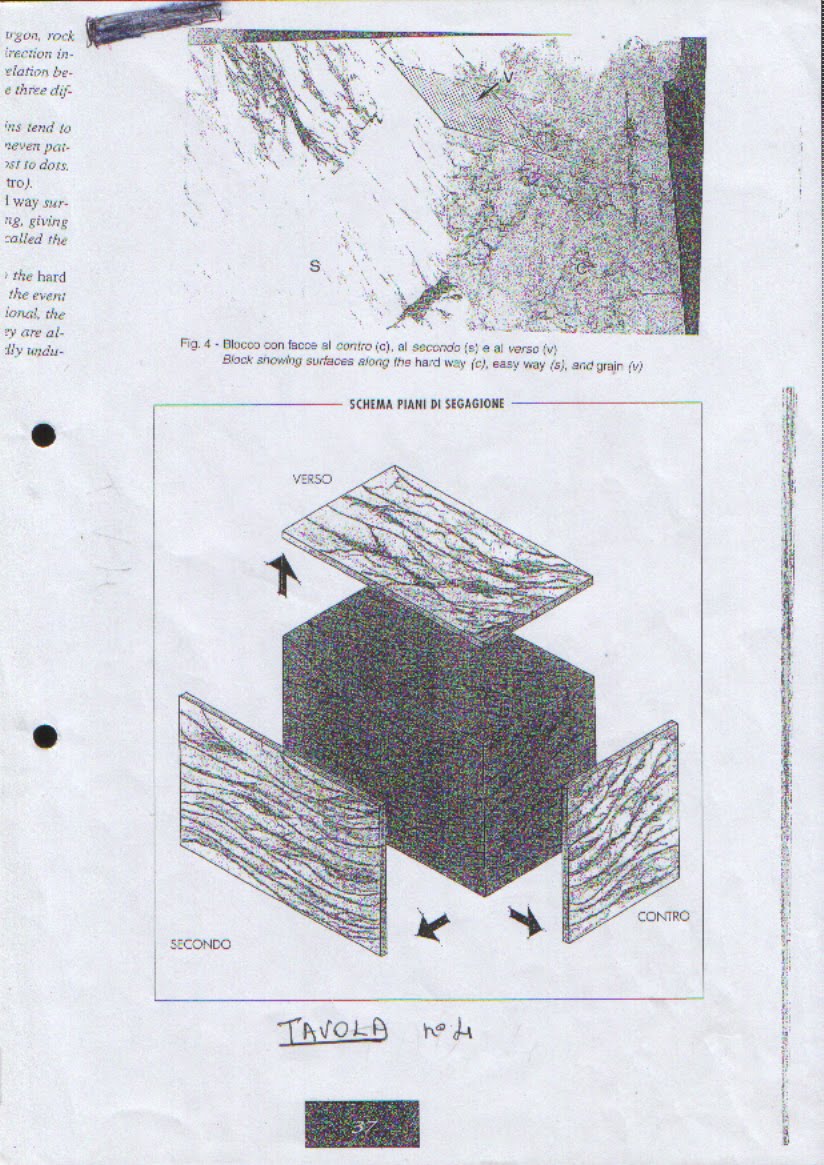I PUNTONI NELLA SCULTURA.
I "PUNTONI" in edilizia sono un elemento architettonico delle capriate (le due travi inclinate ). Nella smodellatura il termine è riferito ad un listello più o meno alto, rispetto alla grandezza del lavoro e ad essa proporzionato sia nel marmo sia nel modello. All'apice di ogni puntone è contenuto un capo-punto, da trasportarsi dal modello alla statua in marmo ( similmente,ognuno di questi due ha i suoi puntoni con capi-punto): i listelli si innalzano, sopra il modellato di entrambi, nel rispetto delle proporzioni, in scala, prefissate. In dialetto sono detti anche "piri" . La parte in basso, opposta al capo-punto, è attaccata e al marmo e al modello.
Dobbiamo considerare anche la quantità di puntoni da installare: saranno numerosi tanto quanto l'estensione del lavoro e dei campi utili alle proiezioni; quindi, adeguati ad un sistema modulare per tempestare di punti la riproduzione, e più questi saranno fedeli e numerosi, più la riproduzione sarà soddisfatta e perfetta.
Il listello, elemento rettilineo in marmo o in legno, può raffigurarsi come una retta perpendicolare che interseca il piano sul quale è fissato; cioè in posizione ottimale per proiettarsi sulle misure necessarie. Disponendo le punte del compasso, una ferma sul suo punto di testa, l'altra, secondo un'apertura prescelta, con la possibilità di ruotare di 360° intorno al detto puntone, si può cogliere e riportare, dal modello alla statua da eseguirsi, tutti quei punti necessari e uniformemente proporzionali, soprattutto le "cale", per una buona e fedele esecuzione. Volendo raffigurare questa operazione, dandogli un significato geometrico, immaginiamo di appoggiare una squadra al puntone, cioè alla sua vera altezza o distanza del suo vertice dal piano di base: così, abbiamo posto la squadra con un cateto verticale e l'altro a contatto con il piano di lavoro ( del marmo o del modello ).
Se pratichiamo, con la squadra, le stesse rotazioni intorno al puntone sperimentate con i compassi, avremo chiaro che le misure da prendersi sono riferite a segmenti di obligua, e cioè alle distanze del capo-punto dal modellato, raffigurabili nell'ipotenusa (lato opposto al'angolo retto) e diverse dalla distanza dell'altezza dal piano, la quale, nel suo punto di intersezione, è definita piede della perpendicolare. Però, non tutti i punti si collocano sullo stesso piano, per cui definire tutte le distanze come ipotenusa è puramente indicativo della direzione che l'apertura del compasso misura, dall'apice del listello, portando una sua punta sulla linea (la lunghezza o cala) che collega due o più punti tra loro. Questi rappresentano quel particolare intaglio che, mano a mano, plasmerà tutte le espressività della figura: vi possono essere plasticità o profondità spaziale; oppure ogni effetto che si voglia realizzare con il volume o le perforazioni, dove sono potenziati tutti quegli elementi espressivi che giocano a contrasto ( es. il chiaroscuro). Ancora, attraverso sporgenze e rientranze, si possono rappresentate azioni di moto o dinamismo o tutte quelle altre emozioni/sensazioni che si vogliono trasmettere. Capita spesso di dover abbassare, rispetto al piano, i capi- punto di partenza, 1-2-3, per recuperare volumi emergenti del modellato.
Il punto di partenza è sempre un piano perfetto, sia del modello sia della statua, piani che formano lo stesso angolo con la linea dell'orizzonte.
Iniziamo il lavoro; si comincia a fissare, su un lato del marmo, gli stessi punti 1 e 2 del modello, sempre in proporzione: poi - stiamo operando su un piano come se fossimo sul foglio da disegno -, facendo uso del compasso, centrando prima sul punto 1 e poi sul 2, tracciamo sulla formella l'intersezione dei due archi che darà il punto 3.( I capo-punti 1 e 2, se li uniamo con una linea, sono un segmento di riferimento, che con la linea di mezzeria ad esso perpendicolare, possono essere utilizzati per orientare meglio il lavoro ).
Dopo i tre capi-punto di partenza, cominciamo ad individuare, strategicamente, i puntoni necessari per mezzo delle triangolazioni:
Il primo listello ( 4° capo-punto ), come tutti gli altri, già preventivamente stabilito sul modello, è riferito ad altri tre punti: si determina come si farebbe per determinare il vertice di una piramide solida, a base triangolare,che risulta simile alla stessa provata sul modello, con le stesse manovre dei compassi, ma con aperture diversamente proporzionali. Per trasportare dal modello al marmo questo punto, e poi via di seguito tutti gli altri, dobbiamo comprendere che le due prime intersezioni dovranno incrociare a 90°, almeno non discostarvisi di molto; mentre la linea del terzo spigolo laterale, che si proietta e si unisce al vertice della piramide come gli altri due, fissa defnitivamente il punto.
Fissati i puntoni necessari, si inizia a tempestare di punti il modellato secondo un ordine sparso, prima fissando quelli essenziali per dare una assestata al marmo (sbozzatura); poi, lo smodellatore ne infittisce il traporto delineando la trama di un tessuto che riproduce fedelmente il modello e la figura ne esce sempre più finemente lavorata.
Le triangolazioni debbono essere strategiche funzionali alle zone dominate dai puntoni, per aumentare l'efficacia delle misure, sia delle lunghe sia delle cale e la loro precisione. ( Non è male sfruttare le coste del marmo e del modello, ed anche le sporgenze del modellato ). A questo punto del lavoro, è consigliabile segnare, sempre sul piano ma prossimi ai lati del lavoro, alcune triangolazioni, per semplificare il riporto delle misure lunghe, lasciando ai puntoni solo il compito delle cale. Quindi, sul piano del marmo e del modello, insediare alcuni capi-punto di servizio che interfacciano con quelli dei puntoni, per utilizzare uno schema di triangolazioni, che abbia la capacità di incrociare le intersezioni senza difficoltà.
L'altezza del puntone, dall'intersezione con il piano ad angolo retto, può avere una distanza variabile, per cui le misure proiettive dal capo-punto al piano posssono essere più lontane o più vicine. L'operazione effettuata con il compasso misura l'ipotenusa, di un virtuale triangolo rettangolo, del quale un cateto giace sul piano e l'altro si identifica con la verticalità del listello/puntone. E' facile prevedere ( v. Teorema di Pitagora ) che, aumentando le misure dei cateti, si auenta contemporaneamente anche l'ipotenusa. Nella sua semplicità questa considerazione ci porta ad indicare il seguente accorgimento: le altezze dei puntoni vanno previste già sul modello, scandagliando bene le zone di dominio e il loro limite ( orizzone proiettivo ), per adottare misure più esatte. Va' da se che quando queste sono più vicine al piede del listello la loro misura è più garantita. Ne consegue che la gittata del compasso previlegia la linea più breve che unisce fra loro due punti dati. Per questo motivo, trattasi di individuare il ragionevole limite di campi o zone di ogni puntone per operare in sicurezza.
E' opportuno chiarire cosa si intende per LEGAME DELLE TRIANGOLAZIONI NELLA SMODELLATURA, parafrasando: " operazione topografica e geodatica mediante la quale si determina e misura una rete di triangoli adiacenti di cui si fissano i vertici sul terreno per la formazione di carte topografiche e geografiche". Abbiamo preso in prestito questa definizione, con lo scopo di chiarire il nostro intento: individuare, sul piano diverse posizioni date nel modellato, legandole a quelle di numerosi punti ben collegati tra loro. Questo sul piano, ma noi siamo interessati a trovare un punto nello spazio, cioè un piano, come se dovessimo individuare, tutte le volte, il vertice di una piramide, a base triangolare. Per questo motivo il lavoro preparatorio dei capi-punto va fatto a regola d'arte, partendo sempre da un piano di riferimento.
Nello smodellare con i puntoni, indicare il vertice di una piramide può trarre in inganno, poichè le cale sono a spingere ( e qualche volta anche le lunghe ); dobbiamo considerare, come in questo caso trattasi di trovare una piramide in posizione rovesciata ( misure a spingere, dall'alto in basso come nell'operare su un oggetto concavo ). Mentre negli altri casi, i più comuni, sono a stringere verso il basso: il termine è sempre riferito al togliere roba cioè marmo per arrivare alla misura del punto da riportare.
PRECISAZIONI
L'esempio sopra citato, riferito ad una immaginaria rotazione delle squadre intorno al puntone, è stato fatto anche per mettere in risalto un'altra configurazione: " per trovare ogni nuovo punto sul marmo bisogna riferirsi almeno a tre altri punti analoghi già preventivamente stabiliti sul modello non disposti su una stessa linea: insomma, precisamente come si farebbe per determinare p. es. il vertice di una piramide solida da costruirsi, mettiamo a base triangolare, e che dovesse risultar simile ad un'altra piramide data ed egualmente disposta". Ritorniamo su questa non sintetica regola, in maniera ortodossa, per sottolineare come, con le misure prese dai e sui puntoni, si può dare l'idea di un interazione che, con i movimenti dei compassi, consente di ottenere una percezione immediata delle intersezioni medesime, e come ogni punto corrisponde ad un piano trovato nello spazio. Qui, è il capo-punto al vertice del puntone. Difatti, la stessa postura dei puntoni, installati inizialmente dai tre capi-punto di partenza (1-2-3), rendono bene l'immagine di una piramide a base triangolare, e come le misure identificate negli spigoli laterali della stessa, possono ben rappresentare le misure che partono ed arrivano ai capi-punto dei puntoni. Da questi, fin dove è consentito spingersi con l'apertura dei compassi, operando in quello spazio laddove non vi può essere alcun margine di errore ( fin dove " tirano " precisi ). Abbiamo così definito il concetto do campo ragionevolmente utile, la cui estensione è più provata dall'esperienza che da un imposto lmite teorico.
Diversa e complementare funzione è quella che assume il concetto di modulare; qui, si intende impropriamente: " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta a un'altra più semplice ". Un gruppo di persone può assumere una forma trapezoidale, oppure come La Pietà del Michelangelo quella piramidale; un mazzo di fiori la conica, e così via. Cosicchè nei nostri campi o zone di lavoro si propone l'intaglio con quella schematizzazione delle forme e semplificazione che,nella scultura, prende il nome di sbozzatura, ed è una prima assestata al marmo con il riporto dei punti principali. Poi, lo smodellatore scopre e definisce sempre di più, nel prosieguo, le forme particolareggiate.
lunedì 24 gennaio 2011
martedì 18 gennaio 2011
CHIARIMENTI
Alcune osservazioni utili.
Recenti pubblicazioni sostituiscono arbitrariamente, scambiandole, il trasporto delle misure effettuate per mezzo dei compassi, con quelle del pantografo o come esclusiva del triangolo di proporzione; e, riferite a quest'ultimo, dichiarano: “ che permette di considerare di volta in volta tre angoli o tre punti come i termini necessari per individuare il vertice di una piramide”. Ma non è così ! Il triangolo di proporzione “ permette “, esclusivamente, di riprodurre nella scala voluta il modello, operando poi, con il sistema delle triangolazioni e delle intersezioni. Il pantografo invece è utilizzato dallo smodellatore, per il trasporto dei punti dal modello al marmo e quando debba effettuarsi una statua di uguali dimensioni al modello, “ a ritratto “ o in scala da 1:1. Diversamente, come già osservato, è il metodo dei compassi, sia negli ingrandimenti sia nelle riduzioni, che prefigura per il trasporto di ogni punto, la piramide. La tecnica è completamente diversa dal pantografo. Pur lavorando sulle stesse figure geometriche solide, solo con i compassi, lo smodellatore, osserva la regola delle tre misure ( lunga, profondità e cala ) per individuare un piano ( un punto ) nello spazio, anche nel caso di un medesimo lavoro a ritratto. Nell'opera di smodellatura sono migliaia i punti necessari ad una buona riproduzione; è qui che, per ogni punto, si determina, prefigurandola, il vertice di una piramide a base triangolare. Lo scolpire è un concepire, individuandoli e metabolizzandoli, piani nello spazio.
Diversa è la copiatura di un disegno sul foglio, rappresentando, per mezzo delle intersezioni, delle figure geometriche piane, le cui linee e punti sono contenuti sullo stesso piano. Rammentiamo alcuni presupposti: a) per due punti passa una sola retta e da essa infiniti piani ; e per tre punti, non allineati, un solo piano. Proviamo ad immaginare una porta o sportello girevole i cui cardini coincidono con i due punti di una retta: il loro movimento è di 360°, in qualsiasi piano di proiezione verticale/orizzontale/obliqua, come individuiamo una loro posizione ( grado di apertura ) presente in una stanza, se non abbiamo una terza misura di riferimento?
Lo smodellatore, con l'ausilio dello sbozzatore, scandaglia il blocco, mettendo i primi punti guida ( capi-punto ), riportandoli dal modello, in maniera che possa realizzarsi la statua nelle volute dimensioni. Vi è sempre, nella partenza, un piano di riferimento, ottenuto con tre punti non allineati: due alla base, uno in cima alla testa della statua (argomento ampiamente trattato nelle tecniche di lavorazione ).
Vediamo come si opera con il pantografo.
Immaginiamo il blocco come se fosse un contenitore: una stanza è un esempio maggiorato del nostro parallelepipedo, c'è il piano del pavimento ed il soffitto, oltre le pareti; così, in maniera più appropriata e ridotta , una vasca da bagno lo è, se pensiamo ad un corpo che vi si immerge totalmente e sopra di esso si chiude il velo o il piano dell'acqua, come se fosse un tetto. Poiché nella riproduzione, il marmo deve poter contenere completamente la figura, si inizia individuando i piani del modello e del marmo, il detto velo dell'acqua, in modo che i tre punti di ciascuno lo rappresentino e formino, con la linea o piano dell'orizzonte, lo stesso angolo visuale ( a livello ). Si comprende facilmente che la nostra partenza utilizza il piano in alto del blocco per contenere tutte le forme della figura sottostante. I tre capi-punto non allineati, che indicano il piano, sono posti alla superficie, due alla base ed uno in cima alla testa della statua e del modello. Sopra di essi, adeguatamente combacianti, sono i tre puntali posti all'estremità della croce, che sono la base portante, e piano virtuale, di tutto l'apparecchio ( detto pantografo o macchinetta).
Le misure si prendono trasportandole dal modello al marmo, muovendo in blocco tutto lo strumento: dopo aver fissato - tramite un morsetto, al regolo verticale della croce, sempre all'altezza voluta - un altro regolo, alla cui estremità è innestata un'asta di ottone, che può muoversi sia in senso verticale che in senso orizzontale e sorreggere un braccio di ottone manovrabile in tutte le direzioni. Il braccio comprende una punta di acciaio scorrevole, che viene fermata quando tocca un preciso punto del modello, così si ricavano tutte le misure desiderate.
Inizia così lo scandaglio col fissare i punti principali, ricavando le larghezze, le altezze e le parti basse; poi lo smodellatore, lo scultore e tutte le altre figure proseguono l'opera. Talvolta è necessario abbassare i tre capi-punto del marmo, se quelli del modello – cioè il piano da loro prefigurato – lasciano sporgere fuori ( al di sopra ) gambe, braccia o altre parti della statua. L'intaglio e l'arte del levare è possibile quando c'è materiale, in dialetto “ roba”, per scolpire le parti esistenti nel modello. Ricordiamoci della vasca d'acqua, se un parte anatomica sporge fuori, è anche fuori dal blocco. Significa che ci siamo “mangiati” il lavoro.
Per sbiancare il marmo:
(1) Per renderlo nuovamente bianco creare un composto di 1 bicchiere d’acqua – 1 bicchiere di succo di limone – 1 cucchiaio di bicarbonato. Applicare sul marmo e con una spazzola a setole rigide (non di ferro), strofinare con cura, sciacquare con cura ogni gradino, prima di passare allo scalino successivo.
(2)Una volta finito, mettere del bicarbonato sui gradini di Marmo e bagnare (non in modo abbondante), così da fare una sorta di poltiglia, spalmarlo con uno straccio sui gradini e lascia agire per circa 15-20 minuti (il bicarbonato pulirà la porosità del marmo) successivamente sciacquare con cura e asciugare con uno straccio, possibilmente di lana.
Essendo un Marmo esterno, è consigliato ripetere la procedura del Bicarbonato (punto 2) almeno due volte al mese, così da tenere pulite le porosità del marmo, che sono le più difficili da pulire con una sola passata di straccio imbevuto in acqua e sapone di Marsiglia (utilizzare questa pulizia nelle settimane alterne a quella del Bicarbonato).Altri rimedi da provare per la Pulizia del Marmo:
Rimedio1: Pulizia generale marmo - l’acqua migliore per pulire il marmo è l’acqua distillata, con dell’aggiunta di sapone di Marsiglia. E’ consigliato non usare né l’aceto, né dei detergenti, considerando il loro contenuto “acido” che potrebbero rovinare i marmi, se non fossero puliti immediatamente.
Rimedi 2: Il marmo bianco - Preparare una soluzione di 1/2 tazza di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e tre cucchiai di succo di un limone. Applicate su tutta la superficie del marmo con una spugna umida. Lasciate agire per qualche ora e successivamente lavate il marmo con acqua e asciugate con un panno di cotone. Infine, applicate un velo di cera.
Rimedio 3:Macchie sul marmo - Per rimuovere le macchie, imbevete uno straccio con del perossido di idrogeno (acqua ossigenata al 3 per cento) strofinate con cura le macchie e lasciate riposare per un paio d’ore e poi risciacquate con un panno umido.
Alcune osservazioni utili.
Recenti pubblicazioni sostituiscono arbitrariamente, scambiandole, il trasporto delle misure effettuate per mezzo dei compassi, con quelle del pantografo o come esclusiva del triangolo di proporzione; e, riferite a quest'ultimo, dichiarano: “ che permette di considerare di volta in volta tre angoli o tre punti come i termini necessari per individuare il vertice di una piramide”. Ma non è così ! Il triangolo di proporzione “ permette “, esclusivamente, di riprodurre nella scala voluta il modello, operando poi, con il sistema delle triangolazioni e delle intersezioni. Il pantografo invece è utilizzato dallo smodellatore, per il trasporto dei punti dal modello al marmo e quando debba effettuarsi una statua di uguali dimensioni al modello, “ a ritratto “ o in scala da 1:1. Diversamente, come già osservato, è il metodo dei compassi, sia negli ingrandimenti sia nelle riduzioni, che prefigura per il trasporto di ogni punto, la piramide. La tecnica è completamente diversa dal pantografo. Pur lavorando sulle stesse figure geometriche solide, solo con i compassi, lo smodellatore, osserva la regola delle tre misure ( lunga, profondità e cala ) per individuare un piano ( un punto ) nello spazio, anche nel caso di un medesimo lavoro a ritratto. Nell'opera di smodellatura sono migliaia i punti necessari ad una buona riproduzione; è qui che, per ogni punto, si determina, prefigurandola, il vertice di una piramide a base triangolare. Lo scolpire è un concepire, individuandoli e metabolizzandoli, piani nello spazio.
Diversa è la copiatura di un disegno sul foglio, rappresentando, per mezzo delle intersezioni, delle figure geometriche piane, le cui linee e punti sono contenuti sullo stesso piano. Rammentiamo alcuni presupposti: a) per due punti passa una sola retta e da essa infiniti piani ; e per tre punti, non allineati, un solo piano. Proviamo ad immaginare una porta o sportello girevole i cui cardini coincidono con i due punti di una retta: il loro movimento è di 360°, in qualsiasi piano di proiezione verticale/orizzontale/obliqua, come individuiamo una loro posizione ( grado di apertura ) presente in una stanza, se non abbiamo una terza misura di riferimento?
Lo smodellatore, con l'ausilio dello sbozzatore, scandaglia il blocco, mettendo i primi punti guida ( capi-punto ), riportandoli dal modello, in maniera che possa realizzarsi la statua nelle volute dimensioni. Vi è sempre, nella partenza, un piano di riferimento, ottenuto con tre punti non allineati: due alla base, uno in cima alla testa della statua (argomento ampiamente trattato nelle tecniche di lavorazione ).
Vediamo come si opera con il pantografo.
Immaginiamo il blocco come se fosse un contenitore: una stanza è un esempio maggiorato del nostro parallelepipedo, c'è il piano del pavimento ed il soffitto, oltre le pareti; così, in maniera più appropriata e ridotta , una vasca da bagno lo è, se pensiamo ad un corpo che vi si immerge totalmente e sopra di esso si chiude il velo o il piano dell'acqua, come se fosse un tetto. Poiché nella riproduzione, il marmo deve poter contenere completamente la figura, si inizia individuando i piani del modello e del marmo, il detto velo dell'acqua, in modo che i tre punti di ciascuno lo rappresentino e formino, con la linea o piano dell'orizzonte, lo stesso angolo visuale ( a livello ). Si comprende facilmente che la nostra partenza utilizza il piano in alto del blocco per contenere tutte le forme della figura sottostante. I tre capi-punto non allineati, che indicano il piano, sono posti alla superficie, due alla base ed uno in cima alla testa della statua e del modello. Sopra di essi, adeguatamente combacianti, sono i tre puntali posti all'estremità della croce, che sono la base portante, e piano virtuale, di tutto l'apparecchio ( detto pantografo o macchinetta).
Le misure si prendono trasportandole dal modello al marmo, muovendo in blocco tutto lo strumento: dopo aver fissato - tramite un morsetto, al regolo verticale della croce, sempre all'altezza voluta - un altro regolo, alla cui estremità è innestata un'asta di ottone, che può muoversi sia in senso verticale che in senso orizzontale e sorreggere un braccio di ottone manovrabile in tutte le direzioni. Il braccio comprende una punta di acciaio scorrevole, che viene fermata quando tocca un preciso punto del modello, così si ricavano tutte le misure desiderate.
Inizia così lo scandaglio col fissare i punti principali, ricavando le larghezze, le altezze e le parti basse; poi lo smodellatore, lo scultore e tutte le altre figure proseguono l'opera. Talvolta è necessario abbassare i tre capi-punto del marmo, se quelli del modello – cioè il piano da loro prefigurato – lasciano sporgere fuori ( al di sopra ) gambe, braccia o altre parti della statua. L'intaglio e l'arte del levare è possibile quando c'è materiale, in dialetto “ roba”, per scolpire le parti esistenti nel modello. Ricordiamoci della vasca d'acqua, se un parte anatomica sporge fuori, è anche fuori dal blocco. Significa che ci siamo “mangiati” il lavoro.
Per sbiancare il marmo:
(1) Per renderlo nuovamente bianco creare un composto di 1 bicchiere d’acqua – 1 bicchiere di succo di limone – 1 cucchiaio di bicarbonato. Applicare sul marmo e con una spazzola a setole rigide (non di ferro), strofinare con cura, sciacquare con cura ogni gradino, prima di passare allo scalino successivo.
(2)Una volta finito, mettere del bicarbonato sui gradini di Marmo e bagnare (non in modo abbondante), così da fare una sorta di poltiglia, spalmarlo con uno straccio sui gradini e lascia agire per circa 15-20 minuti (il bicarbonato pulirà la porosità del marmo) successivamente sciacquare con cura e asciugare con uno straccio, possibilmente di lana.
Essendo un Marmo esterno, è consigliato ripetere la procedura del Bicarbonato (punto 2) almeno due volte al mese, così da tenere pulite le porosità del marmo, che sono le più difficili da pulire con una sola passata di straccio imbevuto in acqua e sapone di Marsiglia (utilizzare questa pulizia nelle settimane alterne a quella del Bicarbonato).Altri rimedi da provare per la Pulizia del Marmo:
Rimedio1: Pulizia generale marmo - l’acqua migliore per pulire il marmo è l’acqua distillata, con dell’aggiunta di sapone di Marsiglia. E’ consigliato non usare né l’aceto, né dei detergenti, considerando il loro contenuto “acido” che potrebbero rovinare i marmi, se non fossero puliti immediatamente.
Rimedi 2: Il marmo bianco - Preparare una soluzione di 1/2 tazza di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e tre cucchiai di succo di un limone. Applicate su tutta la superficie del marmo con una spugna umida. Lasciate agire per qualche ora e successivamente lavate il marmo con acqua e asciugate con un panno di cotone. Infine, applicate un velo di cera.
Rimedio 3:Macchie sul marmo - Per rimuovere le macchie, imbevete uno straccio con del perossido di idrogeno (acqua ossigenata al 3 per cento) strofinate con cura le macchie e lasciate riposare per un paio d’ore e poi risciacquate con un panno umido.
SCULTURA
1. Precisazioni
Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.
Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.
La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.
Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.
2. Precisazioni
ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.
Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.
Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.
CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:
Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:
1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.
2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio della similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.
Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.
Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile all'intero: a) semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze, statua cm 615 : 120 = 5,125 valore proporzionale. Cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ); b) prendendo una misura dal modello che, trasportata sul triangolo (arco tangente), sarà uguale a cm.138,375. Questa misura dovrà essere moltiplicata per 3, ripristinando la ripartizione precedente effettuata , quindi 138,375X3 ci darà, nuovamente, cm 415,125, che è la misurara da riportarsi sulla statua. Oppure, se desideriamo complicarci la vita, la misura cm 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 1.708333333 ( quoziente uguale ad un terzo di 5,125 ) . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.
Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:
3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.
Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.
Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri (uguale a mm. 20,5 ). Praticamente abbiamo diviso le altezze del modello ( cm. 120 ) e della statua ( cm615 ) per 300. Insomma è possibile dividere entrambi in parti uguali, segnandole su due righe diverse: è ovvio che non si fanno tutte le 30 suddivisioni; si segnano solo i segmenti strettamente indispensabili a costruire la scala di proporzione, riportando l'unità grafica nel rapporto voluto ( misure corrispondenti modello-statua ). Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), i quali saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri, non ci resta che rapportarli alla proporzione stabilita (mm.4 = 2,05 cm.). Nella gestione dei sottomultipli si suddividono ulteriormente i due tratti (segmenti) in dieci parti uguali, nel rapporto in scala scelto, e si determinano così per ogni tratto i sottomultipli dell'unità di misura di entrambi i segmenti corrispondenti. L'esempio detto, come riferimento alla scala ticonica, soddisfa, solo, conoscenze utilizzate, ma superate. Normalmente queste operazioni facilitano il lavoro iniziale; indi, si procedeva con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.
Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.
I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre (desideriamo strafare). Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:
Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.
SCULTURA
1. Precisazioni
Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.
Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.
La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.
Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.
2. Precisazioni
ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.
Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre, per il praticante, un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.
Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.
CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:
Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:
1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.
2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio ella similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.
Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.
Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze: statua cm 615 : 120 = 5,125 : cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ). Oppure, se desideriamo complicarci la vita cm 138,375x3 = 415.125 sempre da riportare sulla statua, dove 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 5,125 : 3, che è 1.708333333, uguale ad un terzo di 5,125 . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.
Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:
3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.
Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.
Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri. Insomma tutte queste unità di misura dovranno ma più le mentre il modello sopra o sotto il metro; è possibile dividere entrambi in 100 parti uguali, segnandole su due righe diverse. Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), dei quali una parte saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri non ci resta che moltiplicare ognuno per 2,05 cm. Normalmente queste queste operazioni presiedono il lavoro iniziale; indi, si opera con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.
Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.
I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre. Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:
Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.
SCULTURA
1. Precisazioni
Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.
Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.
La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.
Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.
2. Precisazioni
ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.
Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.
Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.
CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:
Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:
1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.
2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio ella similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.
Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.
Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze: statua cm 615 : 120 = 5,125 : cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ). Oppure, se desideriamo complicarci la vita cm 138,375x3 = 415.125 sempre da riportare sulla statua, dove 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 5,125 : 3, che è 1.708333333, uguale ad un terzo di 5,125 . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.
Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:
3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.
Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.
Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri. Insomma tutte queste unità di misura dovranno ma più le mentre il modello sopra o sotto il metro; è possibile dividere entrambi in 100 parti uguali, segnandole su due righe diverse. Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), dei quali una parte saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri non ci resta che moltiplicare ognuno per 2,05 cm. Normalmente queste queste operazioni presiedono il lavoro iniziale; indi, si opera con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.
Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.
I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre. Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:
Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.
1. Precisazioni
Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.
Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.
La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.
Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.
2. Precisazioni
ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.
Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.
Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.
CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:
Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:
1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.
2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio della similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.
Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.
Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile all'intero: a) semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze, statua cm 615 : 120 = 5,125 valore proporzionale. Cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ); b) prendendo una misura dal modello che, trasportata sul triangolo (arco tangente), sarà uguale a cm.138,375. Questa misura dovrà essere moltiplicata per 3, ripristinando la ripartizione precedente effettuata , quindi 138,375X3 ci darà, nuovamente, cm 415,125, che è la misurara da riportarsi sulla statua. Oppure, se desideriamo complicarci la vita, la misura cm 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 1.708333333 ( quoziente uguale ad un terzo di 5,125 ) . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.
Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:
3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.
Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.
Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri (uguale a mm. 20,5 ). Praticamente abbiamo diviso le altezze del modello ( cm. 120 ) e della statua ( cm615 ) per 300. Insomma è possibile dividere entrambi in parti uguali, segnandole su due righe diverse: è ovvio che non si fanno tutte le 30 suddivisioni; si segnano solo i segmenti strettamente indispensabili a costruire la scala di proporzione, riportando l'unità grafica nel rapporto voluto ( misure corrispondenti modello-statua ). Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), i quali saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri, non ci resta che rapportarli alla proporzione stabilita (mm.4 = 2,05 cm.). Nella gestione dei sottomultipli si suddividono ulteriormente i due tratti (segmenti) in dieci parti uguali, nel rapporto in scala scelto, e si determinano così per ogni tratto i sottomultipli dell'unità di misura di entrambi i segmenti corrispondenti. L'esempio detto, come riferimento alla scala ticonica, soddisfa, solo, conoscenze utilizzate, ma superate. Normalmente queste operazioni facilitano il lavoro iniziale; indi, si procedeva con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.
Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.
I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre (desideriamo strafare). Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:
Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.
SCULTURA
1. Precisazioni
Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.
Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.
La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.
Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.
2. Precisazioni
ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.
Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre, per il praticante, un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.
Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.
CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:
Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:
1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.
2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio ella similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.
Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.
Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze: statua cm 615 : 120 = 5,125 : cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ). Oppure, se desideriamo complicarci la vita cm 138,375x3 = 415.125 sempre da riportare sulla statua, dove 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 5,125 : 3, che è 1.708333333, uguale ad un terzo di 5,125 . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.
Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:
3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.
Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.
Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri. Insomma tutte queste unità di misura dovranno ma più le mentre il modello sopra o sotto il metro; è possibile dividere entrambi in 100 parti uguali, segnandole su due righe diverse. Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), dei quali una parte saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri non ci resta che moltiplicare ognuno per 2,05 cm. Normalmente queste queste operazioni presiedono il lavoro iniziale; indi, si opera con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.
Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.
I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre. Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:
Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.
SCULTURA
1. Precisazioni
Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.
Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.
La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.
Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.
2. Precisazioni
ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.
Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.
Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.
CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:
Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:
1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.
2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio ella similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.
Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.
Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze: statua cm 615 : 120 = 5,125 : cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ). Oppure, se desideriamo complicarci la vita cm 138,375x3 = 415.125 sempre da riportare sulla statua, dove 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 5,125 : 3, che è 1.708333333, uguale ad un terzo di 5,125 . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.
Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:
3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.
Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.
Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri. Insomma tutte queste unità di misura dovranno ma più le mentre il modello sopra o sotto il metro; è possibile dividere entrambi in 100 parti uguali, segnandole su due righe diverse. Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), dei quali una parte saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri non ci resta che moltiplicare ognuno per 2,05 cm. Normalmente queste queste operazioni presiedono il lavoro iniziale; indi, si opera con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.
Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.
I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre. Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:
Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.
IL MORTAIO UNA PRODUZIONE SCULTORIA
DELLE ALPI APUANE
La sua estetica e linguaggio visuale
Mortificante considerarla produzione umile ed utilitaria.
La lavorazione dei mortai, spesso considerata di scarsa professionalità comportava, al contrario, particolari doti tecniche ed una buona specializzazione. Almeno nei suoi impieghi artigianale/industriale, al di là dei singoli spartani che incrementavano la loro busta paga con un "gobet" , vedevano Carrara al centro delle maggiori produzioni e spedizioni, comprendendo tra i lavori speciali di marmo anche le tinozze da bagno. Certamente, il suo utilizzo si collocava, nell'ambito della cucina e della farmaceutica, ma ciò non poteva giustificare una produzione così massiccia, con misure e regole particolarissime. Dalla seconda metà dell'Ottocento, via via scemando fino alla scarsa produzione odierna, si assiste ad un suo utilizzo in architettura, nel designer, in particolari decorazioni di facciate, pavimenti e rivestimenti. A parte la particolare bellezza in sé, dovuta alla sua originale fattura, il mortaio, offre notevoli possibilità decorative: in una facciata ponendoli uno vicino all'altro, si possono comporre, ad incastro, varie figure geometriche, linee e forme che si alternano, in un gioco di pieni e vuoti (composizioni modulari) ; ma anche contrasto di colori, se si riempiono i mortai con un impasto di materiali pigmentati o disposti a mosaico. Altresì, si possono delinearsi processi di configurazione, osservando alternativamente ora una immagine, ora un'altra nello sfondo, adattandoli alla nostra esperienza ( ognuno vede ciò che sa'). Così, la percezione visiva del nostro mortaio in una composizione modulare su un piano, tende a completare la forma e a darle un significato, prediligendo alcune configurazioni su altre personalizzandole. Le cosiddette figure ambigue esemplificano questo aspetto: poiché la nostra attenzione può concentrarsi solo su una figura alla volta, selezionando quelle più semplici e definite, oppure per noi più significanti. Come percepiamo le immagini, ad esempio di fronte alla composizione di una balaustra, il nostro cervello seleziona immediatamente la plasticità e linearità delle colonnette oppure il disegno nello spazio vuoto tra esse?
Desideriamo, qui, dimostrare che il mortaio è un manufatto nobile e non artigianato minore come si suol dire. Insomma, non stiamo parlando del mortaio di discutibile fattura, riempito di acqua o di mangime e buttato nel pollaio dai nostri avi. Nossignori, stiamo parlando di un Re, che ha antenati illustri, misure commercialmente precise, con le quali viene nominato, sia riferite al palmo di Genova, sia al piede inglese, nella prassi mediamente di cm. 25 il primo e 30 il secondo. Entrambi appartenenti al sistema dodicesimale, divisibili per 12 e quindi cm.2 per l'oncia genovese, 2,5 cm. il pollice inglese. Così quando si dice del 10 del 12 del 16 e 22, si nomina un mortaio riferito a precise tabelle, esposte alla futura domanda della clientela. Un Re mortaio, che rispetto alle misure ed alla qualità del marmo, che sia duro e fresco, ha il suo peso ed il relativo prezzo. Le misure sono prese nel loro maggior diametro superiore, ma su l'orlo esterno, escluse le orecchie. Il mortaio, come la scultura, ha un proprio canone, che stabilisce le proporzioni tra le varie parti.
Un canone, la perfezione del bello ideale.
Solitamente, i mortai si ricavano da piccoli blocchetti tagliati e squadrati e nella misura desiderata. Se vogliamo agevolarci nel lavoro, il parallelepipedo ottimale ha un quadrato alla superficie, dove è possibile ricavare le dieci parti ( se comprendiamo anche le diagonali, con le orecchie; ma otto parti il lato del quadrato ). Lo stesso quadrato è alla base, anche se qui avremo una percentuale di sfrido, perché le parti, da ricavare, sono quattro; le altre facce hanno una altezza uguale a sei parti. Le misure canoniche sono le seguenti ( vedi disegno n° ).
La parte superiore è composta di 10 parti ( 1: 10 , come detto ) : di cui n ° 6 l'invaso, n° 1 + 1 il bordo esterno/interno delle circonferenze del mortaio; n° 1 + 1 sono due della quattro orecchie. La profondità dell'invaso è di 4 parti più un mezzo ( 4 + 1/2 ), mentre lo spessore della sua base ( il fondo ), è di parti 1 più un mezzo ( 1 + 1/2. Il diametro della circonferenza della base è di 4 parti, e la sua distanza dall'altra, diametralmente opposta, è di 6 parti, che corrisponde all'altezza del mortaio. Il sistema di calcolo è molto semplice: abbiamo detto che, usualmente, i mortai si fanno sulla misura richiesta ; per calcolare l'unità di misura è sufficiente dividere per otto, il maggior diametro superiore, preso sull'orlo esterno all'invaso, che corrisponde alla misura del lato del quadrato. Se poniamo il lato del quadrato è di cm. 12, l'unità di misura è di , 12: 8 = cm. 1,5 . Meno difficoltoso è partire da una unità di misura standard a piacere; ad esempio di cm. 2, di 2,5 o 3, e moltiplicarla con le parti indicate o adeguandole alla grandezza del marmo a disposizione.
Tecniche di lavorazione.
Si procede annerendo, con carboncino ed erba grassa, la parte superiore del mortaio. Abbiamo di fronte la prima faccia quadrata , tracciamo con il punteruolo le diagonali, poi, passando dal centro, nella sua esatta metà, il diametro. Su questo, dal centro, con la stessa apertura del compasso si indicano i punti 1 e 2, a piacere; indi, con centro in questi, con altre intersezioni ( 3 e 4 ), si alza l'altro diametro perpendicolare. Dal centro, con apertura del raggio pari a 3 parti ( diametro sei ), si disegna il cerchio dell'invaso. Dall'incrocio di questa circonferenza, con le perpendicolari ai lati ( diametri ortogonali ), si ricavano i punti 5 – 6 – 7 – 8 . Da questi, altre intersezioni uguali al raggio, si rettificano, meglio precisandole, le diagonali. Sempre dal centro, con raggio 4 parti, si traccia la circonferenza dell'orlo esterno. Le intersezioni 5 – 6 – 7 – 8 sono necessarie per puntare il compasso alla unità di misura indicata e disegnare le orecchie.
Sui lati del nostro quadrato rimangono i punti di incontro delle diagonali e dei diametri, da tutti questi, manovrando con il compasso, si cerca il centro del quadrato alla base, speculare all'altro in alto. Da qui, con apertura di raggio 2 parti, si segna il cerchio di fondo. Il nostro mortaio è disegnato e visto come se fosse in pianta : con la gradina e con lo scalpello, contorniamolo, ricavando dall'inciso, un intaglio di almeno due centimetri, dopo di che si comincia a scolpire il tutto. Un primo accorgimento è quello di mettere il mortaio in una morsa, appoggiato su uno di lati minori, in costa. Il secondo, è quello di eseguire delle tracce, a mo' di linee guida, che iniziano dall'attacco delle orecchie sulla circonferenza esterna e proseguono, le tracce, fino ad incontrare la circonferenza alla base. Si tenga conto della rastremazione voluta, quando si inizia ad unire le due basi, per dare forma ad un solido molto simile ad un tronco di cono. Se non si è già provveduto prima, a svuotare il catino, intagliato nel bordo interno, lo si può fare in corso d'opera, dopo aver abbozzato il lavoro e prima della definitiva rifinitura.
Dall'estetica al linguaggio visuale.
Nella scultura, il segno, è una diretta emanazione dell'uomo, non è la parola, lo scritto, il gesto convenzionale : è una sfida con la materia, una lotta. Il togliere, l'incidere, il trattare in un certo modo le superfici, esposte al gioco della luce e dello spazio, sono l'affermarsi di una tensione tra l'uomo e la materia, sperimentando nuovi ed avveniristici linguaggi. La texture, anche nel mortaio è importante: certe incisioni, porosità, grumi incerti, fatti con la subbia, la gradina, l'ugnetto o lo scalpello, sono passaggi dove la luce esprime tanti modi diversi di essere e di comunicare della materia, non solo estetici. Perciò spesso viene impreziosito con piccole figure in bassorilievo, motivi ornamentali, anche in una certa fattura delle orecchie. Perché così lo viviamo e sentiamo, a dispetto di molti che lo considerano solo in termini utilitaristici : “ ma in fondo in fondo, non è altro che un'utensile da cucina”. No è molto di più.
Un oggetto piace per se' stesso, per le sensazioni gradevoli che suscita in noi, alla vista e al tatto. Sicché, la sua armonia anima in noi ricordi piacevoli: le emozioni vissute, la memoria di abitudini a noi care, familiari, un sentimento composto di usi e tradizioni. Insomma nello oggetto noi amiamo tutto ciò che vi abbiamo messo di noi: archetipi che corrispondono alla nostra esperienza, a processi di sviluppo e di adattamento all'ambiente, alle motivazioni percepite ed a ciò che avviene intorno a noi e nel mondo. Il mortaio, con il suo pestello, più o meno rudimentale, è una delle forme più antiche usate dall'uomo.
" Perciò la fascinazione artigianale deriva dal fatto che è passato dall'intelligenza delle mani di qualcuno, che vi ha lasciato il suo particolare segno con il suo lavoro e la sua sensibile passionalità, e lo ha stigmatizzato con un oggetto originale e irripetibile. E' la fascinazione di ciò che si è creato, di quel pezzo unico in un momento unico".
Apprendiamo da queste eccellenze, l'unitarietà dei pregi che il marmo accoglie nel suo grembo, giacchè la sua materia contiene in se e per sé quel germe sublime che ogni buon artista sa' trovare con l'opera sua.
A volte mi sorprendo ad osservare vecchie lavorazioni, vestigia del passato, e comincio a fantasticare. E... quella pattina giallognola che il marmo assume con il tempo, più nei luoghi chiusi, mi estranea dal momento reale. A tal punto che più non vedo, mentre mi sorprendo ad ascoltare quel passaggio dei ferri nella materia e il particolare suono materico che ognuno di essi produce; ecco! Ora la gradina scorre velocemente, a momenti spunta piccole impuntature, modesti lasciti di materia in piccolissime gobbe (le tocco con la mano). Sono modeste vibrazioni, quasi a rappresentare lo stato d'animo dell'artista: tal volta leggero e franco talatra stanco. Avverto che la mano deve essere rilassata e ferma quasi ad incontrare la dolcezza del verso, per un ottimo impasto; altrimenti l'impeto e l'ostinazione incontrano durezza nell'eccessivo prender di petto. Così si snoda un percorso della lavorazione che dev'essere unitario e ritmato nei modi, molto più a scorrere che a zappare, se desideriamo la materia più arrendevole e morbida nella musicalità dei toni. Così lo scalpello dal taglio dritto ed affilato traccia già i primi percorsi, parallelamente allineati, lungo il piano; dianzi pregustando lo sfigolio del raschietto sulle gobbe o rigature tra una corsa e l'altra.
DELLE ALPI APUANE
La sua estetica e linguaggio visuale
Mortificante considerarla produzione umile ed utilitaria.
La lavorazione dei mortai, spesso considerata di scarsa professionalità comportava, al contrario, particolari doti tecniche ed una buona specializzazione. Almeno nei suoi impieghi artigianale/industriale, al di là dei singoli spartani che incrementavano la loro busta paga con un "gobet" , vedevano Carrara al centro delle maggiori produzioni e spedizioni, comprendendo tra i lavori speciali di marmo anche le tinozze da bagno. Certamente, il suo utilizzo si collocava, nell'ambito della cucina e della farmaceutica, ma ciò non poteva giustificare una produzione così massiccia, con misure e regole particolarissime. Dalla seconda metà dell'Ottocento, via via scemando fino alla scarsa produzione odierna, si assiste ad un suo utilizzo in architettura, nel designer, in particolari decorazioni di facciate, pavimenti e rivestimenti. A parte la particolare bellezza in sé, dovuta alla sua originale fattura, il mortaio, offre notevoli possibilità decorative: in una facciata ponendoli uno vicino all'altro, si possono comporre, ad incastro, varie figure geometriche, linee e forme che si alternano, in un gioco di pieni e vuoti (composizioni modulari) ; ma anche contrasto di colori, se si riempiono i mortai con un impasto di materiali pigmentati o disposti a mosaico. Altresì, si possono delinearsi processi di configurazione, osservando alternativamente ora una immagine, ora un'altra nello sfondo, adattandoli alla nostra esperienza ( ognuno vede ciò che sa'). Così, la percezione visiva del nostro mortaio in una composizione modulare su un piano, tende a completare la forma e a darle un significato, prediligendo alcune configurazioni su altre personalizzandole. Le cosiddette figure ambigue esemplificano questo aspetto: poiché la nostra attenzione può concentrarsi solo su una figura alla volta, selezionando quelle più semplici e definite, oppure per noi più significanti. Come percepiamo le immagini, ad esempio di fronte alla composizione di una balaustra, il nostro cervello seleziona immediatamente la plasticità e linearità delle colonnette oppure il disegno nello spazio vuoto tra esse?
Desideriamo, qui, dimostrare che il mortaio è un manufatto nobile e non artigianato minore come si suol dire. Insomma, non stiamo parlando del mortaio di discutibile fattura, riempito di acqua o di mangime e buttato nel pollaio dai nostri avi. Nossignori, stiamo parlando di un Re, che ha antenati illustri, misure commercialmente precise, con le quali viene nominato, sia riferite al palmo di Genova, sia al piede inglese, nella prassi mediamente di cm. 25 il primo e 30 il secondo. Entrambi appartenenti al sistema dodicesimale, divisibili per 12 e quindi cm.2 per l'oncia genovese, 2,5 cm. il pollice inglese. Così quando si dice del 10 del 12 del 16 e 22, si nomina un mortaio riferito a precise tabelle, esposte alla futura domanda della clientela. Un Re mortaio, che rispetto alle misure ed alla qualità del marmo, che sia duro e fresco, ha il suo peso ed il relativo prezzo. Le misure sono prese nel loro maggior diametro superiore, ma su l'orlo esterno, escluse le orecchie. Il mortaio, come la scultura, ha un proprio canone, che stabilisce le proporzioni tra le varie parti.
Un canone, la perfezione del bello ideale.
Solitamente, i mortai si ricavano da piccoli blocchetti tagliati e squadrati e nella misura desiderata. Se vogliamo agevolarci nel lavoro, il parallelepipedo ottimale ha un quadrato alla superficie, dove è possibile ricavare le dieci parti ( se comprendiamo anche le diagonali, con le orecchie; ma otto parti il lato del quadrato ). Lo stesso quadrato è alla base, anche se qui avremo una percentuale di sfrido, perché le parti, da ricavare, sono quattro; le altre facce hanno una altezza uguale a sei parti. Le misure canoniche sono le seguenti ( vedi disegno n° ).
La parte superiore è composta di 10 parti ( 1: 10 , come detto ) : di cui n ° 6 l'invaso, n° 1 + 1 il bordo esterno/interno delle circonferenze del mortaio; n° 1 + 1 sono due della quattro orecchie. La profondità dell'invaso è di 4 parti più un mezzo ( 4 + 1/2 ), mentre lo spessore della sua base ( il fondo ), è di parti 1 più un mezzo ( 1 + 1/2. Il diametro della circonferenza della base è di 4 parti, e la sua distanza dall'altra, diametralmente opposta, è di 6 parti, che corrisponde all'altezza del mortaio. Il sistema di calcolo è molto semplice: abbiamo detto che, usualmente, i mortai si fanno sulla misura richiesta ; per calcolare l'unità di misura è sufficiente dividere per otto, il maggior diametro superiore, preso sull'orlo esterno all'invaso, che corrisponde alla misura del lato del quadrato. Se poniamo il lato del quadrato è di cm. 12, l'unità di misura è di , 12: 8 = cm. 1,5 . Meno difficoltoso è partire da una unità di misura standard a piacere; ad esempio di cm. 2, di 2,5 o 3, e moltiplicarla con le parti indicate o adeguandole alla grandezza del marmo a disposizione.
Tecniche di lavorazione.
Si procede annerendo, con carboncino ed erba grassa, la parte superiore del mortaio. Abbiamo di fronte la prima faccia quadrata , tracciamo con il punteruolo le diagonali, poi, passando dal centro, nella sua esatta metà, il diametro. Su questo, dal centro, con la stessa apertura del compasso si indicano i punti 1 e 2, a piacere; indi, con centro in questi, con altre intersezioni ( 3 e 4 ), si alza l'altro diametro perpendicolare. Dal centro, con apertura del raggio pari a 3 parti ( diametro sei ), si disegna il cerchio dell'invaso. Dall'incrocio di questa circonferenza, con le perpendicolari ai lati ( diametri ortogonali ), si ricavano i punti 5 – 6 – 7 – 8 . Da questi, altre intersezioni uguali al raggio, si rettificano, meglio precisandole, le diagonali. Sempre dal centro, con raggio 4 parti, si traccia la circonferenza dell'orlo esterno. Le intersezioni 5 – 6 – 7 – 8 sono necessarie per puntare il compasso alla unità di misura indicata e disegnare le orecchie.
Sui lati del nostro quadrato rimangono i punti di incontro delle diagonali e dei diametri, da tutti questi, manovrando con il compasso, si cerca il centro del quadrato alla base, speculare all'altro in alto. Da qui, con apertura di raggio 2 parti, si segna il cerchio di fondo. Il nostro mortaio è disegnato e visto come se fosse in pianta : con la gradina e con lo scalpello, contorniamolo, ricavando dall'inciso, un intaglio di almeno due centimetri, dopo di che si comincia a scolpire il tutto. Un primo accorgimento è quello di mettere il mortaio in una morsa, appoggiato su uno di lati minori, in costa. Il secondo, è quello di eseguire delle tracce, a mo' di linee guida, che iniziano dall'attacco delle orecchie sulla circonferenza esterna e proseguono, le tracce, fino ad incontrare la circonferenza alla base. Si tenga conto della rastremazione voluta, quando si inizia ad unire le due basi, per dare forma ad un solido molto simile ad un tronco di cono. Se non si è già provveduto prima, a svuotare il catino, intagliato nel bordo interno, lo si può fare in corso d'opera, dopo aver abbozzato il lavoro e prima della definitiva rifinitura.
Dall'estetica al linguaggio visuale.
Nella scultura, il segno, è una diretta emanazione dell'uomo, non è la parola, lo scritto, il gesto convenzionale : è una sfida con la materia, una lotta. Il togliere, l'incidere, il trattare in un certo modo le superfici, esposte al gioco della luce e dello spazio, sono l'affermarsi di una tensione tra l'uomo e la materia, sperimentando nuovi ed avveniristici linguaggi. La texture, anche nel mortaio è importante: certe incisioni, porosità, grumi incerti, fatti con la subbia, la gradina, l'ugnetto o lo scalpello, sono passaggi dove la luce esprime tanti modi diversi di essere e di comunicare della materia, non solo estetici. Perciò spesso viene impreziosito con piccole figure in bassorilievo, motivi ornamentali, anche in una certa fattura delle orecchie. Perché così lo viviamo e sentiamo, a dispetto di molti che lo considerano solo in termini utilitaristici : “ ma in fondo in fondo, non è altro che un'utensile da cucina”. No è molto di più.
Un oggetto piace per se' stesso, per le sensazioni gradevoli che suscita in noi, alla vista e al tatto. Sicché, la sua armonia anima in noi ricordi piacevoli: le emozioni vissute, la memoria di abitudini a noi care, familiari, un sentimento composto di usi e tradizioni. Insomma nello oggetto noi amiamo tutto ciò che vi abbiamo messo di noi: archetipi che corrispondono alla nostra esperienza, a processi di sviluppo e di adattamento all'ambiente, alle motivazioni percepite ed a ciò che avviene intorno a noi e nel mondo. Il mortaio, con il suo pestello, più o meno rudimentale, è una delle forme più antiche usate dall'uomo.
" Perciò la fascinazione artigianale deriva dal fatto che è passato dall'intelligenza delle mani di qualcuno, che vi ha lasciato il suo particolare segno con il suo lavoro e la sua sensibile passionalità, e lo ha stigmatizzato con un oggetto originale e irripetibile. E' la fascinazione di ciò che si è creato, di quel pezzo unico in un momento unico".
Apprendiamo da queste eccellenze, l'unitarietà dei pregi che il marmo accoglie nel suo grembo, giacchè la sua materia contiene in se e per sé quel germe sublime che ogni buon artista sa' trovare con l'opera sua.
A volte mi sorprendo ad osservare vecchie lavorazioni, vestigia del passato, e comincio a fantasticare. E... quella pattina giallognola che il marmo assume con il tempo, più nei luoghi chiusi, mi estranea dal momento reale. A tal punto che più non vedo, mentre mi sorprendo ad ascoltare quel passaggio dei ferri nella materia e il particolare suono materico che ognuno di essi produce; ecco! Ora la gradina scorre velocemente, a momenti spunta piccole impuntature, modesti lasciti di materia in piccolissime gobbe (le tocco con la mano). Sono modeste vibrazioni, quasi a rappresentare lo stato d'animo dell'artista: tal volta leggero e franco talatra stanco. Avverto che la mano deve essere rilassata e ferma quasi ad incontrare la dolcezza del verso, per un ottimo impasto; altrimenti l'impeto e l'ostinazione incontrano durezza nell'eccessivo prender di petto. Così si snoda un percorso della lavorazione che dev'essere unitario e ritmato nei modi, molto più a scorrere che a zappare, se desideriamo la materia più arrendevole e morbida nella musicalità dei toni. Così lo scalpello dal taglio dritto ed affilato traccia già i primi percorsi, parallelamente allineati, lungo il piano; dianzi pregustando lo sfigolio del raschietto sulle gobbe o rigature tra una corsa e l'altra.
lunedì 17 gennaio 2011
TECNICHE DEL TELAIO E AFFINI
Abbiamo un piano di appoggio a terra, costituito da un banco di lavoro idoneo : il tutto è formato da supporti di travicelli o casse in legno ( tipico nei laboratori ). Su uno di essi è adagiato il blocco; mentre il modello, solitamente, viene fissato ad una lastra di appoggio, posta su un altro banco da lavoro adeguato. I due soggetti, marmo e modello, sono sottoposti ad una propria livellatura e traguardati; poi, si debbono posizionare, frontalmente ed opposti, i due telai del modello e i due del blocco, in maniera tale che possano coprire in lunghezza e larghezza le dimensioni di entrambi questi ultimi ( la loro area e volume ).
Per dare un'idea del lavoro preparatorio, immaginiamo due letti, ad una piazza come i nostri di casa: l'uno, normalmente più piccolo, contenente il modello, l'altro, la statua. Ognuna di queste figure giacenti sul proprio letto, sul suo piano, a livello delle lenzuola, come se fossero delle persone. Ogni letto che si rispetti ha anche, da capo a piedi, le sue due sponde, poste frontalmente. Queste, per ogni soggetto menzionato ( i telai ), dobbiamo prefigurarle predisposte in scala di proporzione; e, sempre sul filo dell'immaginazione, pensarle livellate ognuna da un proprio piano virtuale, passante per i bordi estremi delle sponde, che le collega e si predispone parallelamente al piano geometrale ( o di terra ).Così raffiguriamo nella nostra mente dei parallelepipedi ( quello del marmo lo è realmente ), posti l'uno accanto all'altro ed ognuno con le proprie dimensioni atte a contenere sia quelle del modello sia quelle del marmo. Abbiamo descritto, contemporaneamente, anche lo stesso posizionamento dei telai, prefigurando con ciò il perimetro circostante al modello ed al blocco. Proseguiamo nella posa in opera, segnando sulle traverse ( secondo la dimensione dei telai ) tante suddivisioni uguali - ad imitazione delle tacche, simili, presenti nell'asta di ogni stadera - purché ognuna delle quali corrisponda all'unità grafica del rapporto designato, cioè conforme alle grandezze in scala della statua e del modello. Si auspica sempre l'impiego, come traversa ( detta anche cornice ), di una riga in legno spessa e con un profilo perfetto e non alterabile. Siccome ciò che è desiderabile non sempre è dato, si consiglia di fare molta attenzione nel segnare le tacche previste nelle cornici. Susseguentemente, sempre sulle stesse, si traccia, per tutta la lunghezza delle tacche, una linea che le incrocia a 90 gradi, all'incirca nella mezzeria della faccia alta di ogni traversa. Linea detta perimetrale perchè delimita il campo di lavoro. ( Un tempo si incidevano le tacche anche sui laterali dei telai per individuare meglio i piani ed i livelli della scultura, semplicemente posando la cordicella sui fermi, indispensabili, delle aste verticali; ricordiamoci dei livelli della nota " vasca d'acqua " di Michelangelo ). Quelle due linee perimetrali, nei diversi telai - modello e blocco - le chiameremo, arbitrariamente, d'orizzonte, poiché dovranno essere, tra loro, perfettamente parallele e traguardate. E' altresì importante che i piani sia del modello, sia della statua e conseguentemente dei telai, formino coll'orizzonte lo stesso angolo visuale. A questo punto, si prende una cordicella sufficientemente lunga, con all'estremità due pesi adeguati e la si appoggia sulle tacche, quasi a rappresentarne il loro prolungamento - prima su un lato delle traverse, poi sull'altro - a coprire tutta la distanza dei telai: non è complicato, le parti incise sulla cornice ben traguardate e numerate sono in sincronia, mentre i telai sono uno di fronte all'altro: si tratta di porre la corda sulle stesse tacche prospicienti collegandole. Poichè portano lo stesso numero in entrambi i lati dei telai, si segna la corda, con un pennarello, laddove incrociano con le linee d'orizzonte. Va da sè che a misure uguali, prese quasi all'estremità dei due lati, corrisponda una perfetta posizione parallela dei telai e delle linee d'orizzonte contenute. Predisposto ciò si murano definitivamente i telai, cementandone i piedi. LA PARTENZA è IMPORTANTISSIMA; lo smodellatore scandaglia il blocco, per vedere se vi può uscire la statua nelle volute proporzioni; assesta l'insieme del lavoro riportandone i punti principali dal modello. Soprattutto si prendono, dalla cordicella, le cale, in modo che le distanze dei piani del modello e del marmo siano uniformemente proporzionali alla proporzione generale fra modello e statua da eseguirsi. Questo è il momento più delicato: è consigliabile partire dalle due tacche mediane dei due telai, nel punto laddove incrociano con le linee d'orizzonte (es. se le tacche sono 10, il compasso è aperto sui numeri 5 dei due telai ). Si mette mano, immediatamente, al trasporto dei punti principali già fissati sul modello: il riporto inizia da quelli collocati circa alla metà; l'uno sul fianco destro, l'altro sul fianco sinistro. Da qui partono le prime intersezioni ( tre ). Con apertura di compasso uguale alla distanza del primo punto laterale dalle tacche, si effettuano le prime intersezioni ( due più la cala dalla cordicella sovrastante, che sarà perpendicolare al punto ); poi si provvede a riportare l'altro, con identica operazione. I due punti rappresentanto gli estremi laterali, che utilizzeremo per traportare i capi-punto situati uno alla testa e l'altro ai piedi del modello, per facilitarci le intersezioni delle misure lunghe sul piano. In questo modo si è anche cominciato ad individuare i vari campi di lavoro. Altri capi-punto strategici possono essere individuati per migliorare la geometria dei campi necessari ad un fedele trasporto dei punti. Fatte queste prime operazioni, si possono escludere le misure dei compassi dalle tacche, passando la direzione della manovra ai capi-punto del modello e della statua da eseguirsi, ad eccezione delle cale. ( Come già accennato le cale son state CALIBRATE; spieghiamolo meglio : dalla cordicella, sul modello, si sono prese le misure a quelle parti della figura che spiccano in alto o sottostanti, più basse, con queste si valutano i riporti sul marmo, calibrandone le cale, affinché tutte le distanze risultino perfettamente proporzionali. Semplicemente: il piano più basso e quello più alto del modello, debbono corrispondere, proporzionalmente, a quegli stessi da eseguirsi nella figura, che sono poi il riporto dei punti necessari a riprodurre la statua che il blocco deve poter contenere).
RIEPILOGHIAMO:
Tutti possono valutare le tante difficoltà di comprensione: un conto è l'esperienza pratica, un conto la teoria. Proviamo con un altro tentativo di semplificazione. Sarà puerile dirlo, ma abbiamo delineato un recinto delimitato dalle proiezioni congiunte e frontali dei telai, come se fossero le due porte di un campo di calcetto, collegate a confini ben delineati (con perimetro rettangolare). Lo abbiamo fatto in alto ed in basso: sopra di noi a livello delle traverse una rete di fili si prefigura, similmente ai vecchi telai nelle tessiture, considerato che spostiamo, spesso a tutto campo, la cordicella, ogni qual volta prendiamo una misura. E' proprio da questi fili che si ottengono le “ cale” , misure importanti per individuare, perpendicolarmente, un punto nella figura di un solido. Abbiamo simboleggiato, ancora una volta in maniera esageratamente grande, un parallelepipedo. Un campo sportivo non potrà mai essere un blocco; ma uscendo dall'immaginario, la sostanza è una sola: il marmo deve poter contenere congruamente il modello. Ritorniamo alla realtà, quella all'interno dello spazio sopra i banchi di lavoro, dove giacciono il modello e la sua riproduzione, ognuno con il proprio telaio nel rapporto voluto. Resta l'idea di un sistema operativo che ci ricorda l'uso delle squadre o delle cornici, con le loro divisioni in tutto il perimetro e dei corrispondenti fili a piombo. Ricordiamolo, queste, sono squadre fissate alla parete, ad angolo retto, e poste sopra la testa delle figure erette, sia del modello sia della statua per ricavarne le profondità. Qui, le misure si prendono prendendo dal filo di una cordicella tesa a piombo e mobile nel perimetro delle squadre. Nel sistema che descriviamo e che più correttamente chiamiamo del telaio, l'esecuzione è più precisa. Intanto perché il telaio ha proiezioni simili a quelle ortogonali al piano ( cale ). Non dimentichiamoci che la cordicella percorre tutte le tacche linearmente dal 1-1' o dal 2-2' e così via; ma può farlo anche di sbieco, da 1 al 10', mettendo in relazione compositiva, diagonalmente, parti da riprodurre. Infatti, il telaio, domina tutta l'area come se si sovrapponesse, visto dall'alto, ad un elaborato riprodotto in pianta; eppoi se la distanza dei telai tra loro non è molta, si può anche alternare la corda a piombo, con robusto ed inflessibile righello. E', inoltre, facilitato il riporto per la posizione più stabile della corda, che consente meglio l'apertura dei compassi tra essa ed il manufatto in questione, per la possibilità di essere a “ piombo “ sul lavoro; poi, di poter valutare, anche con i laterali del telaio, le sporgenze ed i rientri della figura, riportando una corda tesa su alcune tacche predisposte nei fianchi dello stesso. Si è da più parti, indicato l'esperimento di Michelangelo, con l'immersione di un modellino in una vasca d'acqua, lo rapportiamo all'esempio dianzi fatto, quello dell'estensione del filo laterale, poiché questi si pone sulla medesima traccia del livello dell'acqua: che è un livello sugli scorci dei piani che la figura, vista di profilo, staglia, quando il fantomatico pelo dell'acqua si alza o si abbassa.
PARTENZE ALTERNATIVE:
Dalle traverse dei telai, sia nel modello, sia nel marmo, nella mezzeria che fa' capo alle tacche (se sono 10 la mezzeria passa dal n. 5 al 5' opposto) all'incrocio con la menzionata "linea d'orizzonte", lo smodellatore utilizza i punti di incrocio anzidetti, come se fossero due capi punto di partenza, da questi, per mezzo delle intersezioni, segna altri capi-punto strategici, a destra ed a sinistra del modello e del marmo, poi passa allo scandaglio dei punti più rilevanti della figura, adeguandoli alle misure del blocco; altresì rileva le altezze più basse della statua, affinché sia congruamente contenuta nel blocco. In questa operazione, alzando o abbassando le cale, calibrandole perfettamente al riporto delle misure, dal modello alla statua, sia dei capi-punto, sia, nel proseguo, di tutti gli altri punti necessari, si adeguano tutti i corrispondenti piani, comprese le sporgenze. Poi si può passare, come già detto, la direzione delle lunghe direttamente dal modello al marmo; inalterate le cale.
E' possibile, fattibile, prescindere dal telaio sovrastante e procedere autonomamente, poiché questo piano, con la cordicella mobile sulle tacche, copre ampiamente lo spazio dove è collocato il lavoro? Abbiamo dianzi affermato che i telai sono sovrapposti al modello e al blocco, che fissano, su di loro, un perimetro di copertura, come se fossero due tetti nella voluta proporzione in scala. L'unico problema consiste nel posizionamento dei loro due soggetti sottostanti, che sono sì indipendenti, ma conservano una stretta relazione. La prima banale, il blocco deve poter contenere perfettamente il modello, praticando tutte quelle operazioni preliminari che abbiamo precedentemente detto. La seconda, si fissano i punti principali considerando che le linee delle cale, longitundinali all'elaborato, debbono avere assetti comuni, proporzionalmente dati. Quindi si può iniziare nello stesso modo di altre tecniche, più volte descritte. Si parte dai punti principali 1 e 2, riportati dal modello sul blocco per mezzo delle intersezioni, che segnano in lunghezza anche le linee di mezzeria, nella stessa posizione,il marmo e il modello. Queste linee debbono coincidere con la stessa linea di mezzo dei telai e confermate dalle successive cale. Cosicchè tutti i tre punti necessari saranno organici e nell'insieme a tutti quegli altri che verranno, utilizzando un vantaggioso sistema comune. Al riguardo, restano fermamente confermate le corrispondenze proporzionali, quelle della distanza dei telai dai piani del modello e della statua da eseguirsi.
TELAIO : ALTRE TECNICHE
Bassorilievi e Altorilievi
Questa applicazione del telaio può essere fatta prefigurando un impianto più modesto per i bassorilievi e altorilievi, mantenendo inalterate tutte le applicazioni e regole che riguardano l'uso del triangolo di proporzione. In tal caso i telai sono alzati sul piano di marmo e sul modello: sono lastre di circa 3 o più cm di spessore e di lunghezza uguale ai piani di posa del lavoro; la loro altezza, rispetto al maggior picco verticale del modello, deve poterlo superare da 6 a 10 cm, presi dal suo punto più rilevante. Ciò per utilizzare, i compassi, in maniera più precisa e di aprirli nel modo più consono al trasporto delle cale. I piani di partenza sono importanti. Dire che il piano del marmo deve occupare nello spazio la stessa inclinazione del modello o lo stesso angolo con la linea dell'orizzontale, non è sufficientemente chiaro. La migliore illustrazione si ha facendo un semplice calcolo: il piano del telaio del modello è, poniamo, di cm 6 e l'ingrandimento previsto è il doppio: Posso alzare il piano del marmo di 13 o più cm? No, perché escluderei la parti più rilevanti del modello. L'altezza delle lastre di questo telaio potrebbe essere 12 ( esattamente il doppio ), e partire “ fatti “. Meglio allora alzare a cm. 11,50, per avere la disponibilità minima di marmo ( roba ), per segnare il punto o capo-punto.
Si procede incidendo sulle coste o spessori delle lastre le tacche, partendo dalla mezzeria, così pure, come sulle linee dette di orizzonte che le incrociano si fissano, agli estremi della linea di mezzo, i due capi-punto; il tutto, nel mantenimento del rapporto proporzionale generale. Da questi primi due capi-punto, nella mezzeria, se ne fissano altri strategici, a destra e a sinistra, per poter tempestare di punti la statua onde farla emergere. Si lavora su piani precostituiti, c'è una qualche attinenza con le intersezioni che operano sul foglio da disegno, perché il bassorilievo non ha le dimensioni di una figura a tutto tondo, perciò occorre far molta attenzione all'impostazione del lavoro portando su di esso misure precise. Sull'impostazione, una volta che si è avviata l'opera con i capi-punto della mezzeria, il telaio si utilizza solo per le cale, osservando un modulo unico. Si può sbagliare, con un sistema misto di misure: lunghe e profondità prese, un po' dalle tacche, un po' dai punti sul piano.
UNA DIVERSA IMPOSTAZIONE DEL TELAIO.
I TELAI, se lo spazio nel laboratorio è scarso, possono essere posizionati in un altro modo da quello precedentemente descritto, facendo ricorso ad un sistema misto: mentre il telaio sovrastante il blocco rimane fisso a terra, quello del modello può essere posizionato, in piedi, aderente alla parete più prossima. A questa, e sopra la testa della statua, è fissata, alla parete, una squadra o cornice, che pur mantenendo la stessa proporzione, rispetto al rapporto di grandezza stabilita con il telaio, è parte di un sistema detto delle gabbie.
Con ciò necessitiamo di ulteriori delucidazioni, mai troppe ed inopportune.
COME SI PUO' INDIVIDUARE UN PIANO NELLO SPAZIO.
A) Ricordiamoci che ci stiamo occupando delle figure solide, i cui punti non giacciono tutti sullo stesso piano ( ogni piano divide lo spazio, semispazi,ognuno dei quali contiene infiniti punti ). B) Concetto di piano si intuisce ma non si definisce; sono facilmente intuibili i seguenti postulati: 1) un solo piano nello spazio può essere determinato, tra gli altri, per tre punti non allineati. 2) Per due punti A e B di una retta passano infiniti piani, ma uno solo di questi passa per un punto P, assegnato, non appartenente alla retta. E' lo stesso principio " della piramide a base triangolare", per trovare il suo vertice occorre riferirsi almeno ad altri tre punti non allineati.
C) INTERSEZIONE: L'intersezione di due figure è la parte che hanno in comune: perciò una retta che non appartiene in alcun modo ad un piano, ma lo interseca, ha solo un punto in comune con esso.
IL PRINCIPIO DI B. CAVALIERI.
Il principio di Cavalieri pensa che " un solido si può considerare formato da tante lamine sottilissime sovrapposte: due solidi uguali o diversi, ma formati dallo stesso numero di lamine, dello stesso spessore, con superfici equivalente, essi avranno la stessa estensione. L'enunciato: " dati due solidi, se è possibile disporli, rispetto ad un piano, in modo che ogni piano parallelo a questo li tagli secondo sezioni equivalenti, i due solidi sono equivalenti ".
Questa teoria la valutiamo diversamente, nella stessa visione che tutti i corpi hanno una loro estensione solida (occupano una parte di spazio ) e sono racchiusi da poligoni o figure piane di diversa dimensione. Più che al risultato della equivalenza ( prismi aventi altezze uguale e basi equivalenti avranno la stessa estensione ); il nostro obiettivo, solitamente, è quello della similitudine: esclusivamente di uguale forma. La consideriamo diversamente perchè il nostro modello, indipendentemente dalla postura e dal suo rapporto in scala, lo immaginiamo imprigionato in un parallelepipedo, che è la sua riproduzione nel blocco di marmo. Noi siamo interessati alla manualità del levare il superfluo, per copiare il modello, partendo dal'unicità del punto di vista frontale. Si inizia predisponendo l'intaglio dal piano alto, e mano mano, scoprendo le parti più sporgenti, si scende fino alle rotondità posteriori del piano di base. Il lavoro viene affrontato frontalmente, ma contemporaneamente, si opera anche sul profilo della statua per mantenerne i contorni e la giusta postura, secondo le proporzioni stabilite e mantenendo l'organicità della composizione.
1.RIPRODUZIONE DI SCULTURE PER MEZZO DEL TRASPORTO DEI PUNTI. 2.INTAGLIO DIRETTO ( "COSIDDETTO AD OCCHIO" ).
Di solito con il bozzetto si fissano le prime intuizioni, precedute da uno studio comprendente diversi disegni di approccio. Fissata l'idea si procede con la realizzazione del modello in creta e susseguentemente si getta in gesso con il metodo della forma persa ( raramente si formano gessi di grandi dimensione ). Si è perduta la tradizione del CANOVA di modelli o monumenti grandi al vero, che offrivano il vantaggio di valutare tutte le incidenze: luce, proporzioni, linguaggio della postura; concorrenza dei volumi e vuoti, linearità. Il ricorso a piccoli modelli è la norma, poi si affida l'opera a maestranze esperte. E' possibile che l'artista intervenga, con l'ultima mano. La presenza del modello, da tradurre nelle proporzioni stabilite, oltre ad una visione generale e particolare, offre anche la possibilità di trasferire dal modello al marmo tutte le misure necessarie per la buona riuscita dell'opera, con il pantografo (macchinetta) o con l'ausilio dei compassi.
Anche L'INTAGLIO DIRETTO prevede un qualche studio più o meno approfondito, predisponendo qualche bozzetto di riferimento; tranne che per il lavoro cosidetto commerciale che ha una tradizione artigianale e/o industriale. L'utilizzo di un disegno, stampe e/o fotografie è, da tempo, prassi consolidata. Soprattutto nell'arte cosidetta sacra e funeraria, l'intervento è diretto, d'acchito, utilizzando molteplici sistemi per " impastare" l'opera e la sua pulitura, agevolati da moderni macchinari.
Abbiamo un piano di appoggio a terra, costituito da un banco di lavoro idoneo : il tutto è formato da supporti di travicelli o casse in legno ( tipico nei laboratori ). Su uno di essi è adagiato il blocco; mentre il modello, solitamente, viene fissato ad una lastra di appoggio, posta su un altro banco da lavoro adeguato. I due soggetti, marmo e modello, sono sottoposti ad una propria livellatura e traguardati; poi, si debbono posizionare, frontalmente ed opposti, i due telai del modello e i due del blocco, in maniera tale che possano coprire in lunghezza e larghezza le dimensioni di entrambi questi ultimi ( la loro area e volume ).
Per dare un'idea del lavoro preparatorio, immaginiamo due letti, ad una piazza come i nostri di casa: l'uno, normalmente più piccolo, contenente il modello, l'altro, la statua. Ognuna di queste figure giacenti sul proprio letto, sul suo piano, a livello delle lenzuola, come se fossero delle persone. Ogni letto che si rispetti ha anche, da capo a piedi, le sue due sponde, poste frontalmente. Queste, per ogni soggetto menzionato ( i telai ), dobbiamo prefigurarle predisposte in scala di proporzione; e, sempre sul filo dell'immaginazione, pensarle livellate ognuna da un proprio piano virtuale, passante per i bordi estremi delle sponde, che le collega e si predispone parallelamente al piano geometrale ( o di terra ).Così raffiguriamo nella nostra mente dei parallelepipedi ( quello del marmo lo è realmente ), posti l'uno accanto all'altro ed ognuno con le proprie dimensioni atte a contenere sia quelle del modello sia quelle del marmo. Abbiamo descritto, contemporaneamente, anche lo stesso posizionamento dei telai, prefigurando con ciò il perimetro circostante al modello ed al blocco. Proseguiamo nella posa in opera, segnando sulle traverse ( secondo la dimensione dei telai ) tante suddivisioni uguali - ad imitazione delle tacche, simili, presenti nell'asta di ogni stadera - purché ognuna delle quali corrisponda all'unità grafica del rapporto designato, cioè conforme alle grandezze in scala della statua e del modello. Si auspica sempre l'impiego, come traversa ( detta anche cornice ), di una riga in legno spessa e con un profilo perfetto e non alterabile. Siccome ciò che è desiderabile non sempre è dato, si consiglia di fare molta attenzione nel segnare le tacche previste nelle cornici. Susseguentemente, sempre sulle stesse, si traccia, per tutta la lunghezza delle tacche, una linea che le incrocia a 90 gradi, all'incirca nella mezzeria della faccia alta di ogni traversa. Linea detta perimetrale perchè delimita il campo di lavoro. ( Un tempo si incidevano le tacche anche sui laterali dei telai per individuare meglio i piani ed i livelli della scultura, semplicemente posando la cordicella sui fermi, indispensabili, delle aste verticali; ricordiamoci dei livelli della nota " vasca d'acqua " di Michelangelo ). Quelle due linee perimetrali, nei diversi telai - modello e blocco - le chiameremo, arbitrariamente, d'orizzonte, poiché dovranno essere, tra loro, perfettamente parallele e traguardate. E' altresì importante che i piani sia del modello, sia della statua e conseguentemente dei telai, formino coll'orizzonte lo stesso angolo visuale. A questo punto, si prende una cordicella sufficientemente lunga, con all'estremità due pesi adeguati e la si appoggia sulle tacche, quasi a rappresentarne il loro prolungamento - prima su un lato delle traverse, poi sull'altro - a coprire tutta la distanza dei telai: non è complicato, le parti incise sulla cornice ben traguardate e numerate sono in sincronia, mentre i telai sono uno di fronte all'altro: si tratta di porre la corda sulle stesse tacche prospicienti collegandole. Poichè portano lo stesso numero in entrambi i lati dei telai, si segna la corda, con un pennarello, laddove incrociano con le linee d'orizzonte. Va da sè che a misure uguali, prese quasi all'estremità dei due lati, corrisponda una perfetta posizione parallela dei telai e delle linee d'orizzonte contenute. Predisposto ciò si murano definitivamente i telai, cementandone i piedi. LA PARTENZA è IMPORTANTISSIMA; lo smodellatore scandaglia il blocco, per vedere se vi può uscire la statua nelle volute proporzioni; assesta l'insieme del lavoro riportandone i punti principali dal modello. Soprattutto si prendono, dalla cordicella, le cale, in modo che le distanze dei piani del modello e del marmo siano uniformemente proporzionali alla proporzione generale fra modello e statua da eseguirsi. Questo è il momento più delicato: è consigliabile partire dalle due tacche mediane dei due telai, nel punto laddove incrociano con le linee d'orizzonte (es. se le tacche sono 10, il compasso è aperto sui numeri 5 dei due telai ). Si mette mano, immediatamente, al trasporto dei punti principali già fissati sul modello: il riporto inizia da quelli collocati circa alla metà; l'uno sul fianco destro, l'altro sul fianco sinistro. Da qui partono le prime intersezioni ( tre ). Con apertura di compasso uguale alla distanza del primo punto laterale dalle tacche, si effettuano le prime intersezioni ( due più la cala dalla cordicella sovrastante, che sarà perpendicolare al punto ); poi si provvede a riportare l'altro, con identica operazione. I due punti rappresentanto gli estremi laterali, che utilizzeremo per traportare i capi-punto situati uno alla testa e l'altro ai piedi del modello, per facilitarci le intersezioni delle misure lunghe sul piano. In questo modo si è anche cominciato ad individuare i vari campi di lavoro. Altri capi-punto strategici possono essere individuati per migliorare la geometria dei campi necessari ad un fedele trasporto dei punti. Fatte queste prime operazioni, si possono escludere le misure dei compassi dalle tacche, passando la direzione della manovra ai capi-punto del modello e della statua da eseguirsi, ad eccezione delle cale. ( Come già accennato le cale son state CALIBRATE; spieghiamolo meglio : dalla cordicella, sul modello, si sono prese le misure a quelle parti della figura che spiccano in alto o sottostanti, più basse, con queste si valutano i riporti sul marmo, calibrandone le cale, affinché tutte le distanze risultino perfettamente proporzionali. Semplicemente: il piano più basso e quello più alto del modello, debbono corrispondere, proporzionalmente, a quegli stessi da eseguirsi nella figura, che sono poi il riporto dei punti necessari a riprodurre la statua che il blocco deve poter contenere).
RIEPILOGHIAMO:
Tutti possono valutare le tante difficoltà di comprensione: un conto è l'esperienza pratica, un conto la teoria. Proviamo con un altro tentativo di semplificazione. Sarà puerile dirlo, ma abbiamo delineato un recinto delimitato dalle proiezioni congiunte e frontali dei telai, come se fossero le due porte di un campo di calcetto, collegate a confini ben delineati (con perimetro rettangolare). Lo abbiamo fatto in alto ed in basso: sopra di noi a livello delle traverse una rete di fili si prefigura, similmente ai vecchi telai nelle tessiture, considerato che spostiamo, spesso a tutto campo, la cordicella, ogni qual volta prendiamo una misura. E' proprio da questi fili che si ottengono le “ cale” , misure importanti per individuare, perpendicolarmente, un punto nella figura di un solido. Abbiamo simboleggiato, ancora una volta in maniera esageratamente grande, un parallelepipedo. Un campo sportivo non potrà mai essere un blocco; ma uscendo dall'immaginario, la sostanza è una sola: il marmo deve poter contenere congruamente il modello. Ritorniamo alla realtà, quella all'interno dello spazio sopra i banchi di lavoro, dove giacciono il modello e la sua riproduzione, ognuno con il proprio telaio nel rapporto voluto. Resta l'idea di un sistema operativo che ci ricorda l'uso delle squadre o delle cornici, con le loro divisioni in tutto il perimetro e dei corrispondenti fili a piombo. Ricordiamolo, queste, sono squadre fissate alla parete, ad angolo retto, e poste sopra la testa delle figure erette, sia del modello sia della statua per ricavarne le profondità. Qui, le misure si prendono prendendo dal filo di una cordicella tesa a piombo e mobile nel perimetro delle squadre. Nel sistema che descriviamo e che più correttamente chiamiamo del telaio, l'esecuzione è più precisa. Intanto perché il telaio ha proiezioni simili a quelle ortogonali al piano ( cale ). Non dimentichiamoci che la cordicella percorre tutte le tacche linearmente dal 1-1' o dal 2-2' e così via; ma può farlo anche di sbieco, da 1 al 10', mettendo in relazione compositiva, diagonalmente, parti da riprodurre. Infatti, il telaio, domina tutta l'area come se si sovrapponesse, visto dall'alto, ad un elaborato riprodotto in pianta; eppoi se la distanza dei telai tra loro non è molta, si può anche alternare la corda a piombo, con robusto ed inflessibile righello. E', inoltre, facilitato il riporto per la posizione più stabile della corda, che consente meglio l'apertura dei compassi tra essa ed il manufatto in questione, per la possibilità di essere a “ piombo “ sul lavoro; poi, di poter valutare, anche con i laterali del telaio, le sporgenze ed i rientri della figura, riportando una corda tesa su alcune tacche predisposte nei fianchi dello stesso. Si è da più parti, indicato l'esperimento di Michelangelo, con l'immersione di un modellino in una vasca d'acqua, lo rapportiamo all'esempio dianzi fatto, quello dell'estensione del filo laterale, poiché questi si pone sulla medesima traccia del livello dell'acqua: che è un livello sugli scorci dei piani che la figura, vista di profilo, staglia, quando il fantomatico pelo dell'acqua si alza o si abbassa.
PARTENZE ALTERNATIVE:
Dalle traverse dei telai, sia nel modello, sia nel marmo, nella mezzeria che fa' capo alle tacche (se sono 10 la mezzeria passa dal n. 5 al 5' opposto) all'incrocio con la menzionata "linea d'orizzonte", lo smodellatore utilizza i punti di incrocio anzidetti, come se fossero due capi punto di partenza, da questi, per mezzo delle intersezioni, segna altri capi-punto strategici, a destra ed a sinistra del modello e del marmo, poi passa allo scandaglio dei punti più rilevanti della figura, adeguandoli alle misure del blocco; altresì rileva le altezze più basse della statua, affinché sia congruamente contenuta nel blocco. In questa operazione, alzando o abbassando le cale, calibrandole perfettamente al riporto delle misure, dal modello alla statua, sia dei capi-punto, sia, nel proseguo, di tutti gli altri punti necessari, si adeguano tutti i corrispondenti piani, comprese le sporgenze. Poi si può passare, come già detto, la direzione delle lunghe direttamente dal modello al marmo; inalterate le cale.
E' possibile, fattibile, prescindere dal telaio sovrastante e procedere autonomamente, poiché questo piano, con la cordicella mobile sulle tacche, copre ampiamente lo spazio dove è collocato il lavoro? Abbiamo dianzi affermato che i telai sono sovrapposti al modello e al blocco, che fissano, su di loro, un perimetro di copertura, come se fossero due tetti nella voluta proporzione in scala. L'unico problema consiste nel posizionamento dei loro due soggetti sottostanti, che sono sì indipendenti, ma conservano una stretta relazione. La prima banale, il blocco deve poter contenere perfettamente il modello, praticando tutte quelle operazioni preliminari che abbiamo precedentemente detto. La seconda, si fissano i punti principali considerando che le linee delle cale, longitundinali all'elaborato, debbono avere assetti comuni, proporzionalmente dati. Quindi si può iniziare nello stesso modo di altre tecniche, più volte descritte. Si parte dai punti principali 1 e 2, riportati dal modello sul blocco per mezzo delle intersezioni, che segnano in lunghezza anche le linee di mezzeria, nella stessa posizione,il marmo e il modello. Queste linee debbono coincidere con la stessa linea di mezzo dei telai e confermate dalle successive cale. Cosicchè tutti i tre punti necessari saranno organici e nell'insieme a tutti quegli altri che verranno, utilizzando un vantaggioso sistema comune. Al riguardo, restano fermamente confermate le corrispondenze proporzionali, quelle della distanza dei telai dai piani del modello e della statua da eseguirsi.
TELAIO : ALTRE TECNICHE
Bassorilievi e Altorilievi
Questa applicazione del telaio può essere fatta prefigurando un impianto più modesto per i bassorilievi e altorilievi, mantenendo inalterate tutte le applicazioni e regole che riguardano l'uso del triangolo di proporzione. In tal caso i telai sono alzati sul piano di marmo e sul modello: sono lastre di circa 3 o più cm di spessore e di lunghezza uguale ai piani di posa del lavoro; la loro altezza, rispetto al maggior picco verticale del modello, deve poterlo superare da 6 a 10 cm, presi dal suo punto più rilevante. Ciò per utilizzare, i compassi, in maniera più precisa e di aprirli nel modo più consono al trasporto delle cale. I piani di partenza sono importanti. Dire che il piano del marmo deve occupare nello spazio la stessa inclinazione del modello o lo stesso angolo con la linea dell'orizzontale, non è sufficientemente chiaro. La migliore illustrazione si ha facendo un semplice calcolo: il piano del telaio del modello è, poniamo, di cm 6 e l'ingrandimento previsto è il doppio: Posso alzare il piano del marmo di 13 o più cm? No, perché escluderei la parti più rilevanti del modello. L'altezza delle lastre di questo telaio potrebbe essere 12 ( esattamente il doppio ), e partire “ fatti “. Meglio allora alzare a cm. 11,50, per avere la disponibilità minima di marmo ( roba ), per segnare il punto o capo-punto.
Si procede incidendo sulle coste o spessori delle lastre le tacche, partendo dalla mezzeria, così pure, come sulle linee dette di orizzonte che le incrociano si fissano, agli estremi della linea di mezzo, i due capi-punto; il tutto, nel mantenimento del rapporto proporzionale generale. Da questi primi due capi-punto, nella mezzeria, se ne fissano altri strategici, a destra e a sinistra, per poter tempestare di punti la statua onde farla emergere. Si lavora su piani precostituiti, c'è una qualche attinenza con le intersezioni che operano sul foglio da disegno, perché il bassorilievo non ha le dimensioni di una figura a tutto tondo, perciò occorre far molta attenzione all'impostazione del lavoro portando su di esso misure precise. Sull'impostazione, una volta che si è avviata l'opera con i capi-punto della mezzeria, il telaio si utilizza solo per le cale, osservando un modulo unico. Si può sbagliare, con un sistema misto di misure: lunghe e profondità prese, un po' dalle tacche, un po' dai punti sul piano.
UNA DIVERSA IMPOSTAZIONE DEL TELAIO.
I TELAI, se lo spazio nel laboratorio è scarso, possono essere posizionati in un altro modo da quello precedentemente descritto, facendo ricorso ad un sistema misto: mentre il telaio sovrastante il blocco rimane fisso a terra, quello del modello può essere posizionato, in piedi, aderente alla parete più prossima. A questa, e sopra la testa della statua, è fissata, alla parete, una squadra o cornice, che pur mantenendo la stessa proporzione, rispetto al rapporto di grandezza stabilita con il telaio, è parte di un sistema detto delle gabbie.
Con ciò necessitiamo di ulteriori delucidazioni, mai troppe ed inopportune.
COME SI PUO' INDIVIDUARE UN PIANO NELLO SPAZIO.
A) Ricordiamoci che ci stiamo occupando delle figure solide, i cui punti non giacciono tutti sullo stesso piano ( ogni piano divide lo spazio, semispazi,ognuno dei quali contiene infiniti punti ). B) Concetto di piano si intuisce ma non si definisce; sono facilmente intuibili i seguenti postulati: 1) un solo piano nello spazio può essere determinato, tra gli altri, per tre punti non allineati. 2) Per due punti A e B di una retta passano infiniti piani, ma uno solo di questi passa per un punto P, assegnato, non appartenente alla retta. E' lo stesso principio " della piramide a base triangolare", per trovare il suo vertice occorre riferirsi almeno ad altri tre punti non allineati.
C) INTERSEZIONE: L'intersezione di due figure è la parte che hanno in comune: perciò una retta che non appartiene in alcun modo ad un piano, ma lo interseca, ha solo un punto in comune con esso.
IL PRINCIPIO DI B. CAVALIERI.
Il principio di Cavalieri pensa che " un solido si può considerare formato da tante lamine sottilissime sovrapposte: due solidi uguali o diversi, ma formati dallo stesso numero di lamine, dello stesso spessore, con superfici equivalente, essi avranno la stessa estensione. L'enunciato: " dati due solidi, se è possibile disporli, rispetto ad un piano, in modo che ogni piano parallelo a questo li tagli secondo sezioni equivalenti, i due solidi sono equivalenti ".
Questa teoria la valutiamo diversamente, nella stessa visione che tutti i corpi hanno una loro estensione solida (occupano una parte di spazio ) e sono racchiusi da poligoni o figure piane di diversa dimensione. Più che al risultato della equivalenza ( prismi aventi altezze uguale e basi equivalenti avranno la stessa estensione ); il nostro obiettivo, solitamente, è quello della similitudine: esclusivamente di uguale forma. La consideriamo diversamente perchè il nostro modello, indipendentemente dalla postura e dal suo rapporto in scala, lo immaginiamo imprigionato in un parallelepipedo, che è la sua riproduzione nel blocco di marmo. Noi siamo interessati alla manualità del levare il superfluo, per copiare il modello, partendo dal'unicità del punto di vista frontale. Si inizia predisponendo l'intaglio dal piano alto, e mano mano, scoprendo le parti più sporgenti, si scende fino alle rotondità posteriori del piano di base. Il lavoro viene affrontato frontalmente, ma contemporaneamente, si opera anche sul profilo della statua per mantenerne i contorni e la giusta postura, secondo le proporzioni stabilite e mantenendo l'organicità della composizione.
1.RIPRODUZIONE DI SCULTURE PER MEZZO DEL TRASPORTO DEI PUNTI. 2.INTAGLIO DIRETTO ( "COSIDDETTO AD OCCHIO" ).
Di solito con il bozzetto si fissano le prime intuizioni, precedute da uno studio comprendente diversi disegni di approccio. Fissata l'idea si procede con la realizzazione del modello in creta e susseguentemente si getta in gesso con il metodo della forma persa ( raramente si formano gessi di grandi dimensione ). Si è perduta la tradizione del CANOVA di modelli o monumenti grandi al vero, che offrivano il vantaggio di valutare tutte le incidenze: luce, proporzioni, linguaggio della postura; concorrenza dei volumi e vuoti, linearità. Il ricorso a piccoli modelli è la norma, poi si affida l'opera a maestranze esperte. E' possibile che l'artista intervenga, con l'ultima mano. La presenza del modello, da tradurre nelle proporzioni stabilite, oltre ad una visione generale e particolare, offre anche la possibilità di trasferire dal modello al marmo tutte le misure necessarie per la buona riuscita dell'opera, con il pantografo (macchinetta) o con l'ausilio dei compassi.
Anche L'INTAGLIO DIRETTO prevede un qualche studio più o meno approfondito, predisponendo qualche bozzetto di riferimento; tranne che per il lavoro cosidetto commerciale che ha una tradizione artigianale e/o industriale. L'utilizzo di un disegno, stampe e/o fotografie è, da tempo, prassi consolidata. Soprattutto nell'arte cosidetta sacra e funeraria, l'intervento è diretto, d'acchito, utilizzando molteplici sistemi per " impastare" l'opera e la sua pulitura, agevolati da moderni macchinari.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)