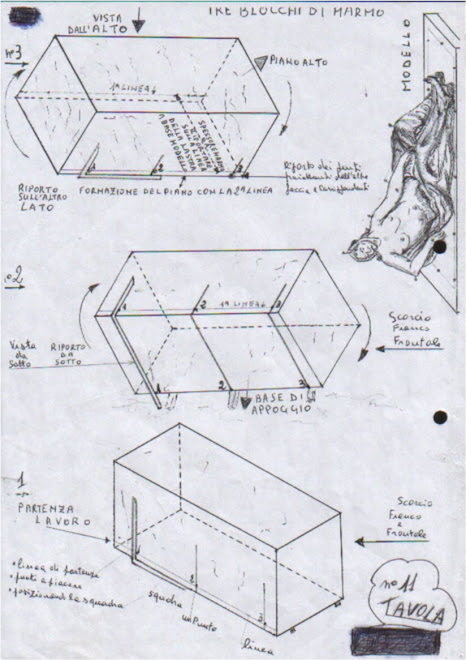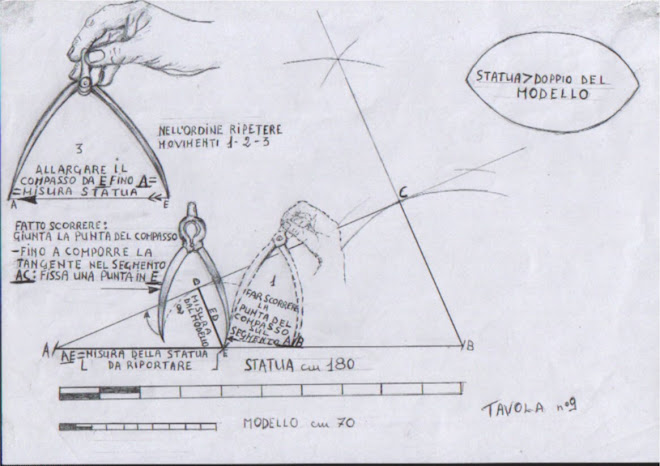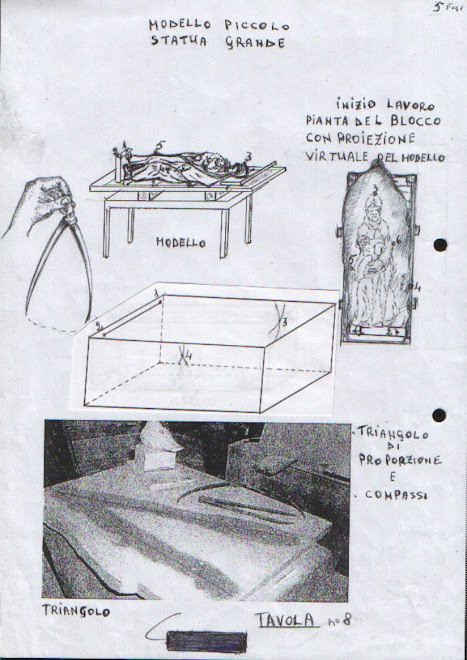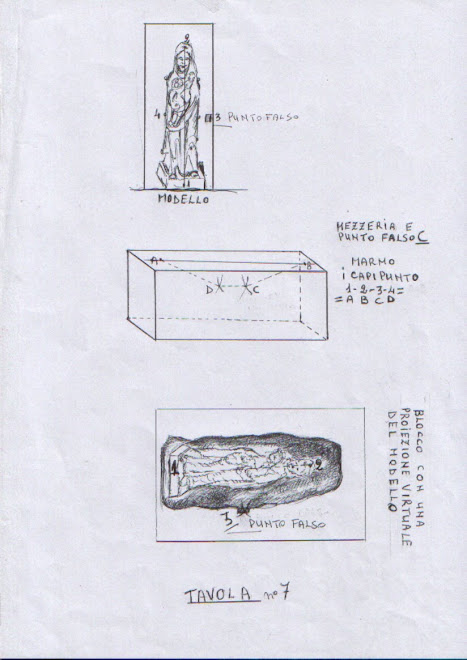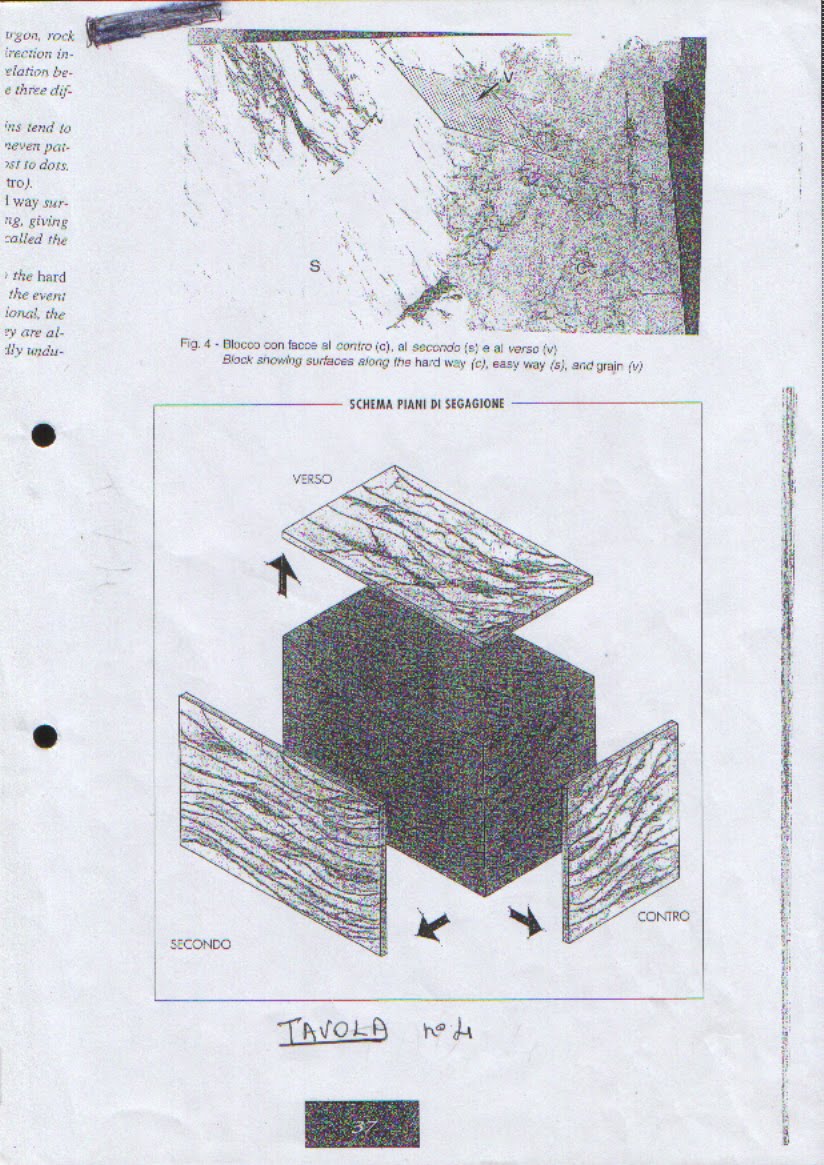SCULTURA:
LA POETICA, LE TECNICHE, IL PUNTO DI VISTA.
Ragioniamo
su alcune osservazioni, allorquando un artista si accinge a
rappresentare un'idea. Si da' per certo che si vuol realizzare ciò
che si è già concepito nella mente: ossia l'oggetto preciso della
nostra immaginazione.
La
differenza sostanziale tra opere fatte e finite è tra la freschezza
dell'una, nell'esprimere di getto l'idea originale, e un'altra troppo
cincischiata e leccata, che può soddisfare l'occhio, essendo di
grande pulimento, ma alla fin fine inespressiva.
Naturalmente,
non vi è contrasto con l'adoperarsi a perfezionare il massimo di
carica espressiva: sì, è giusto che l'idea sia fatta crescere,
maturare, e precisata ulteriormente con uno studio appropriato.
Poniamo di assumere il tema del rapporto uomo – ambiente, uomo
soggetto e/o protagonista; come realizziamo o consideriamo lo spazio
in cui collocare tale figura? La pittura e l'architettura possono far
ricorso alla prospettiva lineare dandovi profondità ed indicando
spazi e oggetti umanizzati. Lo scultore lavora sul pieno e sul
volume, non sul vuoto dello spazio. Ripetiamolo, per esso, fin dalla
sbozzatura più che nella smodellatura, esiste il valore espressivo
ed estetico della geometria, utile per meglio orientare l'opera. Già
qui comincia a rendersi conto del volume, dei contorni e delle masse
( sporgenze e rientranze ); per mezzo delle quali, con lo scolpire
per piani degradanti, si precisano meglio l'andamento degli assi (
orizzontali, verticali, obliqui ) che determinano il ritmo della
composizione. Sono gli assi che suggeriscono la direzione dei piani
da fissare con l'ausilio del trasporto dei “punti” nelle varie
fasi della lavorazione. Viceversa nell'intaglio diretto è la buona
conoscenza del disegno e lo studio accurato in tutte le sue parti
dell'opera, che guida la mano dello scultore, anche attraverso varie
simulazioni di un modellino in creta. Ci si riferisce, a mo'
d'esempio, all'arte dei grandi: ( Donatello, San Giovanni
Evangelista, Firenze ) - “ l'Apostolo si gira leggermente,
collocandosi nello spazio sia con la sporgenza delle gambe, sia con
il busto che vi si collega mediante la linea obliqua della mano e il
passaggio graduale, verso la verticale, dell'avambraccio e del
braccio.....”; - (Donatello, San Giorgio, Firenze ) “ Ha la sua
radice nell'identificazione stilistica del moto, spazio e saldezza
plastica. Lo scudo, oltre a segnare col suo spigolo l'asse della
composizione , con l'obliquità delle sue due ali traccia confini
sicuri nello spazio alla figura, abbracciandola completamente nella
postura delle gambe e, attraverso la spirale avvolgente del manto,
afferra ruotando il braccio sinistro per concludersi nel nodo quasi
all'altezza della spalla destra.”
Queste
citazioni ripropongono l'uomo e lo spazio in una antica dialettica
classica dai termini noti: la composta staticità, la dinamica che
esprime la continuità del movimento delle figure soggetto nello
spazio. “ Il contenuto spaziale della composizione in sintonia con
l'accamparsi dinamico del volume , rilancia l'aspetto di una umanità
rinata e fieramente armata di nobili ideali più che una immagine
emaciata. “ Ma come vengono percepiti questi genuini tentativi di
rinnovamento? Nel primo Rinascimento la postura esprime equilibrio
e compostezza della figura, recuperando la bellezza Classica.
Privilegiati due punti di vista frontale e posteriore: la figura è
inserita in un perfetto parallelepipedo. I corpi sono quasi dei
solidi geometrici. Nel tardo Rinascimento, l'abbandono
dell'equilibrio e la figura tormentata, costruita sullo schema a
spirale, moltiplicano i punti di vista. Perciò Il Mercurio del
Giambologna anticipa un'identificazione stilistica più moderna:
esprime una infinità di punti di vista, la sua struttura visiva è
stata definita stellare o raggiata, proprio perché la figura
costituisce il punto centrale intorno a cui si può girare ( ricorda
Rodin?). L'arte moderna inizia con il negare la frontalità, per
cogliere più superfici ( ogni frammento può considerarsi un'opera
d'arte? ), sospinti, tutti, a correre intorno alla figura,
eliminando definitivamente la visione principale. Ma anche il Barocco
mise in campo nuove capacità espressive volte a stupire, che non
sarebbero state possibili con la postura classica e senza il rifiuto
delle normali linee rettilinee, sostituite dalla spirale, e con il
costante ricorso alla linea curva, spezzettata, contorta. Qual'è la
differenza? Nella produzione impressionista di Rodin e Rosso si parla
del migliore dei punti di vista, quello che riesce a farti
apprezzare meglio l'opera e l'artista, elevando persino il singolo
frammento ad opera d'arte completa. Con il Barocco, un' opera la si
può apprezzare gustando anche singole parti, una volta assimilato
l'insieme ( lo stile, la forma, il significato segnico del contesto).
L'effetto è la teatralità del Barocco, fondamentale per
riacquistare i fedeli e punire i trasgressori: riconquistare quelle
verità divine che non è stato possibile dimostrare nella realtà
dell'uomo contemporaneo.
“ Quello
che apparenta Rodin e Rosso è il senso della continuità dinamica
dello spazio e l'intuizione della luce come mezzo per esprimerla”.
Entrambi negano la frontalità: che non è una novità, come abbiamo
visto fin dal tardo Rinascimento.
Medardo
Rosso impone un rigoroso punto di vista; Rodin vuol essere
espressione in tutte le direzioni dello spazio reale.
Poetiche
in gioco.
La
poetica e la tecnica fondamentale di Michelangelo è che dentro ogni
blocco di marmo esistono infinite forme. Michelangelo parte da questa
teoria: ciò che deve essere rappresentato esiste già nella mente
dell'artista, l'esecuzione consiste nel levare il marmo superfluo: la
scultura è quella che si fa' per forza di levare e non di porre. La
statua in potenza già vive dentro il blocco. Tecnicamente e
poeticamente “il processo creativo Michelangiolesco”, privilegia
l'unicità del punto di vista centrale, cavando per piani, arretrando
fino a quello posteriore, (in linea con il perfetto parallelepipedo).
Si ritorna sull'esempio del San Matteo che tenta di uscire dalla
materia con fatica dove tecnica e poetica concorrono insieme.
Michelangelo è moderno in tutto: dall'uso della copia, per
l'importante esperienza fatta nel “Giardino San Marco” dei Medici
( più simile all'insegnamento delle nostre Accademie e diverso dalle
“botteghe” di allora); all'uso delle tecniche. Il punto di vista
frontale, la concezione dei piani ( la sommità piana della vasca
d'acqua che scende nel suo defluire ), è fondamentale per
comprendere tutte quelle tecniche che, mano a mano, porteranno nel
Ottocento e oltre all'esplosione di sistemi e tecnologie innovative.
Questo processo segnerà sempre di più la tradizione scultoria,
moltiplicando l'uso delle copie, caratterizzando l'insegnamento nelle
scuole moderne, per imparare le regole e la tradizione. Anche se
l'utilizzo del modello, per una migliore riuscita del lavoro,
Michelangelo lo considerava più un aiuto dovuto ai suoi allievi.
Egli preferiva scolpire d'acchito disegnando direttamente sul blocco,
rincorrendo quell'idea, che già preesiste nel marmo, che vive
eternamente e che l'artista ha il compito di liberare dalla materia,
lottando con essa. Qui, il sentimento è la lotta epocale dell'uomo,
in un conflitto irrisolvibile e senza speranza con se stesso; non è
il rapporto sereno del Brunelleschi: la virtù della ragione che
domina le cose.
Nonostante
la critica, è la poesia michelangiolesca che riflette preminente
sull'idea dell'arte, sulla “fatica corporale che genera sudore”,
sulle tante insoddisfazioni e amarezze: “Non ha l'ottimo artista
alcun concetto c'un marmo solo in sé non circoscriva col suo
superchio...”. E' quantomeno ingeneroso il giudizio di Leonardo
sulla scultura, qualificandola arte meccanicista che genera sudore,
quando la scultura, rispetto alle altre è arte di grande ingegno e
scienza sublime, tutt'altro che meccanica e rozza.
“Dopo
la morte di Michelangelo è iniziato un lungo processo di distacco
tra modellatore ( cera, argilla) e colui che lavora la pietra, fino
al punto di considerare la scultura subordinata al modello che è
dell'artista. Una autentica frattura tra invenzione ed esecuzione: un
tempo l'artista riassumeva in sé i termini antagonisti di Statuario
(l'artista) e scultore (chi scolpisce con lo scalpello: l'artigiano).
Oggi
lo scultore è solo il copiatore: un esecutore sempre in ombra e il
mestiere ininfluente; così pure l'utilizzo delle tecniche e dei
ferri. Ma chi sceglie la materia ed è a contatto con essa? Chi ha
consentito di veicolare l'arte, i tutto il mondo, attraverso le
innumerevoli riproduzioni?
Pensare
la scultura sulla base di un piccolo modello non è la stessa cosa
che pensarla in pietra. Oppure si ricorre a modelli uguali al vero.
Canova, già dalla tomba di Clemente XIV, introdusse questa
innovazione, portando all'estrema perfezione il modello: non più
come semplice riferimento, ma guida fedele per la smodellatura.
Riservandosi l'ultimo strato di marmo, lasciatogli dalla lavorazione
precedente, rifiniva e si riappropriava, portando all'ultimo grado
tutto il valore segnico dell'opera e dando una definitiva impronta di
sé.
(E'
corretto non dimenticarsi di un'altra manualità che interviene
immediatamente dopo il puntatore: è uno scultore che, spianando i
punti, conduce la scultura all'ultimo grado di rifinitura,
lasciando una piccola grossezza di marmo, alla magistralità del
tocco di Canova). La manualità dello sbozzatore e smodellatore è
importante; certo la direzione dell'artista deve essere presente e il
loro concerto appropriato ed affidabile. La realizzazione
“dell'idea” non è mai scontata e lineare, per possibili
imprevisti insiti nel marmo o le relative difficoltà di lavorazioni.
Torna alla mente un frase di Martini: “molti artisti mandano
incompiuti modelli in gesso, fidando di trovare, a Carrara, i geni
che rimettono a posto le loro magagne”.
LA
MATERIA, LE TECNICHE, I FERRI.
E'
delittuoso lavorare il marmo e renderlo più brutto di quando era un
semplice sasso, e quando al naturale esprimeva qualcosa di più.
Non
si può disonorare e maltrattare una materia nobile: snaturarla o
snervarla, eccedendo nella pulitura con le smerigliatrici. Le
sculture ne soffrono per l'appiattimento ed i loro contorni vengono
alterati e insignificanti. I costi di mercato costringono a
comprimere il fattore tempo, facendo si che si avvii una produzione
industriale e/o commerciale di brutte sculture. Così il ricorso ad
una lavorazione industriale rapida ( quanto squallore nell'arte
funeraria! ), per le tecniche usate, elimina o rinnega il vero
linguaggio della scultura. Un altro dileggio: non si comprendere
perché il primo “Bischero” che capita a Carrara, carico di soldi
e di raccomandazioni più che di “illuminate idee”, lo si debba
osannare e super gratificare, e non si possa, cambiando referente,
organizzare e finanziare la gloriosa tradizione scultorea Carrarese.
Le
tecniche e l'uso dei ferri debbono, non solo essere appropriate ,
personalizzate e ideate sul campo alla bisogna, secondo il lavoro da
farsi; ma anche tener di conto della qualità del materiale rispetto
alla sua durezza e lavorabilità.
Questo
ci ha insegnato il Canova che portava a perfezione la rifinitura,
consapevole che la sua tecnica espressiva era cominciata da una
eccellente qualità del materiale, dalla perfezione della
smodellatura, da tecniche innovative sul finito , compresa la
lustratura. Per avere una idea dell'affezione del Canova verso la
scultura, pensiamo a questo : – intanto la cosiddetta ultima mano
era tutt'altro che un sigillo formale; - spesso, lasciava e
riprendeva il lavoro dopo un lasso di tempo, iniziando una rifinitura
particolare: al lume di candela, per attuare quelle affettuosità
delle superfici, studiandone i trapassi delle ombre e delle luci
proiettate dall'alto, considerando l'opportunità delle rugosità e
riflessi da armonizzare con le tracce dei ferri o da lasciare
all'opera del lustratore. Da considerare che tutte queste
osservazioni e precisazioni erano già state anticipate nello studio
del modello in gesso portato al vero .
Non
sembrino meticolosità inutili, la pedante descrizione della luce di
taglio dall'alto, che simile a quella degli scuri laterali (luce
radente) evidenzia rugosità indisponenti. Nessuno si allarmi oltre
il dovuto, perché anche questo effetto indotto ci consente da una
parte l'apprezzamento del marmo e il suo essere trasparente,
brillante e carnicino; dall'altra, per tracciare e lasciare segni
voluti e sentiti, facendo apprezzare anche i più impercettibili
elementi di uno stile: la stessa verosimiglianza della pelle ha
integrato l'idealizzazione dell'arte greca. “ Fra i diversi marmi
che si estraggono dalle cave di Carrara il più prezioso senza dubbio
è quello detto volgarmente statuario bianco. A fronte che assai
densa ne sia la materia e grave il peso, ciò nondimeno la sua
omogeneità, candidezza, traslucidezza, e pulimento armonizzandosi
con la diafaneità dell'atmosfera lo rendono atto più di qualsiasi
altra sostanza a rappresentare la leggerezza, e le forme quasi aeree
di quegli esseri mitologici ed eroici, i quali si costumò essere
celesti. Le statue di marmi coloriti e di metallo sono belle per
convenzione ( il diaspro, il basalto, il bronzo), ma pesanti e
compresse verso il suolo..... Apollo, Diana, Ebe, Mercurio nel
sortire sotto lo scalpello dal bianco masso marmoreo non molto
differiscono da quelle stesse divinità, sporgenti dalla nube alla
voce di Omero per manifestarsi ai mortali.” ( Eman.le Repetti).
Ombre, pieghe, semi trasparenze, il rosato della carne viva (qualità
proprie del buon statuario), pongono gli scultori alla pari dei
coloristi e dei pittori . Essi infatti si servono di tutte le risorse
del rilievo: luce (forte) con ombre tenue si alternano quando non si
coniugano in una sinfonia. Il colore è come il fare del bel
modellato: veri passaggi, varie texture, e infine il linguaggio
liberatorio del “non finito”, non solo dalla materia, ma anche
dalla perfezione di un modello: per ciò che il compiuto è
immutabile in contrasto con l'incompiuto che si apre ad infinite
possibilità di soluzione;a qualità infinite, impreviste
(Michelangelo).
ANALISI
PARTICOLARI
Figure
Intermedie
Non
è di troppo neppure l'analisi e lo studio delle cosiddette figure
intermedie ( singole attività lavorative parcellizzate ). Ciò che
più ha fatto disgustare, anche per gli eccessi non virtuosi, il
marmo di Carrara è l'abilità, o meglio l'insufficiente abilità, a
ripetere, di mestieranti/specialisti: un lavoro industriale che ha
suddiviso varie parti della scultura; mani, piedi, volti ( estremità
curate dallo scultore); le vesti (pannista), fiori, capelli,
ornamenti vari ( ornatista ). Allo scalpellino gli elementi
architettonici ( capitelli, basi, ecc). Questi sono alcuni indicativi
elementi di parcellizzazione che hanno disaffezionato nell'apprezzare
le qualità vere del marmo, che piuttosto richiede più armonia nella
lavorazione e originalità nelle espressioni: come ad esempio nella
postura della figura, nel taglio e caduta delle pieghe, nelle
tecniche dell'impasto come nella rifinitura. Insomma, è mancata la
cultura della tradizione, quella preziosissima dei maestri delle
botteghe carraresi, insieme al deperire di ogni apporto scolastico.
Cosicché i manichini nelle loro rotondità asettiche e legnose sono
meglio formati e vestiti.
Il
Marmo.
La
qualità del marmo non può prescindere: dalla lucentezza, pastosità,
gradevolezza, sensibilità e trasparenza. Un marmo che sia anche
consenziente: cioè suscettibile di ottimo pulimento e di plasticità
notevoli e surreali. Tutto ciò è reale: un marmo la cui pasta
finissima e tenace si presta ai lavori di scultura e di ornato, per i
lavori più finissimi e delicati; che sia resistente agli stacchi e
può tirarsi a capello, se vogliamo ricorre ad una espressione
gergale.
Occorre
aver respirato l'aria delle nostre cave, assaporato le sue abitudini
lavorative, i suoi richiami, visto i camminamenti sui ravaneti, per
assaporare quella tradizione che pregna di sé ogni atto e modi di
dire, per intuire quanto questa identità possa aver influito, in
passato, sulla produzione artistica e scultoria. Insomma il marmo è
tante cose della nostra tradizione: nei termini dialettali come
nell'esprimere con una certa durezza atteggiamenti. Sembra la nostra
indole somigliante a quel marmo che tanti momenti avversi della
nostra vita ha rappresentato: in sintonia con le sue sorti
altalenanti, i suoi difetti e imprevisti. Sentirlo dentro di se', il
marmo, lo si trova più docile e consenziente, soprattutto nello
scolpire: una disposizione d'animo sensibile è importante e si
colloca in armonia con un materiale prezioso e buono. Avversarlo lo
rende ostile e caparbio: resistentissimo alla ottusità dei colpi
mal diretti, non coordinati. Dal cattivo suono materico , con il
ferro che via via si fa' più bolso, si evince la contrarietà del
materiale all'insensibilità più che all'imperizia. L'artista, dal
tocco malevole, che maltratta l'armonia degli strumenti, con
eccessiva pesantezza di mano, non coglie alcun risultato propostosi,
bensì il suo contrario. Non sente “il rude” che ben non
iscaglia, con i colpi dati alla cieca pesantemente. Non sente che il
suono non è ritmato e non segue trame ordinatamente dirette? Alla
gradevolezza del suono ritmato corrisponde un marmo arrendevole e un
tessuto omogeneo tracciato dal ferro. La forza va' calibrata, mentre
i colpi possono essere virtuosi. Con il martello pneumatico occorre
una mano miracolosa che sa' prendere il verso e deve esercitare una
giusta pressione, tale da consentire al ferro di mangiare il marmo
statuario gradualmente, o di penetrare segnando dolcemente quei
passaggi di subbia, gradine, scalpello tagliente, e consentire al
marmo di prendere lodevoli forme e tramare. Insulso anche l'uso,
mortificante, di portare la superficie della scultura tirata a
lucido, ad ogni costo, fino a far scomparire ogni traccia della
lavorazione , che è la conseguenza del modo in cui ci si avvicina
all'impasto della forma e alla texture desiderata.
Va
recuperato tutto il mestiere, altrimenti rischia di isterilirsi: il
praticantato nelle botteghe e nelle scuole è importante, perché vi
è una osservazione diretta su tutte le fasi delle lavorazioni;
occorre rispettare tutti i passaggi del modellare, le scorciatoie
sono dannose, come impuntare eccessivamente il ferro, tagliare e
trapanare in profondità. Il lavoro deve poter emergere gradualmente
dalla materia, quasi liberandosene, sfruttando la scala dei piani e,
mano a mano che si rendono più visibili le parti più sporgenti,
parimenti, dar corpo da un lato e dall'altro, all'immagine già
realizzata, completandola. La scalpellata deve essere lunga ed a
correre, altrimenti le pestature e le scalette comprometteranno
alcune parti dell'opera. E' impensabile spianarle con le macchine
abrasive per porre rimedio ad un marmo irrimediabilmente squamato.
Anche l'uso delle raspe e degli smerigli non può essere né
anticipato né abusato eccessivamente nella rifinitura: ne l'un caso
si pasticcia solamente; nell'altro si toglie incisività al segno ed
i contorni perdono forza, mentre i chiaro scuri scemano
nell'inespressività, afflosciandosi. Volendo attutire le asperità
della pelle del marmo, negli incavi, è consigliabile strofinarlo
con sabbia di mare, che non è purgarlo, perché, il termine, nel
linguaggio carrarese ha il significato più di una operazione fatta
anticipatamente e in profondità.
L'Anima.
Nulla
può essere lasciato al caso: la scultura deve poter aver un'anima
che è la spiritualità dello scultore, il senso e l'espressività
della sua personalità: non altro. Perciò nulla è lasciato al caso:
non lo è la plasticità, in omaggio alla quale alcune parti si
debbono considerare in rilievo rispetto ad altre più scavate;
perciò va' stimato quale armonia riservare a ciò che deve essere
lasciato in piena luce, dandogli più o meno forza e ombra; e quali
altri risalti dare agli effetti di superficie, con una linea più
morbida e delicata, oppure rimarcarne le tracce e tormentando le
stesse linee con profondi scuri, spezzandole.
Ritornando
alla diatriba iniziale tra l'ideatore (artista) e l'esecutore
(scultore), entrambi sono obbligati ad incontrarsi a un preciso
crocevia: il requisito fondamentale di un opera è che deve
corrispondere all'idea per la quale è stata concepita, o a
qualsivoglia soggetto, somiglianza o rappresentanza per la qual cosa
essa è stata pensata e originata. E' fondamentale, la casualità non
può essere una scappatoia: affinché il tutto non si possa
giustificare, banalmente, con il tanto triste “non è bello ciò
che è bello ma è bello ciò che piace”; infatti un segno in
libera uscita può essere qualsiasi cosa o qualsiasi processo di
identificazione; oppure perché si vende bene nel variegato mondo del
“politicamente corretto”. L'artista gode di un ottima
pubblicità e consenso? Bene. Ne ha tutto il diritto se ha anche un
buon conto in banca oltre che amicizie potenti. E l'arte, beh!
l'arte è un altra cosa.
UN
PUNTO DI VISTA DIVERSO
Quante
sculture sono concepite con un unico punto di vista, frontale o
laterale, il buon senso ci induce a pensare che ciò dipenda dalla
loro funzione o significato; dallo spazio che si voluto occupare o
corredare. Perciò è ingiusto negare la validità di un solo punto
di vista, che lascia le altre parti in ombra; oppure la possibilità
di esprimere il dinamismo come un prolungamento di continuità nello
spazio, attraverso una sequenza stilistica. Si pensi anche alla
funzione ancillare rispetto alla architettura e al suo uso modulare,
ritmico, o di supporto (cariatidi). Il problema di uno scultore è
quello del rapporto con l'ambiente, di organizzare una collocazione e
farla vivere ed essere protagonista in quel determinato spazio.
Spesso gran parte della figura sono nascoste alla vista: la parte
posteriore, se collocate in una nicchia, non è neppur rifinita; la
stessa cosa avviene per la loro collocazione nelle facciate delle
chiese e dei palazzi, ma anche negli stessi ambienti interni. Perciò
lo studio del posizionamento dell'opera non può che seguire un
preciso significato, anche coreografico, se desideriamo progettare
altri punti di vista. Non dimentichiamoci della luce, sempre
determinante nella scultura, il cui protagonismo e la gamma di
gradazioni meritano uno studio attento e non superficiale, essendo
il principale artefice con il precipuo compito di modellare,
definitivamente, la struttura delle superfici, scivolando o
incuneandosi dentro esse. Va da sé che ogni scelta soggettiva è la
più efficace, ma non quando si vuole stupire in ogni modo e in mille
modi insignificanti, spacciandoli per le nuove frontiere espressive.
La questione, sempre, attiene alla progettazione, stile e funzioni
attribuite all'opera. E forse anche la committenza avrà, con
diritto, dato indicazioni.
Nel
merito, osserviamo la bellezza classica del Davide di Michelangelo,
anche qui la critica si sofferma sull'eroico simbolo esclusivamente
attraverso una visione frontale: “la figura gigantesca è tesa,
concentrata, compressa come un elastico che accumula tensione per poi
liberarla in un solo gesto, nella statua ancora implicito”. Segue
la descrizione su di un movimento imminente, in potenza, che sta per
esplodere; ma tutta la descrizione si sofferma sulle parti anatomiche
anteriori (frontali).
Il
senso poetico è compiuto, anche se in ombra il posteriore, ben
fatto, completa il capolavoro senza la benché minima stonatura.
Infatti, il Davide è il simbolo della repubblica fiorentina. Ciò
conferma le osservazioni sulle funzioni soggettive della figura e
sui diversi modi di organizzare lo spazio e, conseguentemente, sulla
scelta del punto di vista: quando si trattò di trovargli una
collocazione, Leonardo propose la nicchia all'interno della Loggia
della Signoria; mentre Michelangelo e la commissione proposero il
piano di appoggio del grande muro del palazzo nella stessa piazza.
La
questione della scelta del punto di vista attiene più ai
proponimenti progettuali e ideali e non può essere affatto
occasionale; certamente può corrispondere, semplicemente, a una
scelta estetica o modulare, eppure anche in questo caso esprime un
senso compiuto.
Non
è possibile dimenticate il tema del “non finito” di
Michelangelo: la tecnica eccelsa che diventa essa stessa linguaggio e
poesia, nei modi del plasmare, nei passaggi gustosissime tracciati
dai differenti ferri. Così è, almeno per chi ama la scultura,
quella vera. Sul problema del non finito, di Michelangelo, occorre
operare una distinzione, nel contesto delle opere non portate a
termine: tra quelle incompiute per cause accidentali da quelle
effettivamente non finite, ma poeticamente concluse in maniera
definitiva per volontà dell'artista. Per alcuni critici, “
l'improvviso arresto del lavoro è stato causato dalla soddisfazione
di aver raggiunto il termine della propria visione, che in questa
tecnica vedeva il completamento supremo della propria opera”. Ma
quanto è bello il contrasto plastico tra le parti abbozzate e quelle
finite!, se improntate da mani virtuose; e quanto movimento esprime
una forma che levitando tenta di liberarsi dal blocco. C'è chi,
invece, apprezza “ la maggiore espressione di pathos che balza da
una sintesi estremamente rapida e ardita”. “Da parte sua l'ARU
dava nuova validità alla tesi celliniana dell'unicità di visione
per cui, Michelangelo si sarebbe, nella sua pratica di scolpire “per
forza di levare”, fermato allorché, nel processo in cui la
scultura prende forma a poco a poco, la sua eccellenza plastica
sarebbe stata attenuata dalla creazione di altri punti di vista”.
In
definitiva, nella pratica di scolpire, Michelangelo avrebbe
privilegiato l'unicità del punto di vista frontale ( secondario il
posteriore e tutti gli altri ).
Ma,
questa visione è, grossomodo, in sintonia con la tecnica
dell'arretramento del piano anteriore ( di partenza o inizio lavoro
), verso altri piani, rendendo mano a mano visibili le parti più
sporgenti, che saranno rifinite, in contrasto con la materia che
tiene prigioniera l'immagine.
Michelangelo,
alla pari o ancor più dei grandi artisti carraresi, conosceva il
verso del marmo che è il segreto con cui i cavatori, a colpi di
mazza decisi e sicuri, sbozzavano l'opera. Entrambi possedevano la
magica capacità di liberare dal blocco meravigliose sculture. Un
illustre visitatore così dipinse il carattere dei carraresi: “ la
loro indole è assai somigliante al bel marmo in mezzo al quale sono
nati; la materia ne è preziosa e buona, renitente bensì ai colpi
mal diretti, ma altrettanto suscettibile di prestarsi alle più
lodevoli forme sotto la mano, che ne sa' prendere il verso” ( E.
Repetti).
I
CARATTERI CHIMICI DEL MARMO
“ I
caratteri chimici dei marmi risultano composti dalla loro
composizione mineralogica.....I calcari, detti puri, sono costituiti
da carbonato di calcio a cui si associa sempre una quantità più o
meno grande di carbonato di magnesio......Questi marmi sono tanto più
facilmente attaccabili dagli acidi quanto minor quantità di magnesio
contengono. Si sciolgono nell'acido cloridrico ordinario o diluito a
caldo. Siccome non sono mai puri, lasciano sempre un residuo
insolubile dovuto a varie sostanze: al carbonato di magnesia è
meccanicamente mescolato una quantità variabile di sostanze
argillose (caolino) che rimane insolubile. Una parte importante di
detti marmi appartiene ai calcari marnosi”.
L'esempio
che segue inerente alla lavorazione del marmo non è di quelli
calzanti; ma in senso lato chiaro e pratico. “ Riportiamo qui come
si fanno le mine, alla francese, nella lavorazione ordinaria, quando
si vogliono staccare grandi blocchi. Descriviamo esclusivamente come
si ricava la cavità da riempire con la polvere esplodente. Siamo
interessati, esclusivamente, al solo processo di scioglimento del
marmo, traendo partito dalla proprietà che hanno gli acidi
(Muriatico) di scomporre il carbonato di calcio: nell'esempio delle
mine menzionate, vien fatto un foro con il trapano e successivamente,
dovendo allargarlo, vi si versa, con un tubo di gomma, l'acido , il
quale attaccando il marmo fa' sviluppare l'acido carbonico e forma
poi del cloruro di calcio solubile, che può essere prosciugato e
tolto. Si viene a formare una tasca per la polvere esplodente”. Lo
scultore non ha certo bisogno di far esplodere delle mine, ma di
utilizzare un processo simile per scavare in profondità e rilevare
stacchi delicati senza far danni.
Acido
cloridrico.
Non
sempre il ferro è sufficiente per l'intaglio, fosse anche ricurvo e
ben forgiato, in tal guisa da poter penetrare dentro inaccessibili
sotto squadri o trafori nelle profondità del marmo; e neppure
fresette smerigliate, anch'esse sagomate all'uopo, possono essere
determinanti per delicatissimi stacchi. In questi casi si ricorre
all'acido: con le dovute cautele si intinge un pennello, delle
dimensioni adeguate, nell'acido e si passa ripetutamente sulle parti
da eliminare; poi si lascia riposare e ponendo la massima attenzione
sulla quantità di materia da asportare, si smette quando si è tolta
quella grossezza che è ritenuta sufficiente. Indi, si annaffia
abbondantemente la parte coperta dall'acido, ben lavandola e badando
che l'effetto della formazione del cloruro di calcio solubile sia
concluso e che tutto è stato prosciugato.
EQUILIBRIO
DEL CORPO UMANO
La
Ponderatio.
“Nell'arte
Egizia, Assira e Greca primitiva tutte le figure posavano i piedi
simmetricamente allineati. La linea di gravità cadeva in mezzo ad
essi. E' merito di Policleto (V secolo A.C.) la posizione naturale
di equilibrio, detta della gamba libera, la quale concludeva le
ricerche delle sculture arcaiche (Koùros). Policleto, oltre al
canone (il trattato sulle giuste proporzioni), eseguì il Doriforo
detto appunto Kànon che è la dimostrazione visiva del suo trattato
nell'illustrare bene i principi della ponderazione ( la precisa
distribuzione del peso nella posizione verticale asimmetrica ). La
figura non è più sostenuta dalle due gambe, ma poggia su una sola,
la destra, detta portante o tesa, sulla quale grava tutto il peso.
Mentre la sinistra detta flessa o libera, leggermente arretrata,
bilancia il corpo, posando in terra, senza compiere sforzo, solo le
dita del piede”.
“Da
questa posizione naturale di riposo, mantenendo l'equilibrio
prevalentemente sopra un solo piede, la linea di gravità scende
lungo l'arto destro; ne nasce una diversa articolazione delle parti
superiori del corpo: il bacino è inclinato scendendo sulla gamba
flessa, invece il torso, riequilibrando, volge in senso opposto
seguendo la linea delle spalle, che è inclinata. Il braccio destro è
libero, mentre è portante quello sinistro e il collo e la testa
piegheranno verso destra. Sono una serie di relazioni, quelle inverse
della gambe e delle braccia, che danno luogo ad una struttura
armonica (determinata da un incrocio a X detto chiasmo). La gamba
sinistra è a riposo come il braccio destro, mentre la gamba destra è
portante come il braccio sinistro che tiene la lancia. E' un
sapiente gioco di rapporti detto ponderazione perciò immutabile: il
Doriforo rappresenta un modello di equilibrio che rappresenta
l'ideale greco di coerenza razionale; insomma l'ideale di perfetta
proporzionalità”.
STATICA
Quando
una scultura è sbilanciata rispetto al suo centro di gravità, si
dice che non pianta, poiché la sua posizione è errata e fa'
l'effetto di cadere da una parte o dall'altra. Nel posizionare una
statua, gli scalpellini sono particolarmente accorti nell'intaglio
della base (piedistallo). Solitamente, nel metterla nella posizione
eretta, utilizzano, per la perpendicolare il filo a piombo e la
livella: lo scopo è quello di segnare, nella base di appoggio, a mo'
dei praticanti, la linea di un equilibrio stabile, partendo, in
alto, dalla fossetta giugulare verso il basso. Detta fossetta,
seguendo una esperienza tramandata, rappresenta il punto di
corrispondenza nel quale va' posto il filo, la linea a piombo deve
cadere, sempre, sul piano trapezoidale costituito nella base di
appoggio dalla posizione dei piedi. “ Sappiamo: - che il centro
di gravità o baricentro di un corpo è il punto sul quale si
bilanciano, da tutti i lati, le parti del corpo stesso, ed è la zona
più grande e pesante; - che la linea di gravità è una
perpendicolare tracciata da questo punto al suolo”. Abbiamo
osservato che nella stazione eretta simmetrica questa cade in mezzo
ai due piedi. “Si utilizza il filo a piombo come linea di
riferimento (linea a piombo)... perché rappresenta uno standard che
si basa sulla legge naturale di gravità e ci permette di
utilizzarla”. Perciò vanno seguite alcune posizioni mediante le
quali si compie il passaggio dalla stazione eretta simmetrica alla
stazione eretta asimmetrica. In ogni posizioni asimmetriche, il
divaricarsi delle gambe produce un inclinarsi del bacino e un
conseguente spostamento del tronco per riportare la linea di gravità
sulla base di sostegno. La linea del filo a piombo per seguire tali
spostamenti deve fissarsi su un punto preciso: crediamo sia quello
della gamba portante o tesa, puntando direttamente il filo in
corrispondenza del malleolo mediale della tibia. “ Nella posizione
eretta il baricentro cade a livello della 3^ vertebra sacrale. L'asse
del corpo è ortogonale a quello trasversale, che collega le
articolazioni dell'anca e la loro intersezione avviene a livello
della 3^ vertebra sacrale. L'asse del corpo interseca, inoltre,
l'asse trasversale delle articolazioni del ginocchio e quello tibio
- astragalica. Riferendoci alla statica umana, il corpo, nella
postura verticale, ha la necessità fisica di far cadere il
baricentro del peso corporeo su un piano trapezoidale, costituito
dalla posizione dei due piedi con i talloni ravvicinati e le piante
leggermente divaricate. Tale piano viene definito base di appoggio, e
si ottiene unendo i punti di contatto del corpo con il suolo: la
stabilità di un corpo sarà tanto migliore quanto più la base di
appoggio sarà grande e il suo centro di gravità sarà basso. (
Spesso, gli artigiani utilizzano anche un piccolo accorgimento:
secondo alcuni atteggiamenti, danno alla statua pochi millimetri di
leggera pendenza in avanti, poiché la tradizione suggerisce che
adottando una perfetta perpendicolarità, si ha la sensazione che la
figura cada all'indietro). Naturalmente, dobbiamo confrontarci con
diversi atteggiamenti: ad ogni figura appartiene una propria postura
e un diverso punto di vista, con il cambiare delle posizioni e
collocazioni. Permane una regola immutabile: “nei vari
spostamenti, simmetrico e/o asimmetrico, cambiare la posizione
anche di una sola delle parti del corpo, significherebbe cambiare,
contemporaneamente, tutte le altre, fino a raggiungere un nuovo
equilibrio”.
“ L'equilibrio
raggiunto da Policleto, detto ponderazione, è un equilibrio stabile,
ottenuto con un gioco sapiente di rapporti. C'è dunque una serie di
relazioni, la più evidente è quella, inversa, delle gambe e delle
braccia”. “Se la gamba destra è portante, sostiene tutto il
peso, il bacino è inclinato scendendo verso la gamba libera, di
convesso il tronco per contenere tale spostamento, e per riportare la
linea di gravità sul piede destro, si inclina lateralmente dal lato
opposto, producendo una linea concava verso destra. Il centro di
gravità è sempre in un punto all'interno dei piedi. Nell'esempio
detto, è più aderente alla gamba tesa e coincidente con l'interno
del piede di appoggio”.