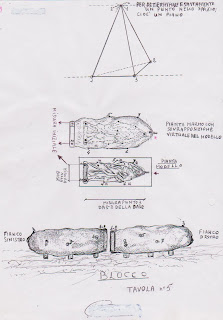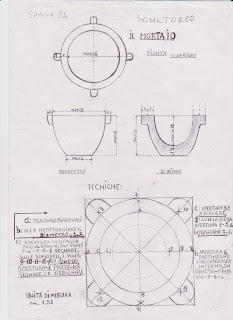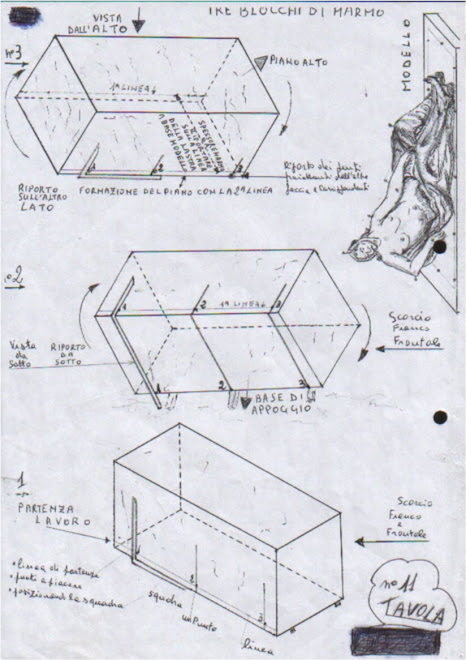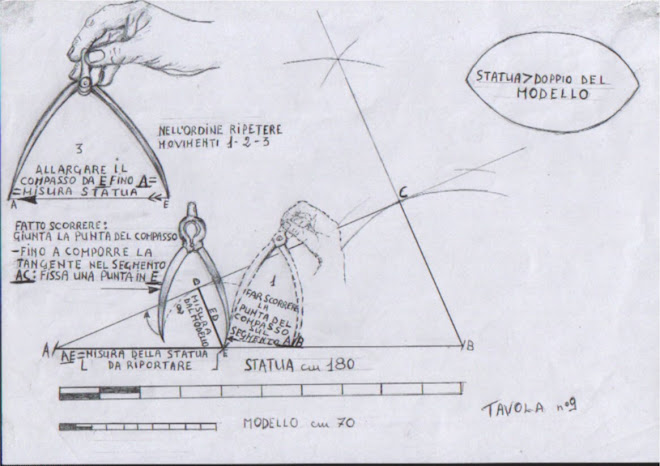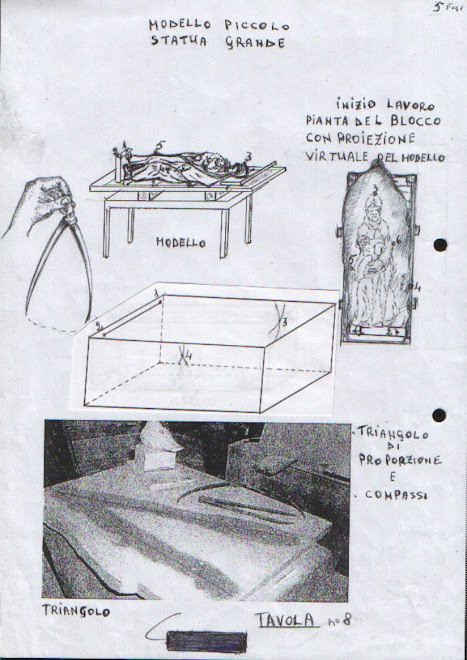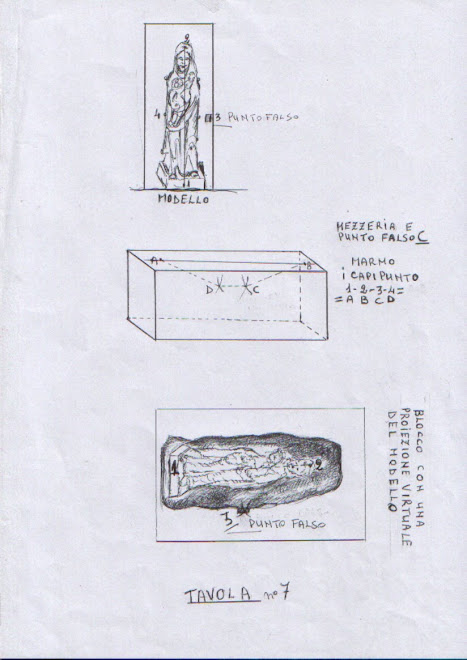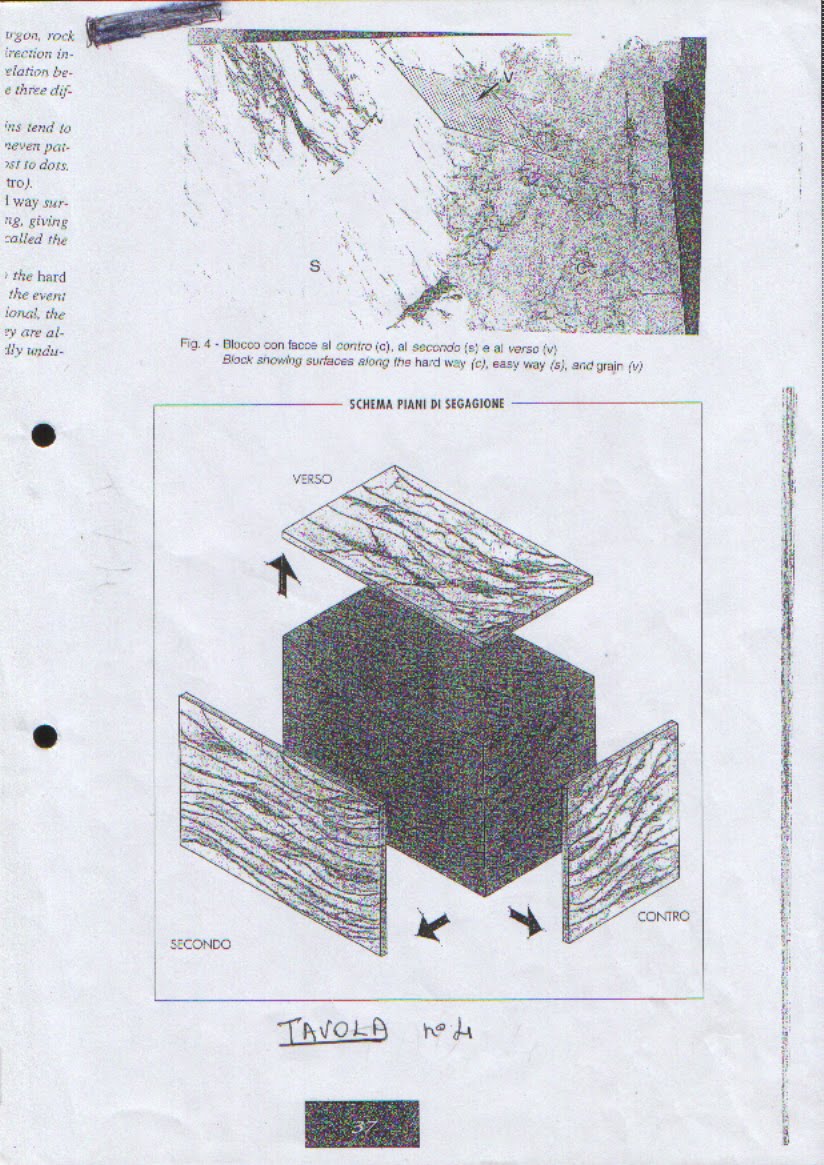INDICE
DEL MANUALE DELLA BUONA SCULTURA: IPOTESI
TECNICHE APERTE ALLO STUDIO E CONTRIBUTO DI TUTTI.
TESI
DI MATURITA' E RIFLESSIONI SULL'ARTE. Seguono: VARI BOZZETTI
(Tabelle).
“Dalla
Tesi di maturità” de “L'Apuano il Giovane”.
INDICE
PAGINE:
1-
2 studio di un prodotto il marmo,
3-4
barocco,
5-6
“700 società in fermento,
7-
8 romanticismo,
9
riflessioni,
10-11
tecniche e significati,
11-12
sistemi di fratture, qualità marmi,
13
tecniche di riproduzione,
14-15
teorema talete,
16-18
preliminari, scandaglio difetti,
18-22
triangolo: tecniche, premessa,
23
tecniche mediana e punto falso,
24
tecnica: 3 punti un solo piano,
30
il piedistallo,
31-32
teorie, la vasca del Vasari,
33
“bodete”, e difficoltà sul triangolo,
35
tecnica triangolo rettangolo,
36
tecniche sconsigliate,
38
evitiamo il marchingegno,
43
tecniche precedenti e arte meccanica,
44
illustrazioni sbozzatura e smodellatura,
49
osservare o contemplare i segni,
64-68
autonomia dell'arte e dominio,
69
eseguire una statua minore del modello,
70-75
pantografo, metodo; poesia,
76-79
precisazioni triangolo isoscele e riduzioni,
80
il bisogno estetico dell'uomo,
96
composizioni, forme chiuse ed aperte,
101
segni,
105
le forme di base,
110-112
il linguaggio del movimento,
113-114
scultura, la poetica, le tecniche, il punto di vista,
117
poetiche in gioco,
121
la materia, le tecniche, i ferri,
124
figure intermedie, analisi,
125
qualità del marmo,
129
affettività della materia e fordismo,
140
l'anima,
142
un punto di vista diverso,
146
i caratteri chimici del marmo,
147
equilibrio del corpo,
149
statica,
152
la postura,
154
biomeccanica. Il centro di gravità,
156
continua postura,
160
consideriamo lo spazio in cui sono posti i solidi,
161
il movimento,
165
lo spregio tra arte moderna e commerciale,
170
la pietra racconta, i segni,
178
il lavoro della scultura,
180
la qualità del marmo,
182
tecniche,
187
strumenti lavorazione a mano,
189
i puntoni,
193
puntoni altra tecnica,
196
il plinto,
198
contemplare il lavoro,
199
precisazioni sui puntoni,
203
osservazioni su compassi e pantografo,
206
sbiancare il marmo robotizzata,
207scultura
uso del robot
210
triangolo isoscele precisazioni,
212
congruità tra modello e statua,
213
e il prolungamento dell'angolo,
214
triangolo rettangolo e isoscele,
218
mortaio, produzione,
220
Canova, bello ideale,
223progetto
per un mortaio
225
tecniche telaio e affini,
234
telaio altre tecniche,
235
una diversa impostazione del telaio,
236
come si può individuare un piano nello spazio,
237
il principio cavalieri,
238
riproduzione sculture, intaglio diretto,
241,
CARRARA, crisi marmo laboratori a rischio,
242
prima ipotesi di uno studio,
243
disegno: esempi di riproduzione (intersezioni),
245
angolo di riduzione e ingrandimenti,
246
rilievi marmorei,
247
inizio smodellatura, tecniche particolari,
252
scale numeriche e grafiche,
253
quoziente di divisione,
256,
le squadre del Vasari,
258
lardo di Colonnata e mortaio,
260
discipline plastiche, intaglio,
261
rilievi a tutto tondo,
264
sculture monumentali e architettoniche,
266
opere realizzate:
266-268
ara gaudium, tallone d'achille,
269
IPSIA MARMO programma,
273
ocelot,
273
la venere delle apuane,
275
l'estasi della libertà, m.me Pagany,
276
la musa addormentata.
TESI
TERZA
Apuano
il giovane
Premessa.
Un masso rotola giù dalla china del "fronte di cava",
dalla diversità del rumore prodotto i nostri vecchi ne deducevano la
qualità del marmo e la compattezza del filone. Anche l'acqua, fatta
scorrere sui banchi, a seconda della sua minore o maggiore
permeabilità, denunciava possibili difetti e venature. La necessità
di produrre tagli paralleli al piano di sedimentazione, a gradoni,
per l'estrazione di blocchi interi, imponeva l'obbligo di avere un
livello di riferimento. Questo nel racconto dei cavatori di un tempo,
non poteva che essere l'orizzonte, come campo visivo opportunamente
traguardato.
Cosicché
molte delle operazioni e dei problemi venivano risolti con una buona
dose di empirismo, nonostante l'affacciarsi già dei primi mezzi
meccanici ed il metodo del filo elicoidale. Nel breve volgere di
pochi lustri, l'estrazione del marmo ha conosciuto una vera e propria
rivoluzione, tale da sconvolgere tutti i sistemi di lavorazione ed
anche le finalità d'uso del marmo stesso. Le ferite nelle nostre
montagne sono sempre più evidenti, a vista d'occhio, giorno dopo
giorno, così pure l'aspetto paesaggistico. Ciò è dovuto alla
grandissima quantità di marmo prelevato, contemporaneamente
all'impiego di potenti mezzi tecno-meccanici. IL risultato è la
distruzione, a breve, di un patrimonio insostituibile e non
riproducibile.
Un
materiale nobile, il marmo di Carrara, che per le sue caratteristiche
e lavorabilità ha il suo naturale impiego nella scultura, in
architettura, nell'ornato, così come testimoniano le grandi opere
del passato.
LO
STUDIO DI UN PRODOTTO - IL MARMO - CHE, GRAZIE AL SUO UTILIZZO
ARTISTICO, E' RAPPORTATO AD UN EPOCA STORICA DI RILEVANZA
ECONOMICO-SOCIALE [MA]
CONDIZIONATO DAI RAPPORTI CON I POTERI COSTITUITI NEI SECOLI
Mi
vengono spontanee alcune domande: cosa sarebbe, oggi, Carrara senza
la preziosità dei suoi bacini? Quale sarà il suo sviluppo futuro,
quando professionalità, tecniche, mestieri e saperi scompariranno
definitivamente? E' in corso una gestione monopolistica delle cave
che privilegia la rendita e la fuga di notevoli quantità di capitali
dalla città, a dispetto di quella che è sempre più considerata una
modesta periferia funzionale solo ad assicurare ampi margini di
profitto: altro che “capitale mondiale del marmo “ , è il
capitale locale di pochi. Il prodotto finito e artistico è
abbandonato all'iniziativa di pochi, declassando un sistema di
relazioni culturali e produttive nei settori artigianali, industriali
e nell'indotto; i quali in passato hanno contribuito ad elevare
Carrara come città d'arte. La strategica presenza di ben tre
istituzioni scolastiche, l'Istituto del Marmo, il Liceo Artistico,
L'Accademia , non hanno più un ruolo interattivo e si avviano a
produrre un'istruzione fine a sé stessa. Ne' il ricordo di illustri
presenze del passato, né quelle attuali, piuttosto rare, risolvono
il problema tradizionale/ereditario.
Molto
si è detto sulla presenza di Michelangelo a Carrara, alla ricerca
dei blocchi migliori, e molto di più è stato detto su tale
commercio e dei rispettivi atti notarili. Ciò che è rimasto in
ombra è la fiducia che il Maestro nutriva nelle maestranze
carraresi; fiducia pare ben riposta, considerata la meticolosità
delle sue richieste per le forniture. Già prima del "500 era
conosciuta la perizia delle nostre maestranze nello scandaglio e
nello sgrossare, poiché le difficoltà di trasporto obbligavano i
nostri predecessori ad effettuare gran parte del lavoro in cava:
capitelli, colonne, statue, ecc...
Sembra
certo che figure sbozzate fossero richieste da Michelangelo stesso. E
la sbozzatura richiede abilità e conoscenza dei materiali: non solo
per portare la figura più aderente alle misure del modello, ma anche
per evitare difetti,venature, luzche, che ne avrebbero deturpato la
finitura. Da ciò nasce la nostra struttura artigianale: cavatori,
scalpellini, smodellatori e scultori rifinitori; insieme ad altre
mansioni complementari: sbozzatori, il pannista (indumenti),
ornatisti (elementi floreali, capelli, decorazioni); poi
accessoristi, raspatori e lucidatori. Figure considerate minori, ma
non secondarie nella buona riuscita di un lavoro; figure sempre in
ombra rispetto ai primi piani dell'artista, ma che stanno lentamente
scomparendo con la decadenza della realtà artistica carrarese.
Mi
sembra importante, di seguito, indicare alcuni periodi che hanno
caratterizzato la scultura della mia città e rappresentato, nei
secoli, la sua principale rendita.
IL
BAROCCO IN ITALIA
(Le
storie del marmo sono anche vicende di grandezza e miseria)
Dal
predominio Spagnolo e l'età della Controriforma, l'oppressione
politica e lo sfruttamento economico, soffocando ogni libertà,
determinano un grave stato di disordine e miseria (1559-1713). Al
"600 appartengono scienziati e pensatori inquisiti per le loro
efficaci ed originali teorie, annuncianti l'era moderna. Mentre gli
altri paesi europei, in quegli anni, crescono in potenza economica, e
una nuova classe borghese, oltre a costruire una civiltà
all'avanguardia, attua un profondo rinnovamento delle lettere e delle
arti. L'affermazione del Barocco arte pomposa e teatrale volta ad
impressionare, sospinta dalla chiesa ormai trionfante sulla riforma,
impone questa risposta mediatica dagli effetti illusionistici e
monumentali. Furono soprattutto l'arte e gli artisti italiani, in
particolare carraresi, a beneficiare del rinnovato potere della
chiesa cattolica , che divenne la principale fonte di commissioni, in
primis Roma si fece metropoli d'arte. Questo impegno saturo di
intenti propagandistici e auto celebrativi erano in grado
d'influenzare le emozioni, puntando sul potere persuasivo del bello.
Così’ come Michelangelo, anche G.L. Bernini, ispirandosi alla
magnificenza della fede, si servì delle maestranze carraresi.
Soprattutto di Giuliano Finelli.
IL
" 700
UNA
SOCIETA' IN FERMENTO TRA RINNOVAMENTO E RIFORMA
Ciò
a seguito di una profonda trasformazione della società e del forte
impulso alle nuove idee ed all'inarrestabile sviluppo del pensiero
scientifico, destinati a creare esigenze e condizioni di vita
radicalmente diverse; contemporaneamente, la soluzione dei problemi
tecnici e la creazione di nuove macchine, agevolarono l'attività
degli operai. Con l'avvento di nuove industrie si diffonde un grande
ottimismo. Nasce l'era moderna , prima in Inghilterra poi in Francia,
con il sorgere di una nuova atmosfera culturale detta Illuminismo,
che libera le menti dalle tenebre e dalle superstizione: conoscere ed
imparare, una possibilità aperta a tutti per poter criticare tutto.
Le nuove conquiste scientifiche ed industriali diffusero un grande
ottimismo, posero l'uomo al centro di un forte e vivo processo di
rinnovamento, con la certezza di modificare la propria vita,
conquistando felicità e progresso ( ma ciò non si avvererà mai).
La nascente borghesia guidava questo processo: diritti e valori,
uguaglianze, divennero una potente arma politica per difendere la
dignità dell'uomo. Libertà in tutti i campi: politico,economico,
culturale. Dunque libertà anche nei commerci e nell'arte, di
pensiero e di stampa. Contro il vecchio assolutismo tutte le porte
furono aperte, anche nei confronti della vecchia committenza nella
produzione artistica. La parola magica del libero mercato divenne
sinonimo di una libera espressione non più deferente ma in libera
concorrenza contro il monopolio della chiesa. Si affermò in questo
contesto l'esigenza di un'arte chiara guidata dall'intelletto,
riscoprendo - in contrapposizione al barocco - il modello classico
Greco-Romano. Sorge il neoclassicismo.
E'
il periodo (dalla seconda metà del secolo XVII) in cui affiora,
meglio di altri, la perfetta riproduzione di opere ispirate
all'antichità, piegata più alle esigenze del mercato
collezionistico e antiquario . E' un periodo aureo per Carrara. [
I CARRARESI A ROMA, opere degli scultori dal “600 ai giorni nostri.
BENEO].
Alla
ricerca del bello ideale, anzi di inventare la bellezza, si ispirò
Canova, rispecchiando fedelmente le teorie espressive di J.
Winckelmann: “l'arte come modello di virtù, e un rinnovamento
ritrovato nei principi di razionalità, funzionalità e semplicità
espositiva”. Anche Canova lasciava la fase preparatoria ai nostri
artigiani. La sua tecnica individuava quattro fasi:
1)
disegni preparatori; 2) modello in creta a cui faceva seguito il
calco in gesso; 3) sbozzatori e smodellatori, con il sistema dei
punti e del triangolo di proporzione, e lo scultore che li spianava
fino al quasi finito, consegnavano l'opera nelle mani del Maestro. 4)
L'ultimissima fase era curata dal Canova: consisteva negli ultimi
ritocchi e nella levigatura e lucidatura dell'opera, terminando con
una distesa di cera in tutta la superficie. Il Canova interveniva nei
suoi lavori anche dopo lunghi intervalli di tempo, fino a quando non
era pienamente soddisfatto.
(
Questa impostazione, preparazione del modellino in gesso, è anche la
scelta di molti artisti contemporanei, sia per la lavorazione in
marmo che in bronzo).
Ma
già il gusto neoclassico stava cambiando, con le prime proposte
romantiche e realiste, anche se il retaggio neoclassico era duro a
morire, mentre processi stilistici e nuove correnti cominciarono a
gettare le fondamenta di quella che sarà l'arte d'avanguardia.
IL
ROMANTICISMO
La
sensibilità romantica nasce dalle rovine della Rivoluzione francese
e con essa del progetto illuminista. La ragione non era più in grado
di soddisfare la totalità dell'esperienza umana, nasceva così il
mito dell'anima, riaffermando l'esistenza di un centro interno.
"Assai
scarsi sono i risultati artistici nel campo della scultura, non
soltanto in Italia ma anche fuori". La critica è avara di
citazioni, fatta eccezione per Lorenzo Bartolini, che dal 1816 al
1826 intrattiene rapporti con lo studio Lazzerini in Carrara,
mostrando, nei suoi contatti epistolari, una notevole fiducia nelle "
capacità tecniche ed interpretative delle nostre maestranze".
Infatti, in un incarico a Roberto Lazzerini, richiede la riproduzione
di due sue opere "debolmente modellate"; per poi
congratularsi, a lavoro terminato, del buon marmo e della perfetta
esecuzione". L'apprezzamento per le nostre maestranze era
notevole, a tal punto che Arturo Martini confessò: "tant'è
vero che tre quarti degli artisti mandano qui degli incompiuti
modelli,fidando di trovare a Carrara i geni che rimettono a posto le
loro magagne".. poiché in effetti sono .."degli autentici
stradivari". [
Scultura a Carrara, OTTOCENTO ].
Nonostante
una ricca produzione di opere, prevalentemente a Carrara come a Roma
- ma anche nel resto d'Italia e all'estero - non vi è alcun cenno
dei raffinati artisti che nel periodo Barocco ed in quello
intermedio, tra neoclassicismo e romanticismo, ricoprono un periodo
importante del "900 ed oltre. Una storia, insomma, che sembra
svanita nel nulla: prima di tutto nel sentire dei suo cittadini, e
nel vivere della città, come gruppo sociale che vi appartiene, a
tutto tondo direi. Non più il ritmar dei suoni materici nei cento e
più laboratori sparsi ovunque, anche nel centro storico; si perdono
i saperi che hanno impastato il nostro linguaggio di modi di dire
nell'ironia come nelle metafore: "lu lí i a 'l kóntr 'n
tésta"; " avér i oći a kul d' subia ". E nulla e
poco rimane, è rimasto, del passaggio di artisti illustri.
RIFLESSIONI
CARRARA
rinomata per la qualità del suo marmo, deve la sua celebrità alla
grande fama dei suoi clienti ed al conseguente settore commerciale,
assai meno all'importante mestiere della scultura. Sensibilità ed
abilità artigianale sono spesso ignorate, attuando una separazione
netta tra fedeli tecniche di riproduzione e creazione artistica.
Chi
lavora il marmo sa bene che, al di là delle capacità migliori,
esiste un trasporto soggettivo, personalissimo: è un particolare
modo di intagliare il marmo, con diversi passaggi da un utensile
all'altro, che può dare freschezza od opacità al lavoro,
promuovendo illusioni lineari o chiaroscurali diverse. Non solo: lo
stesso artigiano non riesce a fare una copia uguale all'altra, pur
utilizzando gli stessi strumenti e materiali. I mezzi espressivi non
sono immutabili ed uguali nel tempo, così pure la tecnica e la
manualità.
Il
marmo è un materiale nobile, da tutti considerato fonte di
particolari forme espressive. La sua compattezza, unita all'unicità
delle sue caratteristiche estetiche (struttura cristallina e
trasparente), sono naturali sorgenti di bellezza. Qui incide il
mestiere: un meraviglioso incontro di sensibilità ; un avvincente
dialogo tra l'uomo e la materia, nel dar luce, colore, brillantezza;
nell'impastare un modellato anziché un altro, oppure levigarlo o
lucidarlo. Colori e masse assumono un significato; ma è come
concepiamo il protagonismo della materia e la sua predisposizione ad
immergersi nella luce, quale materia scolpita, in grappoli di
significanti che assumono una direzione del senso. È nella
corposità, nella delicatezza dello sfumato, che, con maggiore o
minore luminosità, la luce, scivola in armonia sulle opere scolpite.
Ed è sempre la stessa che ci presenta, nel modo voluto, come un
corpo occupa o trasforma uno spazio.
#
. Se
il sistema commerciale, per ragioni di lucro ha spesso messo in ombra
gli esecutori rispetto alla figura dell'artista, ideatore dell'opera,
Carrara si è onorata della presenza di intere dinastie dedite al
mestiere della scultura, che all'interno delle loro botteghe hanno
allevato fior di maestranze. Le vicende e le vie del marmo sono
alquanto tortuose ad iniziare dal " 400, che vede accanto ad
artisti minori, meno conosciuti e mal pagati, una moltitudine di
elaborati che hanno ben arricchito il nostro territorio e fuori di
esso. Anche allorquando le richieste provenivano da una committenza
con modeste risorse finanziarie.
Il
recupero effettuato da CATERINA RAPETTI, con le sue "Storie di
marmo", merita un cenno ed una dovuta consultazione #
.
TECNICHE
E SIGNIFICATI
"
La parola marmo è usata a denotare calcari che si dicono solitamente
cristallini, cioè le rocce formate da un aggregato omogeneo di grani
di calcite... Fra i marmi statuari, i paonazzi, i venati, i
biancochiari ed i bardigli, passa la diversità di struttura
nell'impasto generale del calcare marmoreo: per cui, nel marmo
statuario più puro, non si troveranno, nella sua massa, che
pochissime macchiette e sparse venature" . Le pietre non vengono
più indicate come nell'antichità, sotto la parola marmo. Almeno
quelle che superano in durezza lo statuario. Ciò in base alla loro
lavorabilità: la proprietà che ha il marmo di lasciarsi segare,
scolpire e lucidare per mezzo di strumenti adatti. Perciò i marmi
apuani, con la loro finezza di grana, vanno distinti, per la loro
scolpibilità in confronto dei loro omologhi. Mentre la durevolezza è
la proprietà che hanno di conservarsi più o meno inalterati sotto
l'azione degli agenti atmosferici.
Nel
linguaggio comune i marmi si distinguono in crudi o fieri, deboli o
fragili. Il marmo crudo, detto anche fresco, appena estratto dalle
cave, si mantiene così per lungo tempo, anche alle intemperie.
Infatti un blocco ed un lastrame fresco, quando sono isolati e
percossi, le loro vibrazioni emettono un suono cristallino. Mentre ad
un minor grado di freschezza e di coesione, i marmi danno un suono
pastoso e gradevole; quelli cotti un suono sordo. La minore o
maggiore resistenza del marmo non è solo riferita alla sua qualità,
ma anche rispetto alla sua sedimentazione.
SISTEMI
DI FRATTURE
Se
i banchi marmiferi sono cristallizzati in modo perfetto, i "peli"
che attraversano il marmo sono disposti in maniera favorevole,
possono essere seguiti su due o tre piani di stratificazione o
fratture, tra loro grosso modo perpendicolari: "il pelo al
verso", di più facile distacco, segue il piano di
sedimentazione; "i peli al contro", verticali alla reale
stratificazione, sono orientati secondo la direzione di questa (dei
banchi); mentre "i peli al secondo sono diretti in un piano
perpendicolare ai primi due, seguendo l'inclinazione dell'insieme (la
pendenza).
I
PELI
I
peli furbi: microfratture chiuse che si aprono durante la lavorazione
o dopo la messa in opera; fratture appena percettibili sulla
superficie dei blocchi. Sovente di lunghezza notevole orientata in
una direzione qualsiasi.
I
peli ciechi: microfratture interne al blocco, pelo occulto, che non
sempre si riesce a rilevarlo.
Ognuno
di noi che inizia una qualsiasi lavorazione, oltre a scandagliare il
blocco, nel senso delle misure, è obbligato ad indagarlo in tutta la
sua dimensione; così lo si bagna con l'acqua e lo si guarda mentre
asciuga: laddove si compie l'asciugamento - se esiste un pelo o una
luccica in superficie (non immarmata) - lungo la linea di questi
appare una traccia di umidità; è l'acqua che vi è penetrata e
stenta ad asciugare. Generalmente il marmo che è intorno al pelo è
soffuso di una tintarella giallastra, rossiccia o brunastra. Questa
colorazione è dovuta alla presenza di materie eterogenee che
attraverso l'umidità sono state assorbite dal marmo lungo il pelo.
E' una spia che tradisce la presenza di peli generalmente serrati ed
invisibili. Però chi lavora il marmo si avverte subito se si imbatte
in un pelo: perché quando vi penetra il ferro la scaglia rimane
tronca, esponendo una discontinuità nella materia. Nei blocchi
greggi questi difetti vanno purgati (eliminati seguendone la
traccia). Solo dopo si ha la maggior certezza di un lavoro sicuro. La
bagnatura, inoltre, ci dà un'idea dell'aspetto che assumerà il
marmo a prodotto finito.
TECNICHE
DI RIPRODUZIONE DELLE STATUE IN MARMO
Utilizzo
dei compassi nella scultura.
“
Generalmente
le statue si riproducono in marmo da piccoli modelli in gesso, in
scala di proporzione. Può accadere, diversamente, di eseguire una
statua di grandezza minore del modello”. In tutti i casi è
necessario assimilare il concetto di solido geometrico che, la
scienza della geometria, studiando lo spazio occupato, esprime due
proprietà: la forma e l'estensione ( il volume nelle tre dimensioni:
altezza, larghezza, lunghezza ). Ogni figura solida è un insieme
infinito di punti, che “non sono tutti situati nello stesso piano”.
Poiché nello spazio essi si identificano su infiniti piani, come
potremo individuare ognuno di essi?
Per
far ciò occorre attuare, con i compassi, tre diverse intersezioni,
prese da altri tre punti presenti preventivamente sul modello e
strategicamente predisposti in funzione del triangolo di proporzione,
se la statua da eseguirsi non è di misura uguale al modello. È
ovvio che sul modello vanno predisposti, sempre e strategicamente
tutti i capi punto necessari.
TEOREMA
DI TALETE. - Utilizzo del triangolo di proporzione -.
“
In
un triangolo rette parallele ad uno dei lati dividono gli altri due
in parti fra loro proporzionali”.
Consideriamo
ora un fascio di rette parallele tagliate da due trasversali, se
prolunghiamo queste due semirette, fino al loro punto di incontro
detto origine, la nuova figura, così ottenuta, assumerà il disegno
di un triangolo. A tal punto che, la stessa, diventerà un insieme di
triangoli: sequenza proporzionale e congrua di segmenti ed angoli,
che saranno tanto numerosi quanto ne saranno prodotti dalle
molteplici parallele ivi predisposte, in sequenza a partire da un
vertice 0 (detto origine). Quindi, le rette che uniscono, coppie
di segmenti corrispondenti, sulle due trasversali, formano con
l'angolo O triangoli simili. Teorema di Talete: “ un fascio di
rette parallele determina su due trasversali due insiemi di segmenti
tra loro direttamente proporzionali”.
Dei
triangoli, prenderò in considerazione solo i loro rapporti di
similitudine ( lati corrispondenti in proporzione e angoli fra loro
congruenti). Simili, ma non uguali, cioè non sovrapponibili e
combacianti; e neppure equivalenti perché uno più esteso
dell'altro.
Si
dicono simili solo due o più figure di uguale FORMA, come lo sono i
diversi ingrandimenti di una stessa fotografia o un disegno visto con
la lente di ingrandimento. Ciò per mettere in evidenza un teorema di
Talete: " In un triangolo la parallela ad uno dei lati, che
incontra gli altri due, li divide in parti proporzionali",
originando due triangoli simili. In maniera più esplicita: i
quattro segmenti dati ordinatamente in quella divisione dei lati,
sono in proporzione, poiché il rapporto dei primi due è uguale al
rapporto degli altri due, e il prodotto dei loro medi è uguale a
quello dei loro estremi. Questo rapporto è un valore costante,
dato da angoli ordinatamente uguali e lati corrispondenti
proporzionali. Rammento queste elementari nozioni scolastiche utili,
nel prosieguo delle illustrazioni tecniche, al calcolo dei rapporti
in scala. E' evidente che il rapporto fra due numeri, presi in un
certo ordine, è il quoziente della loro divisione espresso mediante
diverse scritture es: 1/2 , 1: 2, 0,5. Due rapporti si dicono uguali
se hanno lo stesso valore, mentre si definisce proporzione
l'uguaglianza di due rapporti ( a:b = c:d ). Che cosa si vuole
indicare? Esiste una semplice relazione, singole misure prese con il
triangolo di proporzione, ad esempio sul modello, possono essere
sviluppate nella scala stabilita e trasportate su un elaborato ( es.
una statua ). In questo caso dobbiamo considerare la particolarità
dell'esecuzione rispetto ad un qualunque disegno geometrico. Nel
disegno l'ingrandimento o la riduzione, si possono fare tracciando,
nella scala grafica dell'angolo o triangolo di proporzione, tante
parallele quante sono le misure da trasferire, da un disegno
all'altro. Ma in una statua lo smodellatore ( detto anche puntatore )
deve trasferire migliaia di punti e non può segnare una moltitudine
di rette senza creare un grande confusione nel detto triangolo.
Consideriamo che per fissare un punto sul marmo vanno prese tre
diverse misure, se vogliamo definire esattamente la sua posizione (
il suo piano ) nello spazio. Una figura geometrica si dice piana
quando tutti i suoi punti sono situati nello stesso piano; al
contrario, si dice solida quando i suoi punti - non - sono tutti
situati nello stesso piano. E' evidente che il nostro smodellatore
non opera su una figura piana ma su un solido contenuto nello spazio.
E' come se tutte le volte, nel trasferire un punto, dovesse
determinare il vertice di una piramide, su base triangolare: con i
compassi, sempre in proporzione, trova, prima la sua base ( lunghezza
e profondità ), poi la sua altezza. Più il modello è tempestato di
punti, più la riproduzione sarà fedele.
PRELIMINARI:
lo smodellatore sceglie il blocco più adatto, lo scandaglia per
vedere se contiene, e come, il modello; questi, va posto sul piano
lastra in modo da disegnarne il perimetro, nella postura migliore e
più utile, affinché, raffrontandosi con il marmo, non risulti né
scarso né troppo abbondante. Nella presente tecnica, il
procedimento prevede che lo stesso contorno sia disegnato in
prossimità degli spigoli di base del blocco; mentre in altre si usa
la partenza del piano in alto. Inizialmente, lo scopo palese è
quello di riportare i relativi perimetri in proporzione e nella
medesima posizione, oltreché il volume del blocco più attinente
alla dimensioni della statua da farsi, dovendosi eliminare lo sfrido,
se troppo in eccesso. Dopodiché il marmo lo si ispeziona in tutte
le sue parti lavandolo con acqua. La bagnatura serve a mettere in
evidenza le possibili macchie, che potrebbero deturpare il lavoro
finito; oppure eventuali peli, altri difetti e lucciconi. I peli e
gli strappi vanno purgati, mentre macchie e lucciconi dovranno, se
possibile, essere evitati o nascosti nella sbozzatura. Il blocco
scelto è rifiutato, se non sono eliminabili i difetti che ne
potrebbero compromettere l'opera. COMINCIAMO a studiare il lavoro: a)
lo scolpire è si l'arte del cavare, ma con criterio, aggiungo. Vanno
individuati i piani, maggiormente in rilievo delle figure, partendo
da quelli più alti. Consideriamo che ogni opera ha la sua posizione
nello spazio, dobbiamo semplificarla, nel nostro immaginario,
rapportandola, il più possibile, ad un'insieme di forme geometriche
(composizioni sferiche, coniche, articolazioni triangolari o
romboidali, ecc.. ), il tutto simile ad un abbozzo.
b)
Il modello di solito è fissato su un piano costituito da una lastra,
all'interno di uno schema rettangolare ( semplifico: comunque
riconducibile a questo o altro perimetro). Anche il blocco è
orizzontale; un'attenta osservazione ci consiglia come lavorarlo nel
perimetro prefigurato dal modello-lastra-capipunto. Ciò per evitare
che delle possibili macchie possano finire in quelle parti della
figura più visibili o importanti; ma anche per sfruttare meglio il
contro, per collocarvi, eventualmente, quelle articolazioni
sbilanciate o staccate dal tronco e perciò più fragili ( es.
braccia, mani, ecc. Immaginiamo la debolezza della pedata di uno
scalino se questa fosse collocata al verso).
IL
nostro punto di partenza è sempre un piano, come identico è il
nostro punto di vista, che focalizza due forme, supine, in pianta,
statua/modello. Posizione della statua supina, oppure eretta
[potrebbe
anche essere lavorata nella posizione eretta],
posizione che normalmente assumerà a lavorazione finita. I piani
sono identificabili, nel nostro esempio, con tre punti non allineati,
una retta ed un punto fuori di essa [in
modo diverso, con due
rette incidenti, o due rette parallele.]
L'uso
dei compassi, quindi, è più pratico. Operiamo secondo il teorema di
Talete esclusivamente sul triangolo rettangolo o isoscele.
TECNICHE
(PREMESSA)
Nell'uso
dei compassi si prevedono più casi: - notoria la semplificazione di
quelle che escludono il triangolo di proporzione, quando si debbano
eseguire statue di dimensioni uguali o doppie del modello. Al solito,
eseguendole maggiori del modello, si utilizzano, con il triangolo,
particolari tecniche. L'una, più facile, è possibile solo nel caso
in cui l'altezza della statua è minore del doppio del modello (
operiamo su un triangolo isoscele). Più usuali, altre tecniche, in
cui il trasferimento dei punti si fa su grandezze variabili.
Illustreremo, in un capitolo a parte, queste particolari lavorazioni
rispetto al modello. Particolare è il riporto nell'esecuzione di una
statua più piccola del modello (in riduzione ).
Nel
primo caso, in scala 1:1, è sufficiente riportare, pari - pari, le
misure del modello o raddoppiarle per duplicare, tra le altre, una
tecnica sul triangolo isoscele è possibile solo se Il modello SUPERA
la metà della statua da farsi. E' evidente che per effettuare, da
A-B, l'intersezione, la misura del modello dovrà superare la metà
dell'altezza della statua: poniamo che questa sia, nel nostro
esempio, di cm 160; a fronte di un modello di cm 100: sia cm160:2 =
cm 80<100 -="" a="" altezza="" annerita="" b="" carboncino="" che="" con="" da="" della="" di="" ed="" erba="" eseguirsi:="" grassa="" il="" l="" la="" lastra="" lavoro="" linea="" maggiore="" marmo="" met="" modo="" nbsp="" nel="" opportunamente="" porter="" procede="" punteruolo="" quale="" rdi="" seguente:="" si="" statua.="" statua="" su="" sulla="" traccia="" una="" v="">si
avrà il segmento AB ( cm 160 ). Poi, con apertura di compasso uguale
all'altezza del modello ( cm. 100 ), si fa centro in A e B
descrivendo due archi che si intersecheranno in C. Da C, sempre con
il punteruolo, si tracciano due linee che si congiungono con A e B
( ACB sarà il nostro triangolo isoscele). Allora presa una misura
sul modello, con il compasso si riporta in A C, facciamo che essa sia
AD: tenendo fissa una punta in (D) si porta l'altra punta, sempre con
apertura uguale ad AD, su AB in (E): allungando la forbice, la EA
sarà la nostra misura che si deve trasportare sul blocco. Così, con
il doppio passo, si riportano tutte le altre misure (vedi TAVOLA n. 6
). Inizia così il posizionamento dei capi-punto, che saranno la
guida tecnica più sicura e permanente dello smodellatore. I capi-
punto sono fissati, come già detto, nelle parti più emergenti del
modello; ma anche dove possono essere strategici per puntare la
figura di rilevazioni. Rammento che i compassi lavorano in maniera
più precisa quando si intersecano, il più vicino possibile,
all'angolo di 90°. Questi i passaggi permanenti e ripetuti: misura
dal modello, riporto sul triangolo, trasporto della misura
proporzionata sul blocco. Questo, però, non sempre è “ squadrato
“, può essere un informe; allora meglio spianarlo, almeno sul
piano alto, e adeguarlo alla dimensione voluta ed utile, simile a
quella di solido geometrico conforme al particolare posizionamento
del modello. Si inizia così l'attacco principale in una delle facce
del blocco, in alto o in basso; o dal suo perimetro limitrofo alla
base, entrambi omologhi a quelli del modello, nel rispetto della
proporzione scelta. Per l'intaglio, la postura del modello è scelta
a seconda dell'atteggiamento figurato della scultura: può poggiare
sulla sua stessa base, come essere adagiata orizzontalmente su un
piano lastra o composta su un usuale banco; comunque predisposta in
maniera funzionale allo sbozzo e smodellatura. Ciò privilegia il
piano di attacco, preminente per fissare i primi fondamentali capi
punto. Ottimale è sempre, quel blocco che, tagliato e sagomato
secondo la forma del modello, agevola il primo intervento.
Normalmente un blocco squadrato, con gli spigoli laterali
perpendicolari ai piani delle basi, si presenta nelle condizioni
ottimali per una pronta applicazione tecnica, di partenza e miglior
prosieguo.
LA
PARTENZA DALLA SBOZZATURA, con i primi capi punto di partenza.
In
una tecnica il perimetro intorno al modello, sia esso inciso sulla
sua base che incluso nel piano lastra, va alla pari riprodotto, nel
marmo, secondo i rispettivi attacchi, predisposti nel piano di
lavorazione. Sarà, anche, un riferimento per l'intaglio ed il
riporto dei capi punto di partenza.
L'altra
tecnica, con una figura sempre supina - il marmo è stabilmente
conforme alla posizione del modello: si prevede una funzione della
base, che, lavorata e spianata a mo di un poligono regolare,
predispone il piedistallo della statua, nel migliore dei modi per
impostare il piano di partenza, rappresentato dalla faccia superiore
del marmo.
Nel
primo caso, invece, necessitano la disponibilità delle facce
laterali, per segnarvi lo stesso perimetro già predisposto intorno
al modello, sempre in scala.
L'importanza
dei piani: ragioniamo convenientemente su un modello in posizione
orizzontale che, visto in pianta, secondo l'attacco principale,
assume la forma di una figura piana all'interno di un perimetro del
quale ne immaginiamo le tre dimensioni uscenti dai suoi vertici di
base. Questo per il modello. Mentre nel blocco le facce laterali e le
basi sviluppano naturalmente e concretamente le dimensioni del
volume.
Riprendiamo
alcune tecniche GIA' ANNUNCIATE per l'esecuzione di elaborati di
altezza maggiori di quelle del modello.
Iniziano
dal secondo, preparazione dal piano in alto.
Sulla
faccia superiore del blocco e su quella virtuale del modello –
recepita, di solito, dai tre capi punto -, si individua la linea di
mezzo che taglia in due parti la figura, ma che allo stesso tempo
divide i due poligoni. È una linea reale che segna parti di piano
del modello e del marmo, longitudinalmente, e che viene delimitata
alle estremità, in qualità di capi punto estremi, da due chiodi a
testa piatta, conficcati nel gesso. Mentre nel marmo si possono
indicare con due fori fatti col punteruolo. [spesso,
in questi fori del marmo, per evitarne l'usura, è prassi inserire i
chiodi su indicati,
all'uopo amputati vicino alla capocchia, distanziati da essa di 5/6
millimetri, e fissarli col mastice. Tutti i chiodi saranno forati
sulla testa in modo da poter ospitare le punte dei compassi e render
più ferme e precise le misure.]
Il
fine è quello di rendere visibile, tutte, le manovre possibili,
posizionando la figura nello spazio utile dato e funzionale alla sua
riproduzione. Poi lo smodellatore a furia di punti riproduce nel
marmo gli stessi ed i piani della figura, iniziando da quelli
emergenti : dallo sbozzo e, via via, sempre più aderenti alla forma
finita.
SEGUE:TECNICA
della linea MEDIANA o DI MEZZERIA.
E
DEL PUNTO FALSO. (E' possibile utilizzare a piacere il triangolo
isoscele o rettangolo; sempreché lo consentano, il rapporto in scala
delle rispettive altezze.).
Abbiamo
già considerato i capi-punto alle estremità del modello sulla linea
di mezzo, nel corso della sua altezza ( uno ai piedi, uno alla testa
). Detta linea retta sarà parallela “all'orizzontale” in fedeltà
alla livella. Ora cominciamo a fissare i punti 1 e 2 sul blocco: si
prenderà, con i compassi, la misura 1-2 dal modello, debitamente
aumentata col triangolo di proporzione e la si riporterà sul marmo.
Ciò fatto non abbiamo ancora individuato il nostro piano che si
troverà con il punto 3, ancora da fissare: lo si farà, a ritroso,
dal marmo al modello, posizionando, se non è presente, su
quest'ultimo, un chiodo a testa larga ( capo punto). Operiamo, come
si è detto, a rovescio, partendo dai punti 1-2 del marmo: su esso
proviamo tutte le intersezione possibili aprendo i compassi su 1 e 2
verso una faccia laterale, acuendo il nostro ingegno per trovare la
giusta posizione del punto 3. Siamo con la mezzeria su un piano, ma
le nostre necessità sono quelle delle dimensioni della prospettiva
assonometrica: altezza, larghezza, profondità. Quest'ultima ci manca
e va trovata nello spessore del blocco, poiché è la nostra miglior
cala, quale terza misura che individua il punto 3 nello spazio.
Operiamo più manovre - che ci consentono di calibrare, il punto <3>
mediando tra il marmo e il modello-, per la giusta posizione della
linea <1 2="" e=""> , avvicinandola o allontanandola dal fianco del
blocco, fintantoché non si è trovato la posizione ottimale del <3>
nel volume o “dimensioni” del marmo. Ottimale perché si è
scandagliato e trovato - nello spazio compreso tra i due piani, in
alto e in basso, delle due basi -, la giusta collocazione del piano,
passante per il punto 3. Solo allora lo fisseremo definitivamente
sia nella faccia del blocco, che nel piano del modello. Teniamo
presente, sempre, una sola condizione: il blocco deve poter
contenere, agiatamente, la statua da farsi. Con questo punto 3 avremo
comunque un piano funzionale, detto del "punto falso",
biunivoco, che ci consente una partenza “quasi fatti”. Quasi
fatti sta a significare la ricerca della biunivocità tra modello e
marmo, non togliendo ancora la parte di materiale eccedente.
Sfruttiamo la possibilità di fissare un capo un punto di comodo. Lo
facciamo anche se dovessimo installare un piastrino – mini supporto
- che lo ospita sul piano lastra e fuori del gesso. La distanza,
minore o maggiore, di questo supporto, è una precauzione tesa a
sfruttare, momentaneamente, tutta la roba dello sfrido ( a tutto
marmo), e può agevolare la partenza e lo sbozzo.
Esplicato
così il punto 3 di servizio, molto utile per il prosieguo dei
lavori, detto in gergo “ punto falso “ , ma è tutt’altro che
falso e provvisorio poiché assolve bene lo scopo prefissato.
L'operazione trova poi conferma nel raffrontarsi con i punto omologo
nella faccia opposta, il "4" , per trovare la quadra
secondo l'assetto complessivo della figura da riprodursi. E poi di
seguito, il trasporto degli altri capi punto emergenti.
Usiamo
l’impostazione di lavoro dianzi descritta a seconda delle
circostanze imposte; così come anche la seguente è di facile
esecuzione.
Continuiamo
ad operare sul triangolo isoscele A-C- B.
ILLUSTRIAMO
UN SISTEMA CLASSICO. Preliminari.
Intorno
e dalla figura, immaginiamo di svilupparne il volume, partendo dal
perimetro disegnato sul piano lastra. Tale parallelepipedo virtuale,
come quello reale del blocco, dovrà contenere, nelle proporzioni
stabilite, il modello. Prefiguriamo due piani alti: uno del modello
(dato dai tre capi punto); l'altro sulla reale superficie del blocco.
Fissiamo anche sul marmo i tre capi punto di partenza, in
corrispondenza di quelli già fissati sul modello, uno alla testa due
ai piedi. Si prende, col compasso, la misura 1-2 ‘posta
alla base’
del modello, non più nella mezzeria. E, sul triangolo di proporzione
– A-B-C –, ripeto le stesse intersezioni già descritte: faccio
centro in A e riporto, sul lato AC, la misura 1-2; poi, tenendo ferma
la punta del compasso terminale, porto l'altra punta sul segmento AB;
dal punto in cui tocca, si allunga l'apertura del compasso fino ad A:
è praticamente un doppio passo. Questa sarà la misura
proporzionale da riportarsi alla base del blocco. Sappiamo che per
tre punti non allineati passa un solo piano, quindi andremo a
determinare il punto 3: si prenderà la misura 1-3 col compasso e la
si riporterà sul blocco - come prima - debitamente aumentata col
triangolo di proporzione; la stessa cosa si farà con la misura 2-3,
così le intersezioni dei due archi, 1 e 2, mi daranno il punto 3
della testa. Incrocio i compassi, dai punti 1-2-3, sulla costa del
blocco, affinché si prenda un altro punto, il "4", a
fianco del modello e lo si trasporti sul blocco, anche se il piano
1-2-3 del marmo, " non avrà, al momento, lo stesso angolo di
inclinazione spaziale pari a quella del modello". [Inoltre
può verificarsi che, l'atteggiamento della figura, o parti di essa,
emergano dal piano dato dai tre capi punto, e sportano fuori alcune
rilevanze. In tal caso dovrò sbassare, i capi punti di partenza
1-2-3 – prima di riportare il 4 - in modo da poter recuperare quei
rilievi che si stagliano dal piano. Attuerò tali sbassi, alla base e
alla testa della figura, fintantoché non avrò recuperato tutti gli
eccessi di rilievo.]
Così dopo aver corretto il piano iniziale - dagli eccessi di rilievo
- dei capi punto ( 1- 2 -3 ) mi accingo ad adeguare,
definitivamente, il piano del marmo, in modo che abbia,
"coll'orizzontale*, lo stesso angolo uguale a quello formato dal
piano del modello".
[*Orizzontale:
parallela alla superficie terrestre].
“Perciò si prende sulla base del modello un altro punto, lo si
trasporta sul blocco, e si fissa definitivamente il punto 3. (“Così
recita, labilmente, la vulgata corrente”). Constatato
che i miei due punti allineati alla base (1e2 ) sono corrispondenti
nel modello e nel marmo, li unisco, tracciando una linea da spigolo a
spigolo, estesa a tutti i lati, e, aiutandomi con la squadra,
proseguo negli altri due lati perpendicolari a quello che contiene i
capi punto (1e2). Così circoscrivo sia la base della statua che
quella del modello. Il rapporto è tra due poligoni biunivoci.
Perciò, partendo dalla base del modello elaboro sul marmo perimetri
simili, con gli stessi angoli*. [*Attuo
la
costruzione geometrica degli angoli: “dato un angolo qualsiasi
costruirne un altro di uguale ampiezza”].
Apro il compasso sul punto 1 del modello, fino a lambire il vertice
dello spigolo**, e da questi, con la stessa apertura, interseco
l'altro lato, sottostante il punto 2, e segno un punto P, in basso,
sulla linea che circoscrive la base. Lo stesso riporto si effettuerà,
sul piedistallo, nella statua da farsi. E' il momento di utilizzare
il punto 4: con il compasso fisso su esso, con apertura sulla base, a
tangere il perimetro del modello, misuro e controllo la distanza, la
trasporto sul blocco, a conferma della giusta posizione del perimetro
lineare biunivoco. Dopodiché, dal punto 1 del modello, presa una
misura sul punto P - che è l'ipotenusa, poiché opposta all'angolo
retto - la trasporto nel blocco, togliendo quel tanto di roba, se
sarà necessario, per confermare, nel triangolo configurato, un
angolo di uguale ampiezza sia del marmo che del modello. [**Si
può evitare lo spigolo, se l'angolo non è vivo, con l'apertura sui
capi punto, l'1 e il 2 al limite, e poi al P].
Così ho configurato una base triangolare (1-2^-P), di cui il punto
3, misurato e confermato, sarà il vertice della piramide proiettata,
similmente, nel modello e nel marmo. Infatti ho aperto il compasso
dal punto 1 al 3 del modello e riportato, idem dal punto 2; la
conferma la trovo con la cala dal punto P.
Poi,
proseguo riportando, ai fianchi, il 4 ( che va' rivisto***); di
seguito il 5, che conferma il perfetto assetto; e, via via, tutti gli
altri capi punto riportati, dal modello, per tempestare di punti la
riproduzione nel marmo. [***rivisto
perché inizialmente non è certa la sua precisa posizione nello
spessore del blocco. Abbiamo ugualmente utilizzato il punto 4,
assodato che la sua proiezione è comunque ortogonale ai due piani
paralleli, inferiore e superiore, del marmo. Spostando i tre capi
punto verso lo spigolo, il suo spostamento è lineare e
perpendicolare. In modo che, pur variando la sua profondità, non
muta la distanza dal perimetro della base ( // al suo lato)].
Con
le intersezioni alla base della scultura ho
così il piano 1, 2 e 3 rettificato (precisando ciò che non è
esplicito nel libro dell'Enciclopedia delle Arti e Industrie. E
neppure nel libro del Prof. Rovali: "perciò si prende sulla
base del modello un altro punto , lo si traporte sul blocco, e con
quello si fissa definitivamente il punto 3" …). Dove come ? Ci
sembra più corretta l'intersezione con il punto P; e come,
susseguentemente, poter operare sui punti 4 e 5.
ALTRA
TECNICA, RIPORTO DI ANGOLI UGUALI.
La
postura del modello può essere normale al piano od orizzontale. In
questa tecnica il gesso è supino, i lati interessati sono quelli
della lunghezza, consecutivi agli angoli che contengono la larghezza
della figura. Insieme formano il perimetro del poligono sul piano
lastra; in questa posizione l'altezza, dal piano lastra, è data
dallo spessore della figura (la sua profondità).
Questo
altro approccio consiste nel considerare il piano sottostante al
modello come inizio della manovra (cioè non è guidato, nel piano
superiore, dai tre capi punto posti alle estremità della figura).
E'
una tecnica che ha la necessità di intersecare e riportare gli
angoli da un poligono all'altro. A tal fine, per una migliore
comprensione, ricordiamo come si è misurato un angolo dato, ad
esempio dal modello, e lo si è riportato, con uguale ampiezza, sul
blocco. Il punto P, dianzi illustrato può darci uno spunto.
Concentriamoci su un modello supino o eretto sulla propria base; e la
stessa postura che assumerà la sua riproduzione industriale in
marmo. Il miglior fare inizia dalla copia e dalla capacità di
riportare, sul lavoro, tutti i riferimenti con precisione massima.
Iniziamo dalla loro impronta perimetrale, sul piano lastra, se il
gesso è supino. [Dalla
base della figura, se eretto. Qui è' preferibile il lato che
contiene i capi punto 1-2 ; oppure quello che agevola migliori e
strategiche intersezioni: quasi sempre il punto di vista frontale].
Se l'esecuzione è di altezza maggiore del modello, si fa' uso del
triangolo di proporzione. E si opera su perimetri simili, riportati,
sulle basi o sul piano lastra, e ornati di capi punto strategici. IL
riporto può essere dal modello al blocco o viceversa. (vedi inizio
“fatti”). Facciamo mente locale su il "lato"
convenientemente scelto alla base, ambivalente: su quello del
perimetro che lo circoscrive, indipendentemente dalla sua posizione
(eretta e/o supina). Riprodurre angoli uguali è possibile nel
piedistallo della figura, o sul perimetro che la circoscrive. Sulla
base, usualmente, sul lato frontale, scelto un punto mediano, apro il
mio compasso e prendo una misura, da un punto "A", scelto a
piacere, fino a lambire lo spigolo del perimetro, e segno il "B".
Poi, da questo, con la stessa apertura, riporto la misura data sul
lato adiacente, per marcare il punto "C". Da subito,
riporto le misure, in proporzione, sulla statua da farsi; e con esse,
segno anche dei capi punto utilizzabili. Per riprodurre l'angolo di
uguale ampiezza: apro il compasso su A e C, trasversalmente, e lo
riporto sul marmo (è la misura del lato opposto all'angolo retto). l
piani delle basi, sono dei parallelogrammi, le cui facce opposte
costituiscono il parallelepipedo e i loro lati gli spigoli delle basi
(del blocco). Definiti tutti gli angoli prenderemo altre misure, con
i compassi, per meglio insediare nuovi capi punto nei rilievi della
figura, partendo da quelli già predisposti nei perimetri dianzi
menzionati.
IL
PIEDISTALLO
Sul
piedistallo abbiamo impostato una precedente tecnica, guidati dalla
sua proiezione nel piano, altezza e larghezza, e perpendicolarità
dei suoi spigoli laterali (profondità). A tal disegno attengono le
tre dimensioni prospettiche proiettate, presenti anche in questa
elaborazione. Fondamentale è il loro riferimento, nella costruzione
dei piani di partenza, nel concatenare tutte le intersezioni
necessarie alla smodellatura. Dobbiamo aver presente che non tutte le
composizioni scultoree sono uguali e quindi anche l'approccio
tecnico vi si conforma, presupponendo risposte diverse. Della tecnica
che andiamo ad illustrare ci piace quella ché vede nel piedistallo
della statua, a partire dal modello, il protagonista essenziale.
[
L'immagine
utile e pratica, che fin'ora abbiamo dato della base o piedistallo è
quella, di un poligono equiangolo, simile ad un parallelogramma, che
può assumere qualsiasi forma. Ma nel vasto complesso creativo, al
piedistallo, al di là di ogni ruolo portante o di sostegno, molti
modellatori hanno attribuito a questa componente solo una funzione
formale, o semplicemente decorativa. Ma a seconda della sua forma ed
intenzione, può non essere un elemento neutro, a parte, adibito solo
come sostegno portante. Il sistema segnico, può conformarsi allo
stile dell'opera, alla sua plasticità e linearità, se mantiene un
qualche valore artistico. Spesso le opere commerciali e funerarie
sono improntate a rigidità e sono estranee all'ordine dell'opera,
quasi in contrasto con il suo assetto armonioso e sistemazione
razionale nell'ambiente. Per di più vi è il brutto ricordo delle
avanguardie del primo Novecento e la loro pretesa di sostituire il
piedistallo... magari con una ruota di bicicletta. Sono miserie
formali, illuse di sostituire una componente essenziale di base,
nella convinzione di essere innovativi, ridefinendo il rapporto
dell'opera con lo spazio e occupandolo in maniera liberticida. Che
dire, se negli stessi anni, a proposito della funzione estetica
dell'arte, si è preso in grande considerazione l'aspetto del mercato
e le speculazioni correnti di Galleristi e mediatori di ogni tipo,
solo colpevolizzando l'avvento delle tecniche mimetico riproduttive
di tipo meccanico; e, nel contesto, le manualità e specializzazioni
tradizionali. Ma non il robot e l'utilizzo di rifiuti di ogni tipo. I
conti più non tornano: certo una composizione può essere bottegaia
e appiattita sulla trasmissione delle pratiche artigianali; ma
conserva, pur sempre, quella manualità ed unico tocco personale, che
la fanno essere preziosa e ricca di una sua appartenenza. Non come le
tante celebrative e celebrate opere d'arte moderna che neppure sanno
di essere cerebrali e degne di compatimento. E questa non è l'unica
loro funzione: lo è il grave spaccio da grande arte, quella che
sprizza da tutti i pori, mentre incensano solo se stesse, quando
seguono le contrattazioni del borsino bancario e mediatico asservite
al promotore mercantile.
Dall'antichità
a tutto l'Ottocento, la scultura artistica ha recepito l'importanza
del piedistallo, collocando i gruppi scultorei in armonia con lo
spazio/ambiente. Non ci si è preoccupati tanto di aggiungere
contenuti esterni, quanto di dare un ruolo al piedistallo nello
spazio/ambiente, che sia consono alla organizzazione formale del
contesto. E se l'artista è tale, reinventa la realtà delle cose,
ricercando nuovi mezzi linguistici e tutto ciò che attiene alla sua
organizzazione formale].
Per
altre basi diverse dal poliedro, sferica, circolare o a ciambella, la
tecnica adottabile è sempre la stessa, purché ci si conformi sia al
multilatero che alle circonferenze: un quadrilatero può essere
inscritto in una circonferenza; un quadrilatero può essere
circoscritto ad una circonferenza.
Attenzione,
se in teoria si eccede in spiegazioni; nella pratica si ha il
vantaggio dell'esperienza visiva e sperimentale; perciò osservare e
ancora osservare la manualità dei mestieranti.
DISGRESSIONI
TECNICHE ESPLICATIVE.
Il
Vasari, trattando dell'arte del levare, cita l'esempio di una “pila
d'acqua” : vasca nella quale vi si immerge o si “ caverebbe una
figura “ supina, e menziona altresì le parti del corpo che da
questo contenitore, gradualmente, “sportano fora” , tagliate dal
livello dell'acqua. Lo stesso fenomeno, dell'emersione del modello,
si ha facendo semplicemente defluire l'acqua: poiché mano a mano,
che scende il livello del liquido, si formano diversi piani,
prospetticamente coincidenti, di volta in volta, con il pelo
dell'acqua. Stessa cosa è, in prospetto, l'opera dell'intaglio, nel
suo attacco dal punto di vista frontale. Così bene, come se
vedessimo, tale degradare, da un fianco della vasca.
Quindi,
la partenza è già fatta se partiamo da un piano dato da tre punti,
spesso menzionato. L'obbligazione dovuta consiste, osservando, sia
nella statua, sia nel modello, l'affiorare delle figure sottostanti:
ripetiamolo, virtualmente, col decrescere del pelo dell'acqua.
Insomma,
il parallelepipedo, virtuale, costruito sul modello, è pari al
perimetro che contiene la sua estensione e lo sviluppo del suo
volume. Queste misure dovranno essere contenute, agevolmente e
proporzionalmente, nel marmo. Perciò entrambi i piani dovranno
essere traguardati con una livella, in modo che, partendo da essi, i
successivi capi punto potranno essere posizionati con facilità.
“
BODETE”
: dialettale (chiodi a testa larga e piatta).
Una
volta in uso ai tappezzieri per appuntare la stoffa sui divani,
poltrone o altro. Vengono posizionati, strategicamente, sul modello .
Le bullette hanno la testa capiente che può contenere un piccolo
foro effettuato dal punteruolo ( puntarol). Questo piccolo foro
ospita le punte dei compassi, per le dovute misurazioni, e sono
inseriti nei punti strategici del modello e anche del marmo.
OVVIARE
ALLE DIFFICOLTA'.
Con
il sistema della partenza da un piano, individuato dai capi punto
1-2-3 , che non è semplice da usare, vi sono delle difficoltà nel
riprodurre modelli molto stretti e lunghi, perché i compassi non
incrociano bene. Il sistema della mezzeria facilita la soluzione in
questo modo: predisponendo alcuni capi-punto aggiunti, fuori dal
modello, ai fianchi di esso, con pezzi di listelli in marmo alzati
dal piano lastra; allargando o riducendo le loro distanze, dal
profilo della figura, in funzione delle proporzioni modello/copia.
Nota
esplicativa.
a)
Così con la tecnica della mezzeria è possibile utilizzare dei
supporti limitrofi, fuori del blocco e del modello. Uno tra i più
validi, soprattutto in modelli lunghi e stretti, è quello
impropriamente detto “ del punto falso”. Come sarà questa
partenza? Vediamo: una volta posizionati orizzontalmente, sia il
marmo sia il modello, su di essi si traccia l'asse centrale, la
mezzeria; e si fissano in entrambi due capi- punto, 1 e 2: il primo
alla base e il secondo alla testa delle figure. Per trovare il punto
3, in modelli composti, si opera a ritroso, dal marmo al modello,
aprendo i compassi, sul punto 1 e 2, con una manovra di avvicinamento
adeguata a lambire la superficie laterale del blocco: lo scopo è
quello di ripartire lo spessore, affinché vi sia “roba”
sufficiente, in alto e in basso; e il modello, a tutto tondo, vi
possa essere contenuto agiatamente.
Esperita la mediazione, si
acconcia, il punto 3, definitivamente sul modello, e poi si fissa sul
blocco, a partire quasi “fatti” . Indi, a seguire, tutti gli
altri ( il 4, 5, 6, e via ), nel modo diretto già indicato. In
modelli problematici si ricorre all'ausilio di tacche di listello
esterni al modello e anche al marmo se, raramente, non possa
ospitare capi punto. Di solito, nel blocco, vi è la possibilità di
ricavare tutti i punti necessari a coordinare le lunghe e le cale.
Note
esplicative del riporto a ritroso marmo> modello: b), c).
b)
- operiamo sul triangolo rettangolo, aumentando ogni misura del
modello descrivendo l’arco tangente nella sua proporzione in scala.
Ma se occasionalmente dobbiamo -- quando la misura è già sviluppata
-- compiere l'operazione contraria a quella dianzi descritta,
ridurla, non ingrandirla; quando tale misura è utile al buon
contenimento della figura, ed essere funzionale al buon assetto nel
blocco, il nostro esperimento, che ricerca un punto di comodo, si
esplica sia sul triangolo isoscele che rettangolo, quando, evitando
lo sfrido, la misura presa sfrutta tutta la dimensione del marmo.
c)
– Aperto il compasso su detta maggiorazione, la stessa è da
ridurre alle proporzioni del modello. Perciò, con il compasso
aperto, la portiamo sul triangolo, e la segniamo sul AB, altezza
della statua, e sia AD). Poi con una punta del compasso su D, si
stringe l'altra punta, facendo l'arco di cerchio tangente su AC.
Questa è la misura ridotta da portare sul modello e fissarla. per
ottenere la riduzione. È l'applicazione della similitudine sui
triangoli: “ogni parallela ad uno dei lati, che intersechi gli
altri due.....li divide in segmenti direttamente proporzionali, e
così avviene”.
3
- Opero sul triangolo rettangolo ( sistema del..). Eseguire una
statua maggiore del modello: Statua cm 180, Più DEL DOPPIO del
modello che è di cm. 70.
Sempre
con il punteruolo, in A e B si segna l'altezza della statua, su una
lastra opportunamente annerita, indi in B con ampiezza del compasso
uguale a quella del modello, descrivo una semi circonferenza, alla
quale si tiri la tangente AC, si avrà il triangolo rettangolo ABC.
Ricordo che la tangente è perpendicolare al raggio nel punto di
contatto. Il sistema è uguale a quello precedente nel rilevare i
punti, e nell'avvio del lavoro iniziale; ma si opererà con una
diversa impostazione dei compassi ( per ogni misura è necessario
descrivere l'arco di cerchio tangente ). Ciò detto, ad ogni misura
si farà muovere una punta del compasso su AB (B→A),
finché si troverà un punto tale in cui, fermandoci, con l'altra
punta si potrà descrivere un arco di cerchio tangente ad AC: allora
allargando il compasso fino ad A ( sulla linea AB ) si avrà la
misura da trasportare sul blocco. Così per tutte le infinite misure.
TECNICA
INUSUALE ERRATA. SCONSIGLIABILE.
LA
CURIOSITA' E' ASESSUATA, ma al fine di ampliare la conoscenza di più
costruzioni è indispensabile anche L'INUTILE.
Di
seguito, descrivo due metodi diversi nella fase di partenza, da
taluni utilizzati, ESCLUSIVAMENTE al fine di completare la conoscenza
di più costruzioni.
Perimetri
intorno al modello, sulla lastra o alla sua base. Perimetro che
circoscrive la base inferiore del blocco.
1^
fase): L'impostazione di avvio non è in superficie, bensì vicina
agli spigoli dei piedistalli del marmo e del modello, se eretto.
Altrimenti è sul suo piano di appoggio. Qui la postura della figura
è sovente orizzontale. Si "presenta" ( sovrapponendolo
correttamente) il modello sulla lastra per esperire una prova di
posizionamento: trovata quella giusta , viene segnato il perimetro
intorno al gesso. L'attacco è sempre uno solo: quello frontale o
principale della figura, vista dall'alto e simigliante ad un
basso/alto rilievo. È consigliabile includere, il modello, in un
poligono rettangolare, se il suo atteggiamento lo consente, o
comunque riconducibile ad un poligono, più o meno, regolare. In
questa tecnica il perimetro è rilevato nelle facce del blocco,
circoscrivendo la sua base inferiore. Il trasporto dei capi punto è
particolare: riportati dal modello, quelli principali vengono
fissati sul blocco, dopo averlo scandagliato; dopodiché si riportano
tutti gli altri punti necessari ad una fedele smodellatura. Da
notare che, il perimetro, nelle facce del blocco, lo va a
circoscrivere vicino alla base inferiore. Ciò che mi ha colpito, in
questa tecnica è l'imperizia nel costruire i perimetri, ed il
trasporto susseguente dei punti. Non si è riportata l'eguale
ampiezza degli angoli nel perimetrale intorno al modello ed al marmo.
Sia la base della figura, sia quella blocco, non sempre sono dei
parallelepipedi retti. Così non vi sarà un corretto riporto delle
misure. Se modello e la statua da farsi sono in posizione eretta
l'approccio alla sbozzatura e alla smodellatura si fa partendo dai
piedistalli e dai relativi perimetri che li includono. INIZIAMO DA UN
LATO DEL PERIMETRO DEL MODELLO, quello dell'altezza.
TECNICA
ERRATA.
Vanno
segnati tre punti, mediamente ripartiti, sulla corrispettiva linea,
con una partenza simile, nel modello e nel marmo in proporzione. La
retta parte da da un angolo comune, e misura tutta l'altezza della
figura. Perciò, se nel piano lastra del modello inizio da un capo
punto A, proseguo nel punto B e poi C, a distanze eque. Anche nella
linea tracciata, alla base del marmo, sono obbligato ad iniziare
nello stesso modo. {Ma
si
da il caso che il marmo non sempre è squadrato e disposto con angoli
retti, la segata spesso ne difetta: perciò, quasi sempre, dovrò
ricostruire gli stessi angoli uguali, misurati dal modello <
riporto sul marmo; o fare l'operazione opposta, a ritroso, adeguando
i capi punto del modello a quelli del marmo, partendo quasi fatti.
Quel che non viene considerato è che gli angoli, sia nel modello,
sia nel blocco, conservando la loro particolare ampiezza, falsano il
riporto delle misure, e rischiamo di
fissare
punti a casaccio.}
Non consci dell'errore, proseguiamo con i punti sulla prima linea del
piano lastra che saranno, con l'ausilio di una squadra,
ortogonalmente proiettati nel lato opposto alla linea di partenza:
come si può fare su un foglio da disegno, quando si tracciano le
perpendicolari comuni a due parallele. Non fissiamo ancora la
SECONDA LINEA perimetrale, lasciando in sospeso il completamento
della proiezione (si concludono, per il momento, le operazioni
lastra-modello). La stessa PRIMA linea si traccia su una faccia del
blocco, in scala, con l'ausilio della livella, segnando gli stessi
capi-punto comuni, riportati dal modello. E' ovvio che nel marmo si
debba tener conto della distanza delle linee dagli spigoli di base,
per non essere sacrificati a manovrare, con i compassi, troppo vicino
ad essi ( dagli spigoli della base di appoggio, in altezza, il
perimetro dista cm. 5 circa ).
NEL
DISEGNARE LA SECONDA LINEA, ciò che dobbiamo fare, è individuare
due linee comuni e parallele, poiché attraverso esse passa il nostro
piano.
Riferisco,
con rammarico, una pratica in uso ma di scarsa precisione nel lavoro
di smodellatura. La riporto solo come curiosità e perversione del
mestiere.
Segnata
la prima linea sul modello e sul marmo, con i loro relativi tre
punti, operiamo per individuare la seconda. Si procede in questo
modo: con l'ausilio di una squadra, partendo dalla prima linea del
blocco, si proiettano ortogonalmente e in basso, detti tre punti,
fino ad incrociare lo spigolo della base. Da questi passando sotto la
base inferiore del marmo - è qui che casca l'asino, poiché i tagli
non sono mai perfetti - si fanno passare le relative proiezioni, con
l'ausilio di una squadra, nell'opposta faccia del blocco. Siamo
nell'opposto spigolo, con le proiezioni assunte dalla prima: le
riproiettiamo in alto e ripetiamo la distanza di 5 cm dallo spigolo,
poi con l'ausilio della livella tracciamo la seconda linea ed i
punti, incrociando le proiezioni. DISEGNATA
COSI' LA SECONDA
LINEA SUL MARMO, possiamo utilizzare tutta la dimensione del blocco,
partendo quasi “fatti”. L'operazione seguente è quella di
riportare, a ritroso e in proporzione, la stessa larghezza del blocco
sul perimetro del modello. Ovviamente si è tenuto preventivamente
conto, del consono volume del marmo, già predisposto e compatible
con le dimensioni in scala.
Riepilogando:
abbiamo utilizzato, quando è possibile, tutta la larghezza del
blocco ( distanza tra le sue due facce ). Per fissare la SECONDA
linea, sul piano lastra del modello, si procede a rovescio, cioè dal
marmo: con il compasso si prendono le distanze dei corrispettivi
punti e si riportano sulla lastra - in proporzione, a ridurre -
segnando la seconda linea su di essa. Sulle due linee parallele ai
piani del marmo e del modello, si possono mettere infiniti punti;
tanti quanti ne occorrono per facilitarci il lavoro. Comunque,
fissati i primi tre punti su ogni retta, possiamo segnare tutti
quelli che desideriamo, utilizzando, ogni volta, tutte le misure che
ci sono necessarie per tempestare di punti la statua.
EVITIAMO
IL MARCHINGEGNO DIANZI DESCRITTO. 2^ FASE, AUSPICANDO CHE LA SEGUENTE
TOPPA NON SIA PEGGIORE DEL BUCO.
Utilizziamo
un approccio migliore.
DOPO
AVER SCANDAGLIATO IL BLOCCO E SCELTO DA QUALE PARTE INIZIARE, ci
accingiamo a migliorare il sistema dianzi descritto. Innanzitutto
dobbiamo CAPOVOLGERE IL MARMO ( piano posteriore in alto) e,
prendendo in considerazione il piano rovesciato, procediamo nel modo
seguente, affinché le operazioni siano più agevoli. Scelto sulla
lastra di appoggio l'apposito spazio, si individua il perimetro dove
collocare il modello; subito dopo, nel corso della sua maggiore
lunghezza, è segnata una retta e su essa si traccia il segmento A-B.
Lo stesso, proporzionato alla grandezza della statua da eseguirsi, lo
segniamo sul fianco del blocco scelto, da angolo ad angolo, IN
ALTO, circa 5 cm prima dello spigolo e della sua faccia inferiore
(blocco capovolto) Poi, lo controlliamo con la livella, già
ipotizzando i riferimenti futuri comuni con il modello ( lati, angoli
e capi-punto ), come precisato nel precedente esempio. Iniziamo dal
segmento acquisito sul marmo, centrando i compassi sui punti A' e B',
riportati dal modello e, con le loro intersezioni, segniamo il
punto C nel lato opposto, incrociando la stessa profondità (cm 5)
dallo spigolo, del segmento traslato da A' B' che sarà D – E.
Cerchiamo di partire “fatti”, per sfruttare tutta o quasi la
larghezza del marmo, e nello stesso modo utilizziamo le rette A e B
nella sua altezza. Così come questi lati sono, nel loro insieme, la
fascia esterna del poligono, ad essi dovranno essere adeguate le
stesse linee di contorno del modello, affinché entrambi i perimetri
siano simili nel rapporto in scala fissato. [Non
ho però la totale certezza se gli angoli dei rapportati perimetri
hanno la stessa ampiezza.]
Tolto il modello momentaneamente, si trasporta il punto C' sul piano
lastra, riportandolo, a ritroso, sul triangolo di proporzione, come
si è dianzi già indicato. [Può
anche verificarsi il riporto diretto, si toglie la parte di marmo
eccedente, individuando d'acchito il punto C' , modello/marmo, come
si fa' usualmente.]
È utile precisare che i segmenti A B e D E sono paralleli e gli
stessi AC'B = D C E ortogonali.
Abbiamo
così realizzato due piani simili, delimitati da due parallele; e
con esse il perimetro del blocco dato dai lati A' B' D' E' e quelli
del modello definitivamente collocato nel perimetro A. B. C. D.
Ultima
osservazione: da notare che il punto C' sul blocco si segna
facilmente, sia coi compassi sia con il maranghino, essendo lo
spessore da valicare in alto esiguo. Infatti, le linee parallele, a
cui appartiene il piano A'B' D' E' sono molto vicine alla
superficie, essendo il blocco rovesciato, e con il piano anteriore,
momentaneamente, adagiato al suolo. È importante che i due piani
individuati, formino, coll'orizzontale, lo stesso angolo. Iniziando
la partenza, con il trasporto dei capi-punto necessari al lavoro di
smodellatura, è necessario, quanto prima, RIPOSIZIONARE
CORRETTAMENTE IL BLOCCO.
ESPLICITAZIONI:
Abbiamo
eliminato delle difficoltà, senza complicarci la vita, causate dalla
precedente tecnica, dove il piano di lavoro inizia nel piano
posteriore e non in quello anteriore. Mentre auspichiamo di non
usarla, nella ostinata occasione, rovesciamo momentaneamente il
blocco. Con questo capovolgimento si possono rapportare, sia le due
linee di partenza, traguardate, sia i capi punto iniziali ( A . B . C
. ). E capovolgendo, come detto, il blocco, si evitano le difficoltà
di passaggio delle squadre, da sotto, con il riporto dei punti dalla
prima linea, oltreché i passaggi, a scavalcare “il pezzo”, da
parte del maranghino.
Come
nella 1^ fase, il piano così trovato, deve, virtualmente, tagliare
il blocco NEL PIANO POSTERIORE : nel senso che le due facce opposte
(FIANCHI) del marmo possono ospitare l'una il segmento A'- B' ,
l'altra l'intersezione C, sul cui punto si traccia la retta parallela
D - E, che va sempre traguardata con la livella . Entrambe appresso
gli spigoli del marmo, in maniera congrua e da sfruttare, al meglio,
le dimensioni del marmo e per trovare un piano, A' - B'- D' E'
conforme a quello individuato dai punti A-B-D-E del modello. Dopo
l'intersezione da A-B sul punto C, sul piano lastra, troviamo la
relativa parallela, passante per questo punto, tracciando la
perpendicolare al segmento A-B, per avere AD, idem dal punto B per
trovare B-E, entrambe riportando la distanza C da AB.
Nel
marmo l'operazione è fatta sul perimetro, linea di contorno che
delimita il piano: perciò completeremo i lati, sia traguardando con
livella, sia apponendo sul segmento dato le intersezioni dei
compassi, A' – B' e B' - E' partendo dal segmento dato, mai
dimenticando la distanza dagli spigoli e la congruità degli angoli
dei perimetri statua/modello. Gli
angoli vanno misurati – nella loro ampiezza - e la loro equivalenza
confermata.
[
Raccomandiamo, per facilitare il lavoro, che il punto C del modello
dovrà essere fissato, utilizzando tutta la misura del marmo,
partendo quasi “ fatti “ . Se però si è provveduto ad
eliminare l'eventuale materiale in eccesso, si procede direttamente
dal modello. Il suo schema può essere rilevato dalla sua posizione
su un piano, con la possibilità di adattarlo, con opportuni tagli,
alle prospettate dimensioni della statua da farsi.]
DIGRESSIONI:
ILLUSTRAZIONE DELLE PRECEDENTI TECNICHE con i relativi chiarimenti,
dimostrano che dopo lo sbozzo occorre uscire da quelle tecniche
riproduttive che oltre ad esprimere la crisi del mestiere lo sono
anche del sistema dell'arte. Continua la diatriba tra ideatore ed
esecutore, sul tema come uscire da tecnologie mimetico produttive del
bolso artigianato. Dunque si impone “ un'uscita da un'arte
meccanica che genera solo fatica e sudore?” Per alcuni ciò ha
significato affidarsi all'intaglio diretto, dandosi totalmente ad una
sensibilità interiore ; per altri è il potenziare l'intuizione ed
il dialogo con la materia e le sue affettuosità, per farsi guidare
dalle sue configurazioni implicite. È uno scolpire d'acchito, raro
dono naturale, il cui presupposto è la percezione personale. Far
vivere interiormente un'idea di ciò che si vuol rappresentare, è
l'esprimere in essa tutta la nostra sensibilità e progettualità.
Altrimenti se si esclude a priori la cosa che si vuol creare, non si
esprime uno stile e tanto meno si è attori credibili e compresi.
SBOZZATURA
E SMODELLATURA ATTUALE
Un
uso più corretto e tradizionale della precedente tecnica, ci
consente una maggiore facilità nella esecuzione di un disegno,
seguito nell'alternarsi dei piani, per comodità, facciamo ricorso al
metodo della doppia proiezione ortogonale su piani coordinati della
geometria descrittiva (fianco e prospetto).
Fondamentale,
come più volte detto, la partenza da un piano, frontale o
principale, a seconda della postura e dell'appoggio della statua.
Nella seguente tecnica, l'attacco inizia ancora da una delle due
basi parallele del blocco; nel merito in basso, posto sul
geometrale.
Il
parallelepipedo se è segato perfettamente, presenta angoli a 90°,
che molto faciliterebbero, in questa tecnica, la buona riuscita del
lavoro. Cosicché, con misure prese tramite righe e compassi, su
superfici e lati opposti paralleli, non si dovrebbero avere
scostamenti. Abituiamoci al fatto che, nella realtà presente, il
segato perfetto sembra sia cosa rara.
Il
modello per solito va sdraiato sul piano lastra (proiettato, in
pianta, dentro un perimetro), facile immaginare le tre dimensioni
similari a quelle del blocco: altezza o lunghezza, larghezza,
spessore; affinché siano prospettate, in proporzione e speculari, a
quelle supposte nel volume del modello. Abbiamo descritto con ciò un
poliedro disegnandone, in pianta, i contorni di un poligono, sia
pure in funzione di un progetto di massima, ma al momento, per
adeguare il blocco, sulle necessità immediate dei parametri della
lavorazione, così eliminando, con precisi tagli, lo sfrido
eccessivo. A tal fine, ben progettando, ponderiamo anche l'attacco
dal punto di vista principale che sarà scelto sul marmo, a seconda
della collocazione della statua da farsi, agevolati dalle forme
geometriche elementari già predisposte. Insomma, il perimetro,
intorno al marmo che è il medesimo, tradotto in scala, di quello
del gesso, è stato preventivamente misurato, adattato e tradotto
nelle dimensioni veicolate tra lo stesso e il modello,
riproponendolo sintetizzato nelle sue forme base più semplici. Due
momenti tra loro consecutivi si sono avvicendati: la trasposizione
del modello sul piano lastra, che ha consentito di delineare uno
schema per raffrontarlo con il marmo in modo da eliminare lo sfrido
superfluo, geometrizzando il blocco dentro il poligono rettangolo
testé definito: è la conclusiva postura, che meglio aiuta ad
individuare il miglior punto di vista principale di attacco, comune
al blocco e al modello. Questi verrà poi fissato definitivamente,
cementandolo dentro il poligono rettangolo segnato sulla lastra. È
lo stesso perimetro che il marmo assumerà con la migliore posizione
datagli dalla simbiosi ottimale del suo volume, rispetto a quello
figurato sul modello. Comunque, saranno scelte e posizioni che
porteranno più alla mano la lavorazione.
La
postura della statua o delle eventuali composizioni, ad imitazione di
quelle del modello, dovranno assestare la loro postura in modo da
piantare correttamente, affinché la figura e i gruppi si staglino
correttamente sulla loro base di appoggio. A tal fine, il loro
piedistallo dovrà essere definito e controllato con il filo a
piombo, che dovrà cadere perpendicolarmente e dentro il naturale
spazio di sostegno delle figure.
La
tecnica di seguito descritta si inizia dal perimetro (e dal volume)
del blocco dianzi predisposto, reso conforme a quello delineato dal
modello. Sulle facce laterali del prisma abbiamo segnato, ad una
certa distanza dagli spigoli di base (inferiore) del blocco, circa
cinque centimetri, le linee perimetrali (lati) conseguenti,
controllandole con la livella. L'operazione successiva sarà quella
di costruire, sul piano lastra del modello, i quattro angoli reali
dati, in proporzione, dal marmo. E da qui, su uno dei lati di
contorno, nella parte inferiore presso gli spigoli menzionati,
fissiamo un capo punto (A) all'incirca nella sua metà; e con il
compasso ne prendiamo la distanza dal vertice di uno degli angoli
adiacenti. La stessa misura, la riportiamo sul lato consecutivo (B);
poi, aprendo ulteriormente il compasso da quest'ultima intersezione
al capo punto di partenza ( A) – in diagonale - a passare l'angolo
di mezzo, otteniamo una misura che corrisponde all'ampiezza
dell'angolo nel blocco, da trasporre. Questa è la soluzione di ciò
che ci è richiesto: come trasportare, un angolo uguale a quello
dato, che, nel nostro esempio, è quello del marmo. Ripetiamo la
stessa operazione per tutti e quattro gli angoli consecutivi,
riportandoli a ritroso e in proporzione sul modello, tracciando sul
relativo piano di appoggio, il perimetro, con tutti i lati e gli
angoli dati. È il metodo più semplice, in poligoni irregolari o
regolari, secondo i casi. Ciò indipendentemente dalla postura di un
singola statua e di un gruppo nella diversità delle basi, circolari,
ovalizzate, ad isola o altro: tutte quelle che ne sostengono le varie
composizioni, sia inscritte che circoscritte in poligoni. Il marmo ha
la forma di un parallelepipedo rettangolo, non sempre regolare, ed
anche il modello è reso conforme a questo schema. L'affinità
maggiore dovrà rivelarsi nella compatibilità dei piedistalli, per
l'approccio del lavoro, soprattutto nella posizione eretta. In quella
supina il perimetro che circoscrive il modello sul piano lastra è di
facile adattamento. Per semplicità, e per la particolare
conformazione “solida” del blocco, utilizziamo superfici piane
che abbiano tutti gli angoli uguali ed i lati conformi. Noi
seguiremo questa disponibilità sempre, al fine di agevolare il
lavoro del puntatore; in seguito, copieremo convenientemente le varie
forme delle basi, che le lavoreremo come realmente sono nel modello.
Praticamente privilegiamo l'esercizio geometrico di ricostruire gli
angoli ed il perimetro esattamente come quelli obbligati nel marmo,
diffidando dei tagli del blocco, di certo quasi mai perfettamente
squadrato. Anche se grezzo, in questi, vi è la necessità di
impostare da subito una base, quantunque non sia ancora ben definita.
È dato per scontato che una base o un piedistallo o altro vi sia, e
che svolgano una funzione di sostegno della scultura, per renderne
migliore la collocazione e percezione nello spazio. Altrimenti, se
non vi sono i piani di appoggio tradizionali essi vanno ricostruiti
artificialmente per un buon programma di lavoro.
Perciò
al momento, siamo stanziali su due poligoni non necessariamente
regolari, ma che potranno essere equiangolo e possibilmente
equilatero; e comunque consentire perimetri utili. Su questi, a metà
dei loro lati, partendo dagli angoli, fisseremo dei capi punto.
Conseguentemente, proponiamo di iniziare a trasportare nel marmo
tutti i capi punto fissati nel modello, con particolare riguardo a
quelli più emergenti nella dimensione delle maggiori altezze e
sporgenze, mappandoli secondo la loro funzione prioritaria, rispetto
alla scansione dei piani. Non secondario il piedistallo, anche se
grezzo, nel contesto può assumere il ruolo da protagonista
alternativo: essere inscritto e provvisoriamente costruito con
squadre: simili a quelle cornici, dei secoli scorsi, che abbiamo
visto in alto ed ortogonali ai muri di laboratori. Anch'esse possono
darci il volano di un diverso processo del levare, non valendo le
migliori possibilità date da un piedistallo definito nell'impostare
e coadiuvare l'emergere graduale delle forme guidandone l'intaglio.
Abbiamo così riproposto perimetri e piani in similitudine, per
iniziare l'inserimento di tutti i punti essenziali per una buona e
corretta smodellatura.
Giunti
a questa fase del lavoro su figure similmente poste: - quella del
modello, sempre uguale a se stessa, - e quella della statua,
variabile a seconda della sua riduzione od ingrandimento,
ricordiamoci di essere attenti a tutte le operazioni di trasporto
delle misure dal marmo al modello, ma soprattutto sulla congruità
degli angoli perimetrali, alle relative triangolazioni, se
desideriamo operare in sicurezza ed estendere tutti i capi-punto
necessari per un riporto sempre più fedele. Se si ha questa
certezza, il relativo sbozzo e la sua geometria elementare sono il
miglior presupposto per una perfetta copia del modello.
IL
PIANO DI ATTACCO AL LAVORO PUO' INIZIARE DA OGNI PARTE, AD ES.: DAL
FIANCO DEL BLOCCO. E' POSSIBILE DIRE CHE MOLTI E DIVERSI POSSONO
ESSERE GLI APPROCCI PER UN'OTTIMO INTAGLIO? Ognuno di noi ha
maturato, nella pratica della lavorazione una propria e particolare
tecnica che gli è più congeniale nell'esprimere la propria
MANUALITA' IN FUNZIONE DELLA PADRONANZA DEI MEZZI ESPRESSIVI:
l'occasione aguzza l'ingegno. Ritorniamo a rappresentare il modello
ancora supino sul piano lastra. Il gesso è livellato con
l'orizzontale e circoscritto da un poligono. Su un lato di questi,
che esprime la lunghezza della figura, alziamo un piano ortogonale,
fino ad incontrare quello che taglia, in superficie, i capi punto 1e
2 e li contiene, coincidente nel modello e nella figura da farsi.
Nelle facce del blocco, ad una distanza vicina agli spigoli di base,
è incisa la traccia dei lati - il perimetro: linea spezzata chiusa,
simile nel piano lastra e nel modello - che delimita una parte di
piano come quella che circoscrive il gesso; ed ha la sua stessa
funzione. Perciò, in conformità, sui piani testé menzionati, è
possibile alzare tutte le altezze desiderate: – siano essi sui
supporti o direttamente sul perimetro – sia nel modello che nel
marmo, sempre in proporzione. L'altezza, nella faccia del blocco, è
misurata, in alto, a partire dalla traccia già detta; nel modello è
segnata su listelli, cementati sul piano lastra. Va da se che su
questi segmenti perimetrali, da angolo ad angolo, si possono mettere
infiniti capi punto, quanti ne riterremo buoni alla riproduzione.
Assodato che il piano, di partenza, utilizza le stesse
triangolazioni, fissiamo il punto 3 su un supporto del modello. Nel
collocarlo, ad un giusta altezza, valutiamo sempre le disponibilità
dello spessore, affinché sia garantito il contenimento della figura.
Poi, utilizziamo gli incroci dei capi punto 1e2 sulla linea
dell'altezza calibrata, per segnare il punto 3 sul marmo: sul modello
si prenderà, con il compasso, la misura 1-3 e la si trasporterà sul
blocco, in proporzione; identico riporto con l'apertura 2-3;
l'intersezione dei due archi darà il punto 3. In tal modo abbiamo
definito il nostro piano di riferimento. Da questi capi punto è
possibile avviare la riproduzione con punti opposti che si
interfacciano e possono determinare [materialmente]
- con le tre intersezioni [le
linee di obliqua],
un punto o un piano nello spazio, che è al vertice di una piramide
solida a base triangolare. È la dimostrazione di tecniche che
privilegiano la terza dimensione, partendo da ciascuno dei vertici
del poliedro e dagli spigoli e angoli delle basi. La
tridimensionalità è assicurata da questi assi che consentono di
misurare e intagliare il masso e far emergere i rilievi della figura
obiettiva. È un approccio per una razionale manualità che trae da
un informe cose incantevoli. È una misurazione sugli assi che ci
permette di rappresentare, direttamente un oggetto, con
l'intelligenza della mano e l'indole di una passione atavica. DA
MOLTO TEMPO LA RIPRODUZIONE SERIALE DI SCULTURE ha più una valenza
commerciale che non artistica. Il concetto dispregiativo di arte
meccanica “che genera solo fatica e sudore” è nella sua
relatività, subdolo. Qui concepiamo lo scolpire come un automatismo
di passaggi tra strumenti di misurazione e una mimesi di operazioni
fatte con utensili (macchine) sempre più sofisticati. Sottovalutando
con ciò la sensibilità dell'artista o dell'artigiano nei diversi
momenti del lavoro: della sua pratica che non è sempre quella di
un'automa, ma di un uomo con particolari percezioni e personalità.
Quasi mai vi è un completo distacco dall'opera, col prevalere di un
sentire apatico che non è partecipe di un'idea. Non è la routine.
Mai farsi prendere da questa e dalla “ cotta” inconcludente. Non
è questo lo stile che appartiene all'arte del levare, alla
scultura, la quale non potrà mai ridursi ad una insensibilità nei
confronti dell'affettuosità pastosa della materia. Altrimenti è
meglio cambiare mestiere e dedicarsi a qualcos'altro.
OSSERVARE
O CONTEMPLARE
I SEGNI?
Capire
o percepire l'oggetto in tutta la sua totalità volumetrica nel
rapporto che ha con lo spazio non è possibile, poiché nella realtà
la sua visione non si esaurisce nelle tre dimensioni. L'osservatore
coglie l'attimo, il dato visivo è un unico punto di vista; e
l'unicità della visione ci obbliga a spostarci, girando intorno
all'immagine, per godere appieno dell'opera. Neanche il modellatore
può evitare un approccio diverso. Eppure la scelta di un punto di
vista, obbligatorio, è già un messaggio, una precisa scelta:
strutturato sull'incrociare dei piani, che alternandosi, mostrano
varie configurazioni che unificano il vasto campionario segnico
della scultura ( linee, volumi, chiari e scuri, scorci, forme chiuse;
illusioni). Espressi, nella loro forma simbolica, si preoccupano
solo di costruire modi di essere dei contenuti, inediti e trasformati
che vengono mostrati ed esibiti diversamente. E, con la scultura, si
mantiene quel periodo aureo che è naturale nel suo codice, proprio
perché i linguaggi di configurazioni, i segni, si sviluppano
materialmente nella dimensione spaziale”.
Lo
spazio e il vuoto, l'angoscia moderna del troppo pieno ci hanno
portato a considerare il tempo come la quarta dimensione: a seguire
l'illusione degli artisti moderni ad illustrare contemporaneamente
tutti gli oggetti, per superare il punto di vista prospettico.
Dimenticando o sottovalutando la percezione di notevoli forme
espressive: immagini mutevoli con valenze centrali, di peso visivo,
oppure svuotate in spazi dilatati; ottima anche la mancanza di
profondità spaziale, antiprospettica, con una naturalità visiva che
garantisce uguale colore e luminosità a figure della medesima
grandezza. Un grande artista ha solennemente dichiarato: “meglio i
fatti quali che si conoscono rispetto che quali si vedano”. È
riferito alla quarta dimensione, frontale e simultanea, che
sintetizza tutte le percezioni possibili degli oggetti?, quindi una
visione totale? Ma comprendiamo molto attraverso gli occhi, la vista
è il mezzo che da più informazioni al cervello di tutti gli altri
organi sensoriali messi insieme. “ In questo fenomeno percettivo
sono coinvolti anche il nostro stato d'animo, le emozioni
e, strettamente legati a questi, la memoria, il vissuto delle nostre
esperienze”. La forma è il mezzo concettuale: l'idea che la mente
si forma sulle cose. Tale modello mentale si concretizza in base a
riferimenti preesistenti legati all'esperienza, poiché il modello è
la forma più semplice da noi memorizzata, riconoscibile, a noi noto.
Potremmo dire: ognuno vede ciò che sa. Quindi il presupposto della
percezione è la nostra esperienza personale”. Però aver la
capacità di contemplare, insieme al desiderio di conoscere, sono gli
stimoli essenziali per acquisire maggiori e più approfondite
informazioni sull'ambiente : contemplare più che osservare fa' la
differenza. Importante è saper vedere in maniera diversa, le cose,
dai loro espliciti significati, ricostruite e trasformate dal
linguaggio dell'artista. È prerogativa dell'artista quella di
immettere una determinata forma in una data materia. Appartiene al
giudizio estetico dell'artista imitare e contemplare l'idea che lo ha
ispirato, e di costruire dei modi di essere dei contenuti, che
consentano di rivivere in un modo diverso la sostanza dei loro
significati, mostrati nella loro organizzazione formale ed esibiti
nel significante. Ma basta con contenuti e titoli solo vantati ,
imposti. Sappiamo che tutto ha un prezzo: la capacità di ascolto,
l'orgoglio, gli artisti un tanto al peso; il mercato delle idee, e
quello della politica. Ma tutto sembra altrove: qui, nella nostra
Carrara, non è possibile né godere né usufruire di alcunché,
neppure dei resti. Abbiamo la miglior farina (marmo) del mondo e non
siamo capaci di impastare una pagnotta, locale, dignitosa. “ Non è
vero che il marmo si lavora così punto e basta”! Ma se la materia
marmo, un artista, non la sente, come inizialmente è il caso di A.
Martini e tanti altri, dovrebbe essere coerente ed utilizzare ciò
che percepisce meglio: il cotto, il gesso, il bronzo, o qualunque
altro materiale gli sia affettivo”. Purtroppo si sopperisce
all'assenza di vocazione (la poesia del bello e del naturale),
convocando la più radicale delle contestazioni: “l'arte, ripete
supponente l'eco, non ha un passato ha solo un futuro, quello che [
noi
]
gli
costruiremo!”
Perciò tutto è possibile: “....l'opera d'arte è operazione sul
corpo dell'arte... è filosofia dell'arte...si fa' metà-arte … e
si traduce in una discesa agli inferi dei materiali dell'arte, fino a
congiungersi con il residuale, con l'immondizia”. L'idea stessa
della quarta dimensione, geniale ed utilissima per il disegno
tecnico, rappresentò agli inizi del novecento, un voler vedere e
possedere l'immagine dell'oggetto integralmente. I pittori cubisti
riuscirono nell'intento, sovrapponendo le immagini, di uno stesso
oggetto, rappresentato da diversi punti di vista ( operazione non
esaustiva, poiché per possedere integralmente l'insieme delle
dimensioni prospettiche si dovrebbero rappresentare da un infinito
numero di punti di vista). Nella scultura, per cambiare il punto di
vista devo girare intorno ad essa; altrimenti dovrei mescolare, in
una visione d'insieme, le parti posteriori contemporaneamente a
quelle anteriori. È un bel pasticcio mettere sullo stesso piano,
anche la parte che non si vede da un solo punto di vista, cambiando,
con questo virtuale spostamento, l'angolo visuale delle tre
dimensioni prospettiche. Lo spostamento repentino dell'oggetto, per
vederlo rappresentato contemporaneamente da diversi punti di vista,
potrebbe tuttavia rappresentare uno stile, una sensibilità, e
giammai comandare una regola universale imposta con la forza di un
movimento. Al di là di ogni tecnicismo e scientismo non penso che
l'alternativa possa essere l'idea di una figura costruita su una
infinita pluralità di punti di vista: è illusorio, così come non è
possibile una compressione e penetrazione violenta di corpi e piani
in un caos di materiali diversi che si connettono e compenetrano
nella loro incompatibilità formale e materiale. I cubisti non si
fermarono qui ma vollero rappresentare anche l'interno di un oggetto,
squarciandolo. Tutto è ricerca, dello stile, noi apprezziamo un
mosaico bizantino, per la sinfonia delle luci e dei colori,
nonostante l'assenza di rilievo e di movimento; ammiriamo di più il
Cristo morto del Mantegna per la tragicità dell'ardito scorcio; ma
di una sola cosa restiamo convinti: che un'opera è godibile anche in
molti dei suoi particolari alla pari della sua integrità. Molte
lavorazioni, e la susseguente collocazione, lasciano spesso il retro
di un'opera poco rifinito e non in vista: ciò che appare esplica la
funzione di un alto/basso rilievo. Tutto questo dipende dal livello
di struttura espressiva: e a tal fine, ben collocato in una nicchia,
mostra la sua fiera vivacità il San Giorgio di Donatello,
nell'ambito di uno schema a spirale. Mentre la figura definita
raggiata/stellare del Mercurio del Giambologna, la si può gustare
girandoci intorno? La percezione dei nostri sensi è sempre la
stessa: tende a dare un significato alle cose viste, in base a
preesistenti riferimenti, presenti in noi, legati alla nostra
esperienza e alle più semplici forme modello memorizzate. Molto
dipende dalla modellizzazione espressiva e dei significati e del
senso che ogni opera d'arte mostra in sé nella sua organizzazione
formale. Se così non fosse, mal percepiremo l'ingegno, del grande
artista come del modesto artigiano. Ci riferiamo alla capacità
creativa di ognuno, e a quella intellettuale di intuire, intendere,
l'originalità di un idea, che è ciò che contiene il senso,
l'acutezza mentale di reinventare i contenuti, non per quello che
quotidianamente sono, ma trasformati dalla capacità di oltrepassare
l'apparenza delle cose.
L'argomento
che è messo costantemente in ombra, nel quadro del rapporto tra
artista ed esecutore, è il ridurre a modesto artigianato o
specializzazione parcellizzata, ciò che è tradizione, mestiere,
prassi nella lavorazione del marmo, che è collettiva e popolare,
perfino negli utilizzi domestici : la totalità o quasi degli oggetti
che ci accompagnano nel corso della nostra vita sono null'altro che
la trasmissione di un sapere artigianale. È pur vero che molto della
tradizione si va perdendo, a discapito della funzione e qualità
percettiva; ma la qualità e la bellezza coinvolgono costantemente
il nostro stato d'animo, le emozioni, il vissuto, e gran parte di
tutto questo è legato alle nostre esperienze. Nonostante l'eccessivo
bombardamento di immagini che subiamo ogni giorno, di spregevole
assolutismo, riusciamo ancora a godere, oltre che alle piacevoli
capacità e perizie tecniche scultorie dimostrate, dello sviluppo
significativo dell'intenzione, di quell'attitudine a realizzare
l'idea originale e vera, ancora dall'affettuosità dello stesso
statuario epocale, giunto a gratificare i tempi moderni.
È
un processo originale tra i significati in dote alla nostra
conoscenza e una sensibilità alla pietra avito, conosciuta al tatto,
come a trasparire il blocco. La perizia tecnica nel lavorare il
marmo è capirlo, saperlo ascoltare, è quel sentire che richiede una
stratificazione di esperienze praticata da più generazioni. Negare
tutto questo, è negare la genesi artistica dell'artigiano (almeno
prima del Quattrocento). È un voler escludere alla radice
l'organizzazione artigiana e i metodi individuali di ogni artista,
annullare ogni liberismo e particolarismo: da quello economico, alla
libertà artistica, al gusto di dare un'impronta personale e
un'interpretazione degli ideali e delle tendenze del proprio tempo.
Inesistente l'artista che trancia ogni relazione con la quotidianità
e si chiama fuori dal contesto storico. Non saremo sopraffatti dal
nulla, almeno fino a quando vi sarà questa umanità. La
parcellizzazione tecnica può essere invadente e monotona come una
catena di montaggio: perciò frutto di gesti ripetitivi, masticati e
rimasticati fino alla noia; ma senza validi “aiuti” non sono
possibili grandi opere, neppure per un grande come Michelangelo.
Dipende come si gestisce quella dovuta incombenza della
parcellizzazione che porta via tempo ed energie (solo la semplice
arrotatura dei ferri, in corso d'opera, può costituire un problema
all'intaglio e all'efficienza, figuriamoci tutto il resto!).
Un
altro soggetto si confronta con l'eccellenza marmo, è la personalità
dell'artista, che compete, volenti o nolenti, con tutti i mezzi della
sua capacità creativa e con l'originalità dell'idea. E molto è
legato al rapporto con l'ingegno dell'esecutore: dalla sua capacità
intellettuale di intuire, intendere il senso del messaggio. L'opera
dell'artigiano ( il banauso ), per gli antichi l'artista, non è solo
dovuta all'incessante lavoro di lettura e realizzazione di molteplici
copie, è più mutuata dallo sviluppo di una sensibilità interiore
che lo rende disponibile, come mestierante, ad apprendere con
acutezza e intelligenza mentale il verso, la direzione del linguaggio
dell'autore. Siamo consapevoli che stiamo illustrando una figura
(oggi scomparsa?), un personaggio che ha maturato quell'innato amore
per la poesia dei suoni materici, verso l'armonia da essi rivelata,
quando il segno segue il ritmo voluto.
Il
principale punto di vista è legato alla creazione; alla intenzione
dell'artista nell'attimo in cui la ricostruisce internamente; alla
crescita di una pulsazione naturale semplice, data da una limpida
suggestione spontanea. Perciò ci sembra essenziale l'importanza che
si da al linguaggio formale: l'artista reinventa la realtà delle
cose assunte dalla sua esperienza. Non è importante se quel
contenuto è ben precisato ( una casa, un albero, delle foglie) ma
come rivive nella forma espressiva. Preminenti saranno il rilievo
plastico, coloristico, lineare e altro, rispetto alla moltitudine
delle prospettive occasionali. Ad esempio, il rilievo plastico di
Michelangelo nei confronti del non finito, costruisce un immagine
concreta del senso, che è inseparabile dal significante. “
Diversamente, da parte sua l'ARU dava nuova validità alla tesi
Celliniana dell'unicità della visione per cui Michelangelo, nella
sua pratica di scolpire per forza di levare, si sarebbe fermato
allorché, nel processo in cui la scultura prende forma a poco a
poco, la sua eccellenza plastica sarebbe stata attenuata dalla
creazione di ulteriori punti di vista”. “ Altri ritengono che
l'improvviso arresto del lavoro sia stato causato, invece, dalla
soddisfazione di aver raggiunto il termine della propria visione; sia
per il risalto che il non finito da' al rilievo plastico nei
confronti del finito; sia per la maggior espressione di pathos che
balza da una sintesi estremamente rapida e ardita; vuoi per
l'accentuazione di movimento che emana da una forma che tenta di
liberarsi dal blocco; sia per l'amore delle sculture antiche, più
poderose ed espressive se corrose e mozze; vuoi, infine, per la
suggestione che deriva dalle figure che escono dal marmo grezzo ”.
Non vi è alcun dubbio: in questa tecnica spontanea vi è il
completamento della propria opera ed il permanere del suo sofferto
conflitto tra materia e spiritualità, tra sacro e profano.
Michelangelo dà alle sue poetiche una piena libertà espressiva.
Qualsiasi ipotesi, a partire dalla incontentabilità dell'artista,
assunte anche dal Vasari (carenze del marmo, troppi impegni; ostacoli
della committenza e dei colleghi), è fuorviante. È
incontrovertibile il dominio assoluto di Michelangelo sulla materia.
Nessuna insoddisfazione gli avrebbe impedito di esprimere la propria
idea di un maggior realismo attribuito al non finito per la vivacità
dei rilievi plastici e del contesto stridente tra finito e non. Gli
amanti della scultura conoscono il gusto dato dalla vitale
espressività di figure monche, o dall'antico che emana da una forma
grezza, alle sensazioni date dal primitivismo. Tutto ciò, forse
stimola molti riferimenti, in noi preesistenti ( archetipi ),
immagini primordiali dell'inconscio collettivo trasmessi
ereditariamente. O recenti, di un vissuto radicato nella nostra
esperienza, che si ripete e si innova, implicitamente nella nostra
mente, legando le nostre idee a forme e modelli relazionali. Si dice
infatti:
“
Il
presupposto della percezione degli oggetti è la nostra esperienza
personale: ognuno vede ciò che sa'. ….La forma è il mezzo
concettuale per rappresentare l'idea delle cose.... in base a
riferimenti preesistenti legati all'esperienza.... Il modello è la
forma più semplice da noi memorizzata a cui affidiamo la
riconoscibilità delle cose. … E tutte le varianti di un oggetto o
configurazione lo adattiamo al modello a noi noto”.
Il
processo è complesso: “ Per l'Ottocento l'arte è il mezzo per
conoscere il mondo esterno, una forma di esperienza della vita, di
analisi e di interpretazione dell'uomo”. E come il Quattrocento “
entrambi gli intenti si muovono verso nuovi mezzi, nuovi metodi
scientifici, le invenzioni tecniche, l'espansione dell'economia”. E
con un mercato favorevole agli artisti muove con più forza la
ricerca della soggettività, l'originalità, l'espressione personale,
l'idea, contrapposta all'opera, al risultato, qual'è il lavoro
fatto. “ L'idea dell'arte autonoma, disinteressata, godibile in sé
era già famigliare all'antichità; il Rinascimento non fece che
trarla dall'oblio medievale. Ma prima di allora mai si era concepita
l'idea che una vita dedita al godimento dell'arte potesse costituire
una forma più alta e più nobile dell'esistenza”. “ L'idea del
Petrarca di un'arte del tutto autonoma e che, benché indipendente
dal resto del mondo spirituale, anzi proprio in grazia di quella
bellezza che ha in sé le sue ragioni, assurga ad educatrice
dell'umanità, è estranea tanto al medioevo quanto alla classicità”.
Ad onta di ciò “il Rinascimento non fu rigoroso, né autonomo né
puristico”. Ancora peggio nell'arte contemporanea, non solo
l'orgoglio, ma la stessa capacità di ascolto di un popolo, non si
manifesta come il vero motore della crescita di una comunità; ancor
peggio la fredda logica dataci dal commercio, che prescinde ed
opprime ogni elemento di valutazione artistica. Perciò nella vanesia
Carrara: - meretrice di ogni orpello burocratico, ma con un forte e
bilanciato sintomo di indisponibilità alla reale valutazione di
impatto socio - economico dell'arte, - nonché restia alla
programmazione culturale del territorio. Una Carrara dimentica della
nostra realtà, che è permeata di forti tradizioni libertarie e ben
salda in una valente impronta storica. Una Carrara dove gli uomini di
valore si valutano per quel che realmente sono, non per qual che
appaiono quando salgono sul tranvai delle ammucchiate clientelari. È
la tranvia che veicola, in tempi moderni, il ruolo della politica e
delle varie correnti, dove vengono pesati e fatti salire, solo, gli
artisti a seconda delle lobby instaurate e l'afflato con gli amici
dei miei amici.
Questo
e un processo di unificazione che sconfessa la frammentarietà della
percezione di una oggetto, come sommatoria di singole sensazioni,
concezione tanto cara alla teoria associazionistica.
Etichettare
la scultura quale arte meccanica è limitativo: non è solo fatica e
sudore e mezzi meccanici che si spendono nell'esecuzione, l'artista
impegna se stesso, sconta la sua partecipazione totale, l'immersione
è completa, dove il ferro altro non è che il prolungamento della
mano; mentre sente il lavoro dentro se stesso. Sono nate così le
grandi opere ed i migliori artigiani, poiché conta moltissimo il
rapporto con la materia, il volgersi della lavorazione, l'ambiente,
la scelta dei mezzi e dei modi. È l'impasto della subbia, gradina,
scalpello tagliente, che corre nel tuo sangue, sciogliendosi mano a
mano in quel bel modellato, che si fa particolare, di un ornato, di
un corpo, di un panneggio, o qualsiasi altra cosa sia l'opera. È il
segno quale espressione arcaica, la più immediata, che nello
scolpire è innato e si trasmette alla genialità delle mani: è la
materia che si compiace prendendo forma dentro la tua
predisposizione mentale, è come “il tratto inciso sulla pietra
quale indizio di un messaggio più complesso”. Questo sentire è
soggettivo ed ha connotato nella storia della scultura il fiorire di
personalità e di opere di grande contenuto stilistico dal
cinquecento in poi. Un esempio per tutti: nella Pietà del Duomo di
Firenze di Michelangelo, fermatevi a contemplare il percorso lasciato
dai ferri , indubbiamente, vi trovate segni di mirabile maestria, ma
anche tracce di un impasto e di una trama che costruiscono
un'immagine concreta del senso, nella sua stessa organizzazione
formale, che non rinvia, puerilmente, a contenuti palesi e alla loro
quotidianità.
Non
dimentichiamoci del processo di parcellizzazione meccanica, poiché
genera o può generare uno scadimento dal sapore di copia. Moltissimi
manufatti testimoniano il contrario, dimostrando ai critici della
vocazione prevalentemente monumentale e celebrativa che questa non
era monotona imitazione, quanto memoria e ricerca del bello, il
brutto è venuto dopo con decadenti performances e la riscoperta di
una qualche concettualizzazione di accatto, che ha ideato dagli
stracci e da materiali immondi una filosofia degli amici: una cultura
degli scambi di favori, un maso chiuso dove tutti si sostengono a
vicenda... manifestando la sfacciataggine di servire la cultura
universale dei popoli. E quando riscriveranno i dieci comandamenti
“della Cicero pro domo sua?”
Il
Repetti paragona l'esecuzione di una qualche statua al lavoro degli
orologiai di Ginevra nella cui fabbrica usasi spartire i dettagli
dei lavori tra diversi operai, cosicché ciascuno si applica ad uno
stesso meccanismo, con gran risparmio di tempo, di fatica e di
spesa... poi l'artista, solo, conclude definitivamente l'opera,
dandogli reale esistenza. Dunque c'è un metodo di divisione che
giustifica e presuppone più professionalità organizzate;
impensabili se non indotte direttamente dall'appartenenza ad una
bottega e dall'apporto di uno speciale insegnamento scolastico. In
questo contesto, dunque, si stagliano vere e proprie identità,
ottime specializzazioni che continuano a guidare ed illuminare ogni
autore. A fronte dell'enunciato: “il buon artigiano esprime e piega
l'arte con la tecnica secondo i canoni fondamentali dell'arte”, ma
quante identità, personalità, impronta propria di una bottega,
possono evadere dalla consunta configurazione commerciale?, vantare
una tradizione ereditaria, una diversità che la identifichi? Nessuna
! Anche perché la compagnia di giro delle specializzazioni, che
gira per i laboratori è la solita: unico cerchio magico
autoreferenziale. Riflettiamo sulla produzione statuaria, del
passato, in gran parte a carattere religioso e civile, conosciuta
come arte minore. Qui, incontriamo spesso immagini altamente
simboliche (forme-modelli originari ); o a forte simbolismo: Icone
marmore a carattere religioso, a fruizione popolare,
indifferentemente collocate sugli altari o nelle nicchie delle
chiese; sui muri delle case o nei crocicchi. Importante dal punto di
vista iconografico è la storia del santo, e l'episodio che gli ha
dato il nome. Individuato, poi, dall'abito portato, e contraddistinto
dal segno che qualifica l'attività svolta ( libro, croce, rotulo).
Oggi, perfino tutto questo ha perso la tradizionale attenzione. Passi
la standardizzazione, ma una cosa, solo belloccia, tirata al fine con
alcune sembianze quantomeno fantasiose è difficile inserirle
nell'ordine dei Santi, Madonne, angeli. È pur vero che ognuno
interpreta come sa' o come gli conviene, ma qui di emotivo e
devozionale non v'è parvenza. Implacabili tagli con il disco
diamantato, pronti per essere spianati con mole e smerigli, e via
andare, i tempi sono grami. Questi tagli, utilizzati anche per lo
sbozzo e la smodellatura, non sono più recuperabili ad un buon
impasto del lavoro ne per una buona resa delle affettuosità del
marmo. È impossibile accompagnare e riprendere questi tagli con i
ferri, armonizzare linee e i segni plastici, soffermarsi sulla
superficie generando graduali passaggi di chiaro scuro. Impossibile
collegare,in sintonia compositiva, varie texture, pettinare trame. La
stessa provocazione, chiamiamola pure colpo di genio dell'inclita o “
innovazione delle tecniche tradizionali, sempre uguali a se stesse”
: apportiamo ad esse modifiche sostanziali , “al si è fatto sempre
così” e, meniamo, su un lavoro rifinito, decisi colpi con i ferri
dell'abbozzatore sulla lucidatura, al fine di ammaccarne la
superficie e renderla crespa; o per staccare di netto una testa più
volte rifatta. Ma per quanto assestati con maestria, le valenti ed
esperte mazzuolate, sul finito, non potranno mai assumere una forma
espressiva particolare, di concerto con il processo creativo
originario. Già in quella differente tonalità dei suoni materici,
nell'impatto sordo dei ferri, i colpi violenti contrastano con la
dovuta ricettività del bianco marmo al comporre gli adeguati tratti
armonici sulle sue molteplici affettuosità: per ciò stesso che la
musicalità dello scalpello produce sempre tracce identitarie assai
diverse dalla cieca muscolosità. Non è così che si dirime il
contenzioso tra artista ed esecutore. Intanto perché il marmo è
materia viva, carne che palpita ( Bernini, ratto di Proserpina ). Il
marmo ha, da sempre, accompagnato la nostra vita quotidiana ( non
solo per gli usi domestici, civili, religiosi ). Dipoi perché gli
artisti moderni che sanno adoperare il marmo ( e pensano la scultura
in marmo) sono rari. Di modo ché l'opera d'arte concepita non è,
da sempre, elemento di condivisione nella comunità all'interno
della quale sarà allocata ( e come dovrebbe essere naturale
agganciata alla sensibilità del luogo ).
E
non solo!, l'incomprensione è tale, che neppure l'esecutore ai suoi
ordini ha la possibilità di collaborare in sintonia con ciò che
l'artista intende fare. E nel contesto di tanta inaffidabilità non è
secondario neppure la qualità del marmo che deve connotare
esteticamente l'opera. Il marmo va scelto anche in funzione delle
destinazioni d'uso, compatibile con altri materiali facenti parte
della composizione architettonica o figurativa che sia ( a cospetto
dell'effetto che si vuol ottenere). Infine la durevolezza considerata
la sua resistenza, se sarà collocato in un interno o alle
intemperie.
AUTONOMIA
DELL'ARTE E TRADIZIONALE DOMINIO.
Finché
l'arte è tutta volta a rappresentare l'ideologia e gli interessi
dominanti, non sarà mai espressione di una libera sponte, di una
proprietà intellettuale dell'individuo, la creazione autonoma della
personalità. L'idea della produttività di un'arte, concepita come
il più naturale dei godimenti della vita, diventerà una proprietà
artistica individuale, quando ci libereremo delle solite creazioni,
non solo meccaniche ed utilitarie, ma degli inutili polpettoni
stilistici, tanto strazianti, quanto difficili da analizzare.
Nessuno
nega che un lavoro di getto, tutto spontaneo, non esprima una
invidiabile freschezza e vivacità, fonte di emozioni ed aperto nel
plasmare un modello estetico originale, sia passato che presente.
Anche scolpire a vista, senza un modello, partendo da un'idea ancora
in embrione, non avendo programmato nulla, affidandosi solo alle
configurazioni della materia e ad essa ispirandosi e seguendole, è
cosa bella e piacevole, nella consapevolezza che il lavoro può anche
risultare mediocre. D'altro canto v'è il suo risvolto, quante grandi
opere hanno visto la luce dopo molti anni di minuziosi ritocchi ? È
il tempo trascorso dagli autori a correggere, limare, ripensare, per
far si che il senso dato abbia la giusta direzione nello spazio di un
significato; affinché essi possano essere almeno testimoni, in
piena libertà, del proprio tempo. Il libero arbitrio è sempre stato
quel bisognoso grande masso da spingere fin sulla cima. Nel nostro
tempo l'obbrobrio non ha limiti: tramite il dominio ideologico, si è
perfino affermata l'imposizione delle parole e di ciò che bello e
gradevole, nell'arte come negli stili di vita e comportamentali;
alfine tutto vive sotto la cappa del mercantilismo, che mai è stato
così oppressivo e imposto da congreghe di ogni genere. La recondita
armonia, come l'invisa poesia, è ignorata, al pari di un canto che
ritrova il genere umano dentro la propria poesia e verità (secondo
la storia, gli eventi, le mutate tendenze culturali ed ideologiche,
vissute). Se poi nel taglio diretto della pietra, si esclude
qualsiasi intermediario tra l'artista che partorisce l'idea e
l'esecutore, l'effetto può risultare di grande unità nella
composizione.
Nessuno
dubita del passato che è sempre più vivo, del quale, dalle macerie,
perfino le pietre parlano della loro esperienza. La moltitudine
gioisce quando incontra il valore espressivo di un qualsiasi segno,
parole, immagini, tracce, e si arricchisce quando da esse l'immagine
sgorgano forti emozioni. E molto dipende dalla forza visiva
dell'immagine, che entrando nella nostra memoria genera affetti ed
affezione. Sostanzialmente, la vera scultura, come ogni altro
linguaggio o comunicazione, più o meno elaborata, è solo ed
esclusivamente segno: significato che organizza intorno a sé
significanti; lo è perfino nella sua collocazione spaziale rispetto
alla posizione dell'osservatore, per cui non potrà mai essere
tendenzialmente una comunicazione effimera, fugace, essendo, per sua
natura prossemica, duratura ed imperitura nella rappresentazione di
civiltà, usi e costumi.
Il
marmo quale materia nobile è, per l'artigiano, pane e companatico e
simbolicamente il suo viatico. E l'affettività verso la materia
traspare dallo spirito con cui la sente, la manipola, fonde in essa
la propria poesia, quasi soggetti di una stesso destino ed
appartenenza. Ecco!, l'impasto marmoreo non è un elemento neutro,
poiché sostanzia l'antico legame formale e percettivo legato
all'uso, all'esperienza, alla tradizione; a culture storiche e
ambientali. Non è un caso che tra i saperi siano comprese le
conoscenze sulle qualità marmoree (dalla candidezza della pasta
interna, alla consistenza della grana e natura cristallina, ai
difetti). “In questo fenomeno percettivo sono, dunque coinvolti,
oltre il nostro stato d'animo e le emozioni, anche, strettamente
legati a questi, la memoria, il vissuto delle nostre esperienze”.
Da
ciò le motivazioni, il tratto singolare di ogni mestierante custode
di quella particolare manualità che lo rende diverso e speciale.
Ma, come ogni altro lavoro, quello della scultura non differisce,
dall'essere metodico e dipendente, secondo le esigenze della
committenza e la qualità delle commissioni. Concettualmente, nella
produzione, dallo scandaglio fino allo sbozzo, per togliere scaglie
in eccesso, vi possono essere ancora voglie di novità, che saranno
molto meno, nella successiva smodellatura, totalmente sostituite, da
gesti ripetitivi dovuti al trasporto dei punti. Ovviati dal
mestierante itinerante che non si pone questo problema, tiene al
risultato, per consegnare il lavoro puntato in ordine, privo di
errori. Poiché mira alla pagnotta e al sovrapprezzo, così come
custodisce gelosamente i segreti del proprio mestiere, che utilizza
di nascosto, menando anche il lavoro di routine. Sarà l'artista,
solo, a completare l'opera a dargli una somiglianza ottimale, dopo
averne assimiliamo l'idea che la motiva e aver ben compreso la
direzione del senso.
Nello
stile dell'artista, non è tanto designata la mercede, che è
stabilita, quanto la fedeltà all'idea. Questa non è facilmente
ottenibile se l'unico obiettivo è quello di finire, in tempi sempre
più brevi, il lavoro, e quando il puntatore non modella come si
conviene, ma spiana con decisi tagli del disco diamantato a ridosso
delle misure puntate, lasciando solchi non accompagnanti passaggi
gradevoli, ma ostinati. Questa esecuzione non tiene, nel giusto
conto, dei profili e masse in armonia tra loro, dei ritmi, del
concerto dell'opera, della quale ne ostenta, sempre di più, la
spigolosità dell'affettato. La materia ne soffre ed anche il
successivo intervento dello scultore a rifinire, utilizzando il
piccolo strato di roba lasciatogli. Vengono così escluse antiche
figure professionali minori, saltate perché si eliminano quei
preziosismi – dovuti alle particolarità distintive dei vari gruppi
scultorei, alle loro movenze, postura, vestimento; fino alla
pulitura-rifinitura – che vengono assegnati alla manualità del
lavoro ordinario, cancellando così specializzazioni non più
rinnovabili nella scuola-bottega-laboratorio, sempre più povere e
lontane dalla pratica e cultura tradizionale. Emotivamente, anche la
semplice incisione dei segni su una pietra o su una statua stele,
lasciati nel tempo, esprimono molto di più dell'odierna statuaria,
in quanto almeno ne interpretiamo gli attributi che ci comunicano
esperienze precedenti, quali simboli archetipo posti nelle case o nei
luoghi di culto ad indicare una particolare funzione. Soprattutto
benché immagini primordiali, queste mantengono un forte legame
ereditario. Invece l'anonima statua di oggi, non la percepiamo
neppure come la più semplice icona votiva, poiché è una parvenza
imposta ai nostri sensi anonimamente, alla pari dei mass-media, che
oltre la parola ci impongono anche la configurazione a senso unico. E
non è un senso imposto dalla moda del momento; no è l'incapacità
di elaborare in proprio modelli, attuare una scelta libera sul senso
e sulla scelta del significato, spingendosi oltre questo, per dare,
all'opera scultoria una sua dignità, non solo per antonomasia. Si
discetta molto di mercato, quale dominus imperante. Ma la legge del
prezzo, della domanda e dell'offerta, riguarda tanto la preziosità
di una materia, quanto la sua rarità rispetto alla sua quantità. Il
metallo o il diamante più prezioso ha già in natura un valore e lo
mantiene. È ricercato. Vieppiù se vi aggiungiamo la magia di una
lavorazione artistica di pregio, che lo rende ancora più unico che
raro, aumenterà o diminuirà, sfidando i tempi, il suo valore? Il
marmo, oro bianco, finirà male, alla “sbrota” ( broscia?), come
l'oro nero.
4°)
ESEGUIRE UNA STATUA DI GRANDEZZA MINORE DEL MODELLO. Ritorniamo ad
operare sul triangolo isoscele. Sia A B l'altezza della statua,
supponiamo cm 50 ; centro in A e B con ampiezza di compasso uguale
all'altezza del modello ( cm 150 ), si descrivono due archi che si
intersecheranno in C ( Tavole 16 e 17 ), C -A- B è IL NOSTRO
TRIANGOLO.
Presa
col compasso una qualsiasi misura uguale al modello, si faccia centro
nel vertice C e si tracci un arco che incontri i lati CA e CB. Poi,
chiudendo le aste del compasso su queste due intersezioni, misuriamo
la distanza della retta CA→CB.
Questa è la misura da riportarsi sul marmo, che sarà sempre, come
tutte le altre a seguire, quella di un segmento parallelo ad A B ( la
parallela ad uno dei lati del triangolo, che incontra gli altri due,
li divide in parti proporzionali). Il proseguimento del lavoro è
uguale alle altre tecniche già descritte.
5°)
Riproduzione delle statue in marmo in scala 1:1. IL PANTOGRAFO. Oggi
sempre più spesso sostituito con l'utilizzo dei compassi.
Per
questo tipo di lavoro, a " ritratto", perché di grandezza
uguale al modello, si adopera il pantografo, detto in gergo "
macchinetta ". E' un braccio snodabile, in ottone, alla cui
estremità è fissata, su un carrello, una punta di acciaio. Il
braccio è imperniato su un'asta mobile e scorrevole, tanto in senso
verticale che orizzontale: mentre il suo perno consente un movimento
di rotazione ed è dotato di un fermo a sua volta mobile che è
fissato ad un regolo, il quale è stretto, con un morsetto, ad una
croce di legno. Questa va ad insediarsi, mediante tre puntali (grossi
chiodi) acuminati, fissati alle estremità dei suoi bracci, in tre
bullette forate nella capocchia: una è conficcate nel modello in un
punto in cima alla testa; le altre due alla base del modello,
comunque sul piano scelto. Nello stesso modo , in correlazione, detti
puntali si inseriscono nei fori del marmo. Nei lavori di pregio,
uguali bullette mozzate, a 5 o più millimetri, si “inmasticiano”
nei fori. Così come nel modello di gesso i puntali sono ospitati nei
fori ricavati da tre chiodi detti bulletta e ivi infissi, gli stessi
puntali della medesima crocetta, sono sempre ospitati nei bulletta,
“bodete”, che sono fissati e cementati in nicchie intagliate nel
marmo: dove, precedentemente si sono scalpellati dei piccoli incavi,
all'interno dei quali si sono praticati tre fori, predisponendovi i
tre capi-punto. I fori ricavati nelle nicchie sono fatti con il
punteruolo. Nell'esecuzione del lavoro, si segue la prassi già
descritta: scandaglio alcune misure di approccio, ecc.. IL modello
verrà tempestato di punti: si comincia a rilevare quelli più alti,
lasciando una matita di " roba ", finché non se ne sarà
ricavato lo sbozzo nelle sue dimensioni approssimative, in funzione
di forme rigorosamente geometrizzate, quelle più emergenti nello
spazio, le quali ne delimitano rigorosamente il volume in forme
elementari di contorno. Indi, si fisseranno le misure quelle "
a buono ", cioè reali. Per mettere i punti si prende una misura
sul modello, con la punta di acciaio che scorre all'estremità del
braccio: la si prende, la si blocca col fermo, si riporta sul marmo,
spostando in blocco tutto l'apparecchio. Questo trasporto altro non è
che il riporto dello stesso piano dal modello a quello identico del
marmo: poiché i tre punti locati in entrambi, rappresentato
dall'insediamento dei tre puntali della crocetta, sono esattamente la
prefigurazione di un piano uguale, per un lavoro in scala 1/1 (a
ritratto). Così partendo da una base comune, piano, il fermo
sull'asta indicherà quanto marmo occorre cavare. Questa operazione
dovrà essere ripetuta ogni qualvolta si porta una misura del modello
sul marmo. Tavola 18.
Seguono
altre tavole illustrative della materia trattata.
PANTOGRAFO.
Metodo.
La
partenza è data attraverso un piano comune, del modello e della
statua, che di solito è quello più funzionale e che meglio si
presta a posizionare la crocetta e quindi il pantografo:
posizionamento atto a sfruttare tutte le possibilità di abbracciare
con precisione tutte le parti e poter mettere i punti nel piano
individuato. Desideriamo mimare Michelangelo, per meglio cominciare a
togliere il superfluo, che è il vero spirito della scultura.
L'approccio alla sbozzatura dipende dagli atteggiamenti della figura,
dalle sue sporgenze, rilievi e sotto squadra. Anche in questa che è
una riproduzione dal vero, il concetto di piano è fondamentale, e
vede la figura da un unico punto di vista, prima di scoprire le sue
tre dimensioni. La convenienza alcune volte trova l'approccio
posizionando il modello e la statua orizzontalmente, come negli
esempi precedentemente detti, e solo dopo si metterà la figura nella
sua posizione eretta o progettata; nelle altre, la statua è
verticale sulla sua base o piedistallo naturale. Tutto dipende dalle
scelte per lo svolgimento del nostro intaglio, che avverrà
considerando il rapporto di due parallelepipedi, esaminando il
particolare geometrismo della figura. Il lavoro parte sempre tra due
piani a piombo, o traguardati e a livello: perciò, nel caso
specifico, quando spostiamo la crocetta, spostiamo tutto l'apparato,
piani compresi. E' come se trasferissimo dal modello al marmo lo
stesso, identico, piano; e difatti è così: poiché con il braccio e
la punta di acciaio si prende una misura sul modello e la si riporta,
pari pari, sul blocco, ma l'effetto è come se fossimo fissi su un
unica posizione: stanziali su piani congrui.
Per
ottenere un ottimo risultato dobbiamo posizionare strategicamente la
crocetta, unica e certa guida, la quale ci consente, anche con prime
misurazioni a scandaglio, una postura della figura che prevede già,
il modello-statua dentro un parallelepipedo che ha lo stesso volume
del blocco. Insomma, questi deve poter contenere agevolmente la
figura.
Cominciamo
a fissare i punti maggiormente in rilievo: siccome il blocco è
ancora grezzo, la punta dell'asta non cadrà, ancora, nella esatta
profondità marcata dal punto e dal piano del modello: il fermo
dell'asta sollevato indicherà l'esatta quantità di “roba” da
togliere. È prassi comune lasciare, d'acchito, una matita di materia
( 5 o più millimetri) per dare una prima sgrossata al modello.
Comincia così lo sbozzo, facendo emergere via via le parti più in
rilievo: significa che le misure portate lasceranno un funzionale
spessore di marmo in più, e i punti non saranno fissati
definitivamente, “ a buono”. Si lascia quello spessore di una
matita di “roba”, partendo da un punto di vista frontale e
arretrando fino ad ottenere forme grossolane, una bozza, composta di
figure solide elementari.
Finito
l'abbozzo, si comincia a mettere i punti definitivi, “ a bon”.
Nel fissare questi, si faccia attenzione non solo alla precisione, ma
alla loro collocazione strategica: far sì che seguano i profili e la
plasticità della figura, come nell'eseguire la precisa trama e
l'ordito di un tessuto: il movimento non è molto dissimile dal
tratteggio di un buon disegno, quando occorre dare plasticità,
linearità e volume ad un qualsiasi oggetto. Solo che sul marmo lo si
fa' con i ferri, seguendo il tratto con la subbia che precede la
gradina e vari scalpelli, favorendo quel bel modellato che già da' ,
di sé, una prima idea della texture della statua, mentre essa si
fa' via a via più somigliante. E non è la mimesi il principale dei
contenuti; al contrario lo è il modo di essere di tali segni,
diversi in ogni libera manifesta interpretazione, nella loro qualità
estetica, così come vengono mostrati nella singolare organizzazione
formale ed esibiti, lontano dal modello concreto dei contenuti, che
sta altrove; qui è in gioco quella sensibilità formale, che mostra
in sé il senso vero, interprete originale dei modi di essere del
linguaggio. È il canto e la poesia degli strumenti, orchestrata
dalla sensibilità della mano che si fa poesia e solfeggio mirabile,
con il dono della maestria che ha caratterizzato questa qualità, per
secoli, con la bellezza ideale dell'arte e l'umiltà del mestiere.
Poesie:
ICONA
MARMOREA :
BIANCA
MATERIA
PLASMATA
DA UNA MANO IGNOTA.
ICONA
ANTICA CHE DI CARRARA
SEI
INTRISA
DI
SECOLI E DI STORIA.
D'UN
TRATTO
FIORISCI
NEL NUDO MURO
DI
UNA CASA.
NELL'ANIMA
DI MARMO
CUSTODISCI
LA VERITA'
E
IL PRINCIPIO DELLA VITA.
L'ETERNO,
ABBRACCI,
IN
DIGNITOSO SILENZIO.
MONTAGNA
MADRE
TRA
CUPI VERDI
E
GRIGI NUDI E ARSI
INCOMBE
BIANCA
L'ONDA
LUNGA SU MISEGLIA.
SULLE
ALTE CIME
MAI
VIOLATE PRIMA
STAN
CONSUMANDO TEMPI DI RAPINA.
CAMBIANO
VOLTO ALLA MONTAGNA
CHE
DA SEMPRE ACCOMPAGNA
LA
VITA E LA GENTE DI CARRARA.
OGGI,
APPARE
EFFIMERO FONDALE
D'UN
TEATRO SILENZIOSO ED OTTUSO.
LO
SCEMPIO
SI
VEDE DA QUI.
ALMA
VITTORIA CORDIVIOLA ESTRATTO
DAL
LIBRO “ POESIE INCIVILI “
Note
e tavole alla tesi Paolo.
NOTA
N° 1:
CARRARESI
A ROMA DI GIANCARLO BENEO, INDICE DEGLI AUTORI DA PG. 13 A PAG 126.
NOTA
N° 2:
SCULTURA
A CARRARA “OTTOCENTO”. SOMMARIO:
IL
MARMO, LE CAVE, LA CITTA' DI M. DE MICHELI
ARTE
E MANIFATTURA DEL MARMO A CARRARA DI G.L. MELLINI.
FRA
ARTE E MESTIERE: IL RITORNO DELLA SCULTURA DI M. BERTOZZI.
GLI
ARTISTI, BIOGRAFIA A CURA DI R.CAROZZI.
LE
TAVOLE TECNICHE E ILLUSTRATIVE – CHE SUGUONO LE NOTE UNO E DUE –
INIZIANO DAL NUMERO 3 FINO AL 22.
PRECISAZIONI
SULLA TECNICA DEL TRIANGOLO ISOSCELE.
Alcune
volte si sono fatte osservazioni in merito alle difficoltà, per i
novizi, di utilizzare i compassi con il sistema dell'arco di cerchio
tangente, sul triangolo rettangolo, per rilevarne le misure
proporzionali relative. Abbiamo, a proposito una tecnica più
semplice e molto precisa, quella di utilizzare, quando è possibile
il triangolo isoscele. Ma quando è possibile? La condizione prima è
quella di operare su un modello che è maggiore della metà della
altezza della statua. Nell'esempio già citato ( statua cm 160: 2
=
cm 80<
di cm100 del modello, che supera la metà della statua ). Questa
disponibilità ci consente - incrociando i compassi aperti su cm
100, e puntandoli prima su A e poi su B – di segnare le
intersezioni dovute, partendo dal segmento AB relativo alla statua
( cm. 160 ). Anche qualora non vi fosse tale disponibilità, è pur
sempre possibile operare su un'altezza maggiore della statua di
almeno 1/4 e finanche di 1/6. La soluzione non è complicatissima:
abbiamo già operato sul triangolo isoscele nel terzo degli esempi
(tesi Paolo). Qui, se utilizziamo una grandezza superiore ad ¼,
abbiamo, pur sempre, la necessità di superare la metà della statua:
e lo facciamo raddoppiando la grandezza del modello. Supponiamo esso
sia di cm 42 - che, moltiplicato per 2, è uguale a cm 84, maggiore
di 160:2 = 80 <
cm 84. Quindi possiamo
agevolmente effettuare la nostra intersezione. Con un particolare
accorgimento: così come abbiamo raddoppiato l'altezza per costruire
il triangolo isoscele, dobbiamo riportare su esso, raddoppiata, ogni
e qualsiasi altra misura presa dal modello. Sia nel trasporto dei
capi-punto come per tutti gli altri necessari all'intaglio, c'è
questo obbligo sulle misure prese: cosicché dopo aver raddoppiato
l'apertura del compasso lo si porta sul lato A-C e, con il doppio
passo ( rotazione su una punta ), si porta come già esperito la
misura in AB allungandola fino ad A. E' questa una semplice
rotazione, poiché, portando la misura su AC, si tiene ferma la
seconda punta – quella più vicina a C – e si porta la prima su
AB in maniera di poter allungare la punta del compasso fino ad A.
Stessa operazione su detto 1/6 , che esige triplicate tutte le
relative misure, tal quale l'esempio sopra descritto (il raddoppio).
Nel
disegno in scala, statua cm.160:10 = cm 16; mentre il modello cm.
42:10 = cm 4,2. Scala 1:10 ( unità di misura uguale al metro ).
Tavola 23.
Abbiamo
considerato, precedentemente, le scale di proporzione per copie più
grandi del modello, e dello stesso triangolo isoscele. Qui, ci
occupiamo di un triangolo per eseguire una statua minore del modello.
Il progetto ora è diverso, ma comanda ancora l'altezza della statua
da farsi, che, pur assumendo il ruolo di variabile indipendente,
mantiene comunque il quoziente del rapporto dei due numeri dati in un
certo ordine (quelli di ogni proporzione). Il metodo è sempre quello
dei triangoli simili, si segna l'altezza del blocco (statua da farsi)
su AB, poi, apertura del compasso con ampiezza uguale a quella del
modello (altezza), centrando prima in A e poi in B, trovo la loro
intersezione che mi darà C. Di seguito, per ogni misura presa dal
modello, una punta faccia centro in C, vertice del triangolo
isoscele, l'altra disegnerà un arco, la cui corda, intersecando i
lati AC e BC, sarà la misura DE da riportarsi sul marmo. Così si
procede per ogni altra misura: centro in C, segno l'arco, poi stringo
il compasso sui due punti di contatto, con le altezze del modello,
misurando la relativa corda che sarà la riduzione voluta. Vedi
tavola n° .Tutte queste operazioni raffigurano triangoli simili.
Nella prima delle operazioni abbiamo la similitudine di ABC e CDE:
per cui ad AC sta AB come CD sta DE (AC:AB=CD:DE).
Sul
triangolo isoscele la riduzione, a stringere, è come quella da
effettuarsi sul triangolo rettangolo. Per le statue di minore o
maggiore grandezza è sempre l'altezza della statua che
comanda,abbiamo dovuto ridurre il triangolo pari a un 1/3, e poi
moltiplicare la misura, in scala, trovata per tre. Queste le
operazioni fatte nei precedenti esercizi.
Continuiamo
ora con un nuovo esempio, e operiamo sul David di Michelangelo,
indicando già le misure, sia del modello sia della statua. Prendiamo
di esso una copia in gesso o resina, che è cm. 408 di altezza,
desiderando intagliare in marmo una statua di cm.102, quindi in scala
di riduzione. Per far ciò, dovremmo disporre di compassi molto
grandi ed allestire un triangolo avente un lato di cm. 408, mentre
l'altro è di cm. 102. Ben si comprende che dovendo trasferire le
misure di un colosso, i compassi dovrebbero aprirsi alla stesse
grandezze del modello e del triangolo ( da cm. 102 fino a 408). Per
questa misura maggiore, può essere utile dividerla per due,
lasciando invariata la misura della statua che è di cm.102; quindi,
408 : 2 = cm. 204. Fermo restando il rapporto dei numeri del modello
e della statua che è il quoziente quattro (408 : 102 = 4). Ciò
significa che ogni misura rilevata verrà ridotta ad 1/4 (se una
misura presa sul modello, ad esempio cm. 80, quella che verrà
trasferita sul marmo sarà di cm.20, cm 80:4= 20). E cioè: 408 : 102
= 80 : X = cm 20. Questa è la proporzione nell'ipotesi che tutte le
misure restino invariate ( cm. 408 e cm. 102 ). Altrimenti se
riduciamo la misura che comanda che è di cm. 408 e la dividiamo per
2, abbiamo questa riduzione da recuperare. Infatti la proporzione è
la seguente, sia 204: 102 = 80: X = 40, che è la riduzione da
recuperare; e quindi, ancora 40:2= 20, misura reale del triangolo
facilitato. Questi venti centimetri sono il corrispettivo della
riduzione di una misura del modello, cm. 8O, nella proporzione della
statua di cm. 102. Non dimentichiamoci che siamo in scala di
riduzione e non di ingrandimento, verso la quale abbiamo l'obbligo
della moltiplicazione.
IL
BISOGNO ESTETICO DELL'UOMO.
Bisogno
di arte.
Considerato
il contesto primordiale nel quale si organizzò l'attività umana,
non si esclude che essa si esplicò su innati bisogni essenziali: -
nell'indagine sull'ambiente per assicurarsi migliori condizioni di
vita ( conoscere per meglio corrispondere agli stimoli vitali ); -
nello interrogarsi sulla propria esistenza, su ciò che ha dato
origine alla vita; sul significato della morte ( all'aldilà ). Non è
facile elencare una lista dei bisogni umani. “La psicologia
caratterizza il bisogno nella carenza totale o parziale degli
elementi di benessere innati e/o ambiti dalla persona. Alcuni
fondamentali sono necessari alla sopravvivenza e sviluppo dell'essere
individuale e sociale, quali l'alimentazione, la propria sicurezza e
la miglior gradevolezza dell'esistenza; infine quella
dell'affettività sessuale che costituisce l'essenza della
prosecuzione della razza”.
Poiché
l'uomo non è soltanto istinto e pura animalità, se così fosse non
ci saremo mai evoluti, dobbiamo considerare come le straordinarie
bellezze dell'universo mondo lo abbiano ispirato, quale grande
protagonista e intermediario, abbagliato, tra l'immenso spettacolo
della volta del cielo e la natura incontaminata circostante; quando
non è il grande mare a stupirlo, con i suoi infiniti orizzonti.
Quali emozioni estetiche avranno provato quei primitivi? Quali
pulsioni e facoltà spirituali si saranno attivate? La vita di allora
certamente non piana, da reinventare giorno per giorno, determinò la
naturale reazione di alleviare l'esistenza con il bisogno estetico:
sicuramente il godimento contemplativo originò l'attività
artistica, avendo come prima fonte la natura che è in grado di
impressionare i singoli esseri, elevandoli spiritualmente, così come
tutti gli aspetti più belli ancor oggi ci rasserenano. “ Il bello
è qualcosa che ha forma, quindi tra perfezione e armonia” E. Kant.
Fu grazie a questo appagamento che l'uomo poté superare la barbarie
e percorrere più velocemente il binario della civiltà. Oltre a ciò,
nell'epoca considerata, le prime esperienze espressive orbitavano,
tutte, nelle misere pratiche del ristretto gruppo della tribù.
Quindi le prime forme artistiche nascono con l'uomo stesso; nascono
dalla realtà e dalla vita stessa, stimolando una spiritualità
contaminante in tutti i luoghi abitati. Lo provano i numerosi oggetti
a carattere estetico, quantunque modestissimi caratterizzati, sempre,
dalla funzionalità e utilità del manufatto. Di fatto però, “ il
sentimento del bello non va confuso con il piacevole, che è invece
collegato alla reale esistenza dell'oggetto”. E. Kant. E' ovvio che
la potenza produttiva, come il concetto del bello, segue lo sviluppo
delle civiltà, indispensabili per il maturare delle condizioni di
istruzioni, esperienza e, in determinate condizioni socio-economiche,
il genio della mente e l'intelligenza della mano. Infine, “ il
bello è ciò che piace universalmente, condiviso da tutti, senza che
sia sottomesso a qualche concetto o ragionamento, ma vissuto
spontaneamente come bello”. E. Kant.
Nasce
così l'arte come espressione di regole genuine, si è tentati di
dire artigianali, in continua lotta con l'innovazione. Il bello si ha
quando nelle cose si trovano armonia e giuste proporzioni. “La
bellezza è qualità percepite che suscitano sensazioni piacevoli che
attribuiamo a concetti, oggetti, animali o persone nell'universo
osservato, che si sente istantaneamente durante l'esperienza, che si
sviluppa spontaneamente e tende a collegarsi ad un contenuto
emozionale positivo, in seguito ad un rapido paragone effettuato
consciamente od inconsciamente, con un canone di riferimento
interiore che può essere innato oppure acquisito per istruzione o
per consuetudine sociale”. E. Kant. “....l'ordine e l'armonia ,
mimesi naturalistica, valutabili per il piacere visivo che producono
, valgono in quanto ripetono rapporti e leggi della natura e del
corpo umano”. .. ..G.C. ARGAN. Potremo dire che l'arte non è per
gli occhi ma per l'anima: non è esclusivamente per ciò che uno
vede, ma per come lo vede, rispetto alle sensazioni/emozioni che
prova. È lo spirito che ognuno sa immettere nella materia preferita,
anch'essa parte di una stessa appartenenza e sulla quale l'artista
ha trasfuso la propria poesia. In questo senso la materia non è mai
un elemento neutro, poiché sostanzia il legame tra funzionalità
della cosa e senso estetico del manufatto. Lo sa bene l'artigiano che
convive con la materia, che è per esso pane e companatico, un
viatico quotidiano, nei cui confronti, ogni volta, rinnova un'impresa
ed una competitività da intraprendere giorno dopo giorno: con tale
impegno e sacrificio gli da vita e ne ricava il necessario per
vivere. Diamo all'artigianato ciò che è dell'artigianato, che ha,
da un lato, per sua destinazione e uso, almeno il privilegio di
essere libero e affrancato da tutti quei condizionamenti che l'arte
moderna impone, con tutte quelle sue astrusità espressive, che si
nascondono dietro il nulla imposto dall'anarchia compositiva e
“l'eccelso” materiale dello straccivendolo. Arte artigianale
servile? Anche l'arte classica lo è, se comandata dalla religione,
dal Principe, dal mercante? No! Perché l'artista puro non è mai
stato asservito. È come il buon artigiano mantiene la capacità di
trasmettere emozioni, che costituiscono un vero e proprio linguaggio.
Poiché l'arte nel suo significato più ampio di espressione
estetica, comprende ogni attività umana creativa, svolta
singolarmente o collettivamente. Purtroppo, l'arte classica è la
sola che è rimasta, in tutti i tempi, fonte inesauribile di emozione
estetica. Oppure è considerata servile in quanto utile a qualcuno o
a qualcosa nel risponde ad una precisa esigenza o rappresentazione di
un ideale (“l'arte esprime la bellezza morale e spirituale mediante
la bellezza fisica”. Cousin). Certo il pericolo è sempre
incombente, quando un'opera è portata a buon fine con una tecnica
impeccabile e rispondente alla commessa richiesta. Ma se il
committente fosse appunto “quell'idea” nata dai lombi di quelle
tante divinità, oggi imperanti, e liberamente prigioniere solo
dell'oligarchia dei galleristi e speculatori vari, quanto del “vile
danaro per ogni moccio” , obbligatoriamente dato a chi,
politicamente corretto, è contro l'arte servile? Una cosa è certa,
escludendo l'arte con la - A - maiuscola, “ l'artigianato
rappresenta uno dei pochissimi attori di continuità culturale nella
storia e nel costume di un popolo, nell'espressione di una creatività
che si fonda sull'intelligenza della mano di cui la destrezza è
parte, e che ancora dipende dall'approvazione del senso estetico” .
È questa la crisi della nozione del bello? La dannazione per chi ha
coltivato la monumentalità e l'arte celebrativa e retorica? Cosi
interpretando, quanta sperimentazione alla elaborazione della
tradizione va perduta, e quindi la riedizione di nuovi linguaggi. Se
si escludono le radici di un popolo, a quali soggetti della vita
reale si attinge; a quale realtà, quotidianità e concreto vissuto
si contribuisce, collegando il prodotto arte ad una produzione
diretta e moderna, significante, del senso in se stesso? A quale
funzione artistica si potrà far riferimento? Certamente, a quella
intesa a conciliare il mercato con il libero scambio e il valore
aggiunto dell'opera ideata, maggiorata da quello dei materiali usati,
con le preziosità e originalità della tecnologia. La tecnica è
utilissima, per meglio governare la propria sensibilità ed ampliare
la possibilità di riprodurre tutto ciò che è fonte di ispirazione,
ma non sempre è essenziale, eccezionalmente la sola spontaneità
costituisce la vera originalità di ogni artista nella sua personale
distinzione. Distinzione e personalità per uscire da codici
rigidamente determinati, frutto della trasmissione di un sapere
artigianale rigido, chiuso in se stesso e ad ogni diversità. Troppo
determinato e chiuso nella sua caparbia conoscenza tecnica. Questa
ultima considerazione, che esprime un particolare squilibrio, può
riguardare la purezza e la completezza di alcuni singoli, i quali,
impadronitisi del mestiere, ed l'unico e solo loro vanto, ignorano
quella sensibilità artistica ed artigianale,che è lo specchio delle
sensazioni provate. Dunque potremo dire “ un'arte per l'anima non
solo per gli occhi”. Ma senza un briciolo di tecnica, adeguata al
proprio ego, come può essere difesa l'originalità
dell'ispirazione?, è possibile generalizzare semplicità e
autosufficienza creativa? Cioè una tecnica non imparata, autogena,
valida ad esprimere universali sentimenti ( una particolare
autogamia: una specie di parafrasi all'auto fecondazione artistica).
L'esperienza e la storia ci raccontano altro, una sempre maggiore
quantità di persone nutre una generale devozione verso i tantissimi
capolavori che, prodotti con tecniche raffinate, catturano
costantemente la loro ammirazione. Gli è che, nella modernità, si
ha da “concionare” solo di riproduzioni, per lo più brutte,
escludendo quell'abilissima tecnica che sa' perfettamente
interpretare l'idea dell'artista e non ne mortifica né la libera
espressione di lui né l'armonia e la sostanziale poesia dell'opera.
La storia delle botteghe carraresi ne è una testimonianza storica
inconfutabile. Il buon artigiano aveva ed ha questo compito
interpretativo, anche se, all'interno del manifesto virtuosismo,
nessuno può negare il sorgere di alcune rare genialità artistiche.
Nel bene e nel male tutte le opere dell'uomo hanno un senso: la
natura ed il godimento contemplativo che ispirano la creatività
artistica; l'utilità del lavoro dell'artigiano estroso e le sue
stesse modeste riproduzioni. Nel contesto delle attività umane,
tutte queste rappresentano uno stile o la particolare realtà che le
hanno ispirate, affidando loro la vocazione di rappresentare una
funzione o di soddisfare bisogni, che esprimono i gusti di un'epoca e
ne rappresentano una concreta testimonianza. E' innegabile, l'armonia
e la perfezione sono pur sempre piacevolezza indotta.
Avanguardismo
e astrattismo, nelle loro rappresentazioni di disordine e disarmonia,
non rappresentano sempre un linguaggio compreso e condiviso; ciò non
significa che non vi siano, in questi movimenti, anche opere
pregevoli. Quindi, ritorniamo al punto di partenza, quando ci
troviamo di fronte ad un codice incomprensibile e ognuno di noi può
darvi la sua occasionale interpretazione. Riusciamo, invece, a
condividere o comprendere quasi tutto, dei moltissimi studi del
moderno linguaggio visivo, che sono studi della percezione visiva,
del segno, delle superfici, il colore, il volume e la luce; e poi lo
spazio la composizione, le tecniche, ecc. ecc.
L'anatema
di oggi, è quello smisurato ego che disturba, quel “ solo
concepimento dell'idea”, imperitura, universale, indiscutibile
(perché, in alcuni casi, sfida solo i posteri); oppure l'emozione ed
il godimento è solo del fautore. E l'arte della provocazione è
un'arte al di sopra di tutto e di tutti: fuorché dalla pubblicità,
che dà notorietà, che a sua volta dà successo; dal quale sorgono
stima, onore, gloria e ricchezza. Gli Dei sono avvisati. La critica
seria si adegui, il popolo pure.
E'
quel Fiat, quel Deus: quell'attimo e quella luce Divina, che solo
alcuni eletti possiedono, con lo “spotico” predominio delle idee:
idee che però non si realizzano “ se non vi sono quegli stradivari
che mettono a posto le loro, tante, magagne “. Tant'è che il
mestierante e l'artigiano, con grande sensibilità e generosità,
hanno saputo interpretare, spesso da piccoli modelli malfatti,
grandiosi capolavori. E' questa la vera storia delle botteghe
Carraresi.
La
tecnica è indispensabile se ha il dono dell'umiltà e la capacità
di immedesimarsi nell'idea dell'autore: ci riferiamo a quella
sensibilità, anch'essa distinta forma d'arte, traccia, segno, di
forti personalità artigianali, che sanno esprimere, con il
linguaggio della loro poesia, l'originalità dell'ispirazione. Perciò
non riusciamo a dimenticare l'idea del “bello obiettivo”, così
diffuso nella natura e nella vita, che è nella composizione
dell'armonia cosmica e nell'ordine della disposizione del creato.
Avvertiamo che esso equivale a serenità e bellezza; è avverso ad
ogni bruttura, al di là del tema religioso e dell'origine di ogni
cosa. Al contrario l'arte moderna, in gran parte della sua infinita
produzione, disdegna qualsiasi regola o canone compositivo. Disdegna
altre sì ogni giudizio critico, quand'anche fosse quello che gli
riconosce una piena libertà espressiva. Nel modo siffatto gli autori
costringono l'universalità dell'arte a deformarsi, ad umiliarsi,
spesso annichilendosi secondo le esigenze di fortuite e sgangherate
originalità che rappresentano un eufemismo per non dire che trattasi
solo di provocazione: o meglio un piegarsi della socialità
universale all'opera di un LUI o di un LORO. L'individuo oggi ha la
capacità di essere singolo individuo e contemporaneamente
collettivo. L'uomo collettivo è giustificato a concepire l'arte come
la nuova coscienza collettiva del nuovo mondo. Se avessimo la
capacità di comunicare con un linguaggio comprensibile a tutti - un
codice e realtà maggiormente condivise - oltre a migliorare le
generali relazioni, avremo una coscienza globale nei confronti di
comuni interessi. Il sapere collettivo consente di cogliere meglio
ogni segno e movimento sociale o artistico. E' per questo che l'arte
si gloria sempre del suo passato anche il più remoto ed è fonte
inesauribile di emozione estetiche per tutti: archetipo e memoria a
cui si ricorrere nei periodi di decadenza.
L'ammirazione
extra arte verso l'artigianato è benvoluta nei confronti di un
oggetto ben fatto, funzionale ( utilizzo e gradimento primario ).
Riflettiamo
su un qualsiasi oggetto utile, e anche alla sua forma che si ripete
più volte, modulo, alla sua applicazione nella composizione
modulare, che può assumere valore connotativo in progettazione
complesse ed eleganti design; ma può descrivere solamente l'oggetto
nel suo uso comune, quotidiano, e quindi denotarsi. Abbiamo in mente
il mortaio asservito al pestare, ma che il designer industriale ne ha
colto tutte le suggestive forme elementari, riempiendo di stucchi
colorati i vuoti e, giocando con l'accostamento delle forme, ha ben
distinto la loro figura dallo sfondo, ottenendo le cosiddette figure
ambigue, dove si percepisce ora una immagine ora un'altra,
alternativamente. Questa costruzione modulare si è fatta per i
pavimenti e per i rivestimenti esterni e/o interni.
E'
sorprendente che Carrara, una città permeata da un'antica tradizione
artigianale e con un passato artistico notevole, non abbia conservato
una forte coscienza di sé, riducendosi ad una funzione marginale
dell'arte e dell'artigianato d'arte: e quindi solo ad una appendice
commerciale e mimesi meccanica. Salvo lodevoli eccezioni, si è
passati dalle “botteghe” di un tempo agli odierni bottegai,
venditori di brutte opere. Oltre l'innovazione, dove è finita quella
cultura che sola è rappresentativa del futuro dell'artigianato.
Consideriamo la diversità dei mezzi e modi di lavorazione che si
confrontano e diversificano (scuole, botteghe?). Di certo una
diversità nell'organizzare un gruppo strutturato di segni, intorno a
strutture espressive. Diverse le personalità, lo stile, che
reinventano la realtà, nella migliore interpretazione di un'idea,
nel rispetto di ogni sensibilità. Artigianato come unico fattore di
continuità culturale nella storia e nel costume di un popolo: di
grande innovazione sì, ma contemporaneamente espressione di un
creatività che tramanda di sé componenti etniche, sociali,
estetiche, economiche e religiose; tutte espressioni di una società
sinceramente rivoluzionaria e indomabile.
Nei
momenti di grande sconforto non è facile ripensare “Carrara e la
sua gente”, il ritmo materico dei laboratori sparsi nei vari borghi
e ambienti (posti), veri luoghi della memoria ( quel ponte, quella
chiesa, il particolare palazzo). Tutti ormai soggetti a mutazioni e
monotonia e malinconicamente persi, persino dalle vivacità vocianti
dei suoi “bardassi”. Serpeggia qua e là ombre di una solitudine
uggiosa senza neppure il conforto dei vecchi lampioni scomparsi nel
tempo.
Riemergono,
a contrasto, come fantasmi della memoria, le consunte immagini dello
stuolo degli antichi lavoranti: scalpellini, ornatisti, scultori....,
via via che il tintinnio dei ferri scema dentro di noi. Forti si
sentono ancora i lazzi degli “sfottò”, che maturavano i novizi
portandoli alla padronanza del mestiere. La restante arte prova ad
affacciarsi dai vicoli bui, oscuri perché senz'anima; ché
devitalizzati e senza più identità: dove lo storico non è più
storico ed il Centro non è più tale.
Allora
lo sguardo volge lassù, verso quella montagna imponente e diafana
che da sempre ha segnato il destino delle sue genti. Volge lassù
verso quello storico compendio di blocchi sparsi: informi, abbozzati,
squadrati, che ancora portano dentro di sé il risuonare di martelli
e scarpelli. Una Carrara ricca dei suoi tanti mestieri, gelosa dei
suoi saperi e delle sue scuole-bottega, è amata per la visibilità
delle sue opere ben fatte (a regola d'arte). Una grande città perché
ha dotato, di una superiore intelligenza, la mano di un esercito di
artigiani.
Fuori
dalle gelosie e dalla concorrenza, una risposta gli artigiani sono
tenuti a darla: alla tradizione, al centro storico, alla loro
sopravvivenza.
C'è
bisogno di condividere esperienze, visibilità, minori costi ed un
cartello che rappresenti le produzioni lapidee presenti nel
territorio.
Una
vetrina nel Centro Storico, con esposizioni qualificate e permanenti,
abbinate ad un turismo selezionato, potrebbero essere una prima
risposta.
Mi
ha colpito un sunto di E.Repetti : “Nella maggior parte dei
comunelli , il complesso dei quali forma la comunità di Carrara, i
principali abitanti riunironsi in società sotto il nome di
VICINANZA,
acquistarono
in comune degli agri, frantoi, e molini, ne affidarono
l'amministrazione ad un agente amovibile, e si obbligarono ciascuno
verso tutti, e tutti verso ciascuno.....”.
L'inciso
del Repetti suggerisce un legame con il territorio, partendo dai suoi
bisogni e dalla sue particolari esigenze produttive più popolari e
gradite, quale bene collettivo e preziosità insite nel patrimonio
genetico comune, di una Carrara che brama riappropriarsi della
propria storia e radici connesse. Purtroppo, questi orizzonti sono
nascosti nelle pieghe, scivolose, di una tradizione e una
innovazione, sempre più in contrasto tra loro, e storicamente
lontane da un qualsiasi collegamento scolastico e di bottega. Lavori
e manufatti, dell'oggi, che, nella quasi totalità, evadono da
quella eccellente manualità e inventiva che era il vanto del
patrimonio artistico Carrarese, peculiarità e grandezza dei nostri
maestri. Oggi rimane solo il commercio spicciolo, frutto di modeste
piccole vanità e spartizione di tutto ciò che si può spartire:
alla barbarie non c'è mai fine. Perciò, in contrasto, l'associarsi
presuppone un incontro sociale ed amministrativo, tra i primi attori
di ogni attività artistica ( scuole, botteghe artigiane, Enti
locali, Fondazioni preposte, singole personalità ). Ne abbiamo
assoluta contezza, così ci è sembrato l'auspicio del Repetti
richiamato all'inizio. Cioè costruzione di strutture organizzative
predisposte all'uopo, per meglio lievitare la produzione artigianale
Carrarese di eccellenza, riscoprendo e facendo leva sull'unicità e
la sapienza tecnica del nostro patrimonio collettivo.
Domandiamoci,
inoltre, rispetto a quale domanda si riparametra l'offerta locale,
sul brutto dell'arte commerciale o funeraria che fa' degli sgorbi il
proprio modello? Mentre gli innovatori non sono da meno. Sarà
possibile un'offerta migliore?
Un
orizzonte l'artigianato e l'arte Carrarese se lo può dare,
attraverso un approfondimento degli aspetti più belli del localismo
e dentro quel vissuto che ha consentito di respirare il piacere
dell'armonia, della sapienza tecnica, coltivando fior di
specializzazioni. Lo erano e sono manualità e innovazioni giocate,
fin quasi alla soglia del Duemila, sul terreno della ricerca e sulla
preziosità di un prodotto, reso insostituibile per stili di
lavorazioni e di linguaggio; insomma, una ragione identitaria, il
vero marchio delle scuole bottega. E all'interno di questi valori, la
capacità di comunicarsi innovazioni, di contaminarsi a vicenda, di
essere sistema e cartello, in un contesto europeo ricco di
intellettualità elevate, costantemente alla scoperta di nuove
ideologie. E nell'insieme, vicissitudini di una tradizione
marmoraria non sempre fatta di cose belle e buone, sostanziata,
spesso, dal dolore e dalla esasperazione, della miseria al seguito
di un mercato e di una produzione non sempre generosa.
Ma
il vero nodo gordiano da sciogliere ha la sua consistenza nei costi e
nella concorrenza, accettare la sfida accampando l'unicità di una
offerta internazionale. Dobbiamo riuscire a contrapporre la
incomparabile bellezza di un prodotto, il marmo, nei confronti del
quale non abbiamo saputo esaltarne la bellezza e la funzione,
rispetto alla sua godibilità e autentica e rara e classica
lavorazione. Ma come si approccia un simile risultato? Nel nome
della scultura si è fatto di tutto e di più, utilizzando
materiali diversi e anche spregevoli. La scultura originale nostra è
un'altra cosa, ha la sua fonte in Michelangelo e nei grandi artisti
del passato. Poiché i suoi natali sono le molteplici possibilità
espressive, a principiare dalla scultura del “non finito” e del
finito che ha un suo particolare codice e ritmo secondo le dimensioni
che possono assumere i segni: cioè un messaggio, di per sé,
compiuto, o gruppi di significati poeticamente organizzati ; oppure
composizioni contrastanti e sequenze di significati. Tutto è
possibile, persino un messaggio appena suggerito, incompiuto. In
Michelangelo è la enucleazione di un'idea: la scultura come processo
graduale di liberazione della forma dalla materia. E nessuno può
negare che in tutto ciò vi è il godimento dato dal passaggio dei
ferri, manovrati magistralmente e fautori di stupendi effetti
plastici . Tutto sembra seguire i tratti di uno stesso disegno
michelangiolesco, già compresso dentro di sé: e perciò segni che
escono rapidi e sicuri, in linee, trame, chiari e scuri, senza
tentennamenti, perché già posseduti da quel sasso. E' di questo
prodotto che stiamo ragionando, della sua immagine, di farlo vivere
nel suo habitat naturale, il centro storico, con le su botteghe, i
suoi atelier, i luoghi tradizionali di ritrovo ( caffè, bar ? ),
dove si possa discutere e familiarizzare, nel bel mezzo di un fiorire
di botteghe d'arte e di presenze artistiche. Tutto nel rispetto
rigoroso di una città che ha avuto e merita ancora nobili
testimonianze all'altezza delle sue tradizioni.
Altro
che arte meccanica che genera sudore, quindi grande riflessione
sulla manualità dei nostri artigiani e sul loro passato. Certo,
l'abuso dei tagli dati con il flessibile, come percussioni alla
cieca, sono impossibili da recuperarsi e lontanissimi da
quell'intaglio che fa' emergere gradualmente il modellato. E'
sufficiente guardare I PRIGIONI di Michelangelo, oppure il San
Matteo e le sue ultime Pietà: e osservare quei tratti di subbia
accanto a rifiniture compiute, o la bellezza dei contrasti e delle
texture; e nell'insieme la capacità di manovrare il ferro,
martellato con colpi dati in giusta percussione e trasporto, che
mangiano il marmo senza sbocconcellamenti, pestature o biascicamenti.
Vi è tutto il passaggio di Subbie e subbiette, non a pizzicare ma a
tracciate, a correre con un tratteggio allineato e parallelo. Non
raramente si trova l'ugnetto nei sotto squadra e profondità.
Cosicché il marmo viene mangiato unito, non zappato, e le figure
acquistano le forme prefissate, già nella mente come nel modello. E
di seguito vanno la gradine, e i vari e diversi scalpelli, prima di
passare alla pulitura, levigatura, lucidatura, se prevista.
Il
godimento dell'intaglio e dei volumi non emergono, se spiritualità e
manualità non si completano. Non si può apprezzare questa abilità
e intelligenza delle mani, se non si imposta correttamente il lavoro.
L'un caso l'abbiamo dianzi descritto, un pasticciare la materia,
prendendo inutili scorciatoia: sbassi e tagli traumatici, che tolgono
sì molta materia, velocemente, ma non impastano il marmo con
quella gradevolezza necessaria ad armonizzare e rendere puro un buon
lavoro ( di questo si è già detto parafrasando il codice di un buon
disegno e i molteplici significanti disponibili e organizzati dal
tratteggio e sfumature). L'altro riguarda l'eccesso di trasposizione
meccanica dei punti nella smodellatura: in questo caso il lavoro
perde di freschezza, cioè quella caratteristica propria
dell'intaglio diretto e della spontaneità. ( Come nel campo della
recitazione, spontaneità e lettura pedante contrastano e fanno la
differenza ). Se osserviamo le opere di Bistolfi, ad esempio
nell'esecuzione dell'Armonia ( Città del Messico ),
notiamo
sì un eccesso di tecnicismo, nel trasporto dei punti e nella
esecuzione perfetta: Bistolfi è un virtuoso nell'esaltazione di
ogni singolo passaggio, così preciso ed obbligato da stupire i
migliori professionisti. Le Sue mani miracolose elevano la pasta del
marmo aldilà di quella specifica qualità che appartiene
naturalmente alla materia, donando ad essa il soffio della vitalità,
che la fanno più bella, non ricca, e all'insieme, quel magistrale
sentire che l'ottimo scultore cova dentro di sé, ingravidato
dall'idea-soggetto-significato.
Sono
questi i fenomeni specialissimi nel campo dell'arte, facenti parte
del bello oggettivo. Ne consegue che l'idea sovrana è sempre
pensata, e soprattutto sentita, in marmo o in pietra, perciò
l'attore si immedesima nella più consonante delle materie,
assumendo la particolarità del marmo di farsi duttile e di
veicolare, con la sua lucentezza e colore, la forza istintiva e
immediata delle passioni, espressa con poesia da quel poeta che, da
essa e con essa, sa riconoscersi ed esprimersi.
Perciò
l'ammaestramento ed il praticantato hanno da essere esercitati da
quei notevoli artisti e mestieranti che si cimentano con il marmo
quotidianamente nelle botteghe e nelle cave. Ecco! Una valida
proposta che può dare sostanza e spessore all'insegnamento nelle
scuole d'arte carraresi, soprattutto in quelle professionali. In
questo contesto non può venir meno lo studio della litologia, in
particolare dei marmi e loro giacimenti.
LA
COMPOSIZIONE
FORME
CHIUSE FORME APERTE.
A
Carrara hanno lavorato e si sono formati in prestigiose botteghe e in
un'eccellente Accademia, gran parte dei maggiori scultori di ogni
epoca, educati all'affettività di un materiale vivente e di notevole
personalità, il marmo! Un materiale che ha avuto la prima culla
sulle falde del Monte Sacro ed è stato nutrito da una musa di nome
Euritmia: “ la nascita di Euritmia avviene in Grecia, per indicare
il bello soggettivamente condizionato, che non consiste nella
armonica composizione delle parti di un oggetto, bensì
nell'impressione di armoniosità che esso procura” . Non è chiaro
cosa questo parto significhi, ma diamo per scontato che il verbo
degli Dei è sempre enigmatico. Invece siamo certi che il bianco
statuario di Carrara per sua natura si predispone, per le sue eccelse
qualità, a rappresentare il bello ideale, comunque ad esprimere ogni
cosa sublime. Sulle statue e sui monumenti scolpiti, nelle Apuane,
desideriamo scrivere alcune pagine affinché si aprano al linguaggio
dei sentimenti nelle arti figurative. Iniziamo con due termini a
confronto, EURITMIA contrapposto a SIMMETRIA. E' evidente che la loro
distinzione è molto sottile: la simmetria nasce dalla proporzione
(accordo sulla totalità delle misure e giusta distribuzione dei
moduli ); “l'euritmia è il bello e grato aspetto cagionato dalla
disposizione delle membra”. Sembrerebbe che la prima sia riferita
alla quantità e quest'ultima alla qualità. A parte che anche nel
mondo antico i due termini tendevano ad assimilarsi; nel senso comune
oggi per simmetria intendiamo una cosa diversa, siamo portati a
concludere che due o più parti simmetriche sono uguali : spesso
facciamo riferimento, tenendo conto della simmetria bilaterale del
corpo umano, al piano sagittale mediano o piano di simmetria,
utilissimo nell'avvio del lavoro di scultura. L'euritmia sarebbe un
rinnovamento delle proporzioni del canone di Policleto. E' Lisippo
che mette mano a correttivi parziali per migliorare il punto di vista
dello spettatore e conquistare la profondità dello spazio
(tridimensionalità). Nella veduta frontale dell'Apoxyòmenos,
nonostante che dalla testa, più piccola, alle membra e a tutto il
corpo, l'insieme sia più snello e sottile, rimane quel brutto
scorcio del braccio destro. E' vero Lisippo tende al movimento e
all'equilibrio instabile rispetto alla stabilità policletea: tutto
il peso del corpo si sposta, bilanciandosi alternativamente sulle
gambe (e quella destra si allarga un po' troppo), seguendo il
movimento avanti/indietro dello strigìle, ma la visione che riassume
tutte le altre, e rimane unica, è laterale anziché frontale. “
Una composizione sbilanciata, non da' un senso di sicurezza, di
affermazione, trasmette casualità e precarietà ”. Siamo ancora
lontani dal movimento di quelle linee forza dette serpentinate, che
coinvolgono lo spettatore a girarci intorno e che si presenteranno
come forme aperte: da “ Il Ratto delle Sabine a Il Mercurio del
Gianbologna ”. L'Apoxyòmenos non è una forma chiusa, rompe il
parallelismo dei piani anteriore e posteriore, ma la vitalità delle
masse muscolari è presente solo sulla schiena; infine, quelle
braccia protese in avanti non sono esteticamente gradevoli. La
dimostrazione più evidente l'abbiamo nei cosiddetti “Bronzi di
Riace”, che precedono di molto l'epoca dell'Atleta di Lisippo. Essi
sono bilanciati e ponderati come il Doriforo, ma ben più alti e più
saldi al suolo , con una maggiore accentuazione delle masse muscolari
( qui è evidente la grande differenza, a livello artistico, tra i
bronzi originali e tutte le copie pervenuteci dalle statue in marmo
in epoca romana ). I Bronzi di Riace con la loro bellezza e assoluta
vivacità, già enucleano che l'intimo ritmo può portare alla
nascita della poesia nel processo creativo. E tutto questo è merito
della sintesi di Policleto nello studio sui Kùroi e di averli
razionalizzati e tradotti in un trattato. “ Il ritmo ha un ruolo
fondamentale nella creazione dell'opera espressiva. Al pari della
proporzione ne è un elemento imprescindibile, fino ad assumere esso
stesso un valore creativo autonomo”. E' specifico il riferimento al
Doriforo, “ che rappresenta l'ideale greco di coerenza razionale
...”ossia l'ideale di perfetta proporzionalità”. Per il medico
Galeno ( II secolo d.C.), la bellezza consiste nell'armonica
proporzione delle parti, di un dito rispetto all'altro, di tutte le
dita rispetto alla mano, del resto della mano rispetto all'intero
braccio, infine di tutte le parti a tutte le a altre...”, cioè un
gradimento estetico dato dalla ripetizione armoniosa e continua di
uno stesso modulo che diviene ritmo modulare . Mentre il chiasmo lo
riteniamo un ritmo alternato, alla pari di spazi pieni e vuoti di un
edificio. “ Questa corrispondenza da' ordine e varietà. Perciò i
retori greci la paragonavano alla struttura di un periodo
armonicamente costruito con quattro frasi giustapposte, perché
quattro sono gli elementi fondamentali messi in relazione fra loro”.
( Un piacere, come leggere A. Manzoni ! ). Se il ritmo è alla base
di molte forme espressive dell'uomo, e ne scandisce la stessa
organizzazione della vita quotidiana, l'equilibrio stabile di
Policleto, detto “ponderazione”, è una postura che, mantenendo
la figura ben salda sulle gambe e il baricentro dentro la sua base di
appoggio, non può che esprimere un atteggiamento di coerenza nel
mantenere ferme le proprie prerogative. Se l'Apoxyòmenos rappresenta
con la tridimensionalità l'esistenza concreta dell'uomo sulla terra,
il Doriforo ben saldo sui piedi da l'idea di difendersi bene dalla
precarietà della vita, esponendo la sua verità: “ perché la
realtà molteplice che noi vediamo quotidianamente è solo
un'apparenza transitoria, è solo una copia dell'idea”. Quindi,
è “ l'idea unica “ dell'arte greca che elevatasi dalla
realtà perviene alla verità. In questo senso il ritmo è movimento,
poiché è percepito come una successione di eventi: quando questi si
alternano con una certa regolarità; in quanto un sentire primigenio
può precedere le forme espressive anticipando la nascita dell'idea e
l'immagine.
Il
Doriforo nella sua bellezza statica si riallaccia all'arcaismo e
all'idealizzazione greca, osserva la realtà ma è contro
l'apparenza, e tutto relaziona all'uomo eterno, immutabile, perfetto:
“ l'uomo è misura di tutte le cose.” Resta un interrogativo di
fondo, sulla corrispondenza implicita del Chiasmo o Chiasma (
incrocio a forma di X ). Perché i greci la paragonavano a quattro
frasi giustapposte?, mentre i latini parlano di “quadratio” per
indicare che quattro sono gli elementi messi in relazione tra loro.
Si esaurisce tutto in questo contesto “l'ideale greco di coerenza
razionale “ o va oltre? “ Secondo la tradizione medica greca la
salute è data dall'equilibrio di quattro umori o sostanze fluide :
SANGUE, FLEMMA, BILE GIALLA, BILE NERA, collegati secondo
caratteristiche fisiologiche e predisposizioni intellettuali. Per gli
scrittori arabi, collegamento con i quattro umori i quattro
temperamenti: SANGUIGNO, FLEMMATICO, COLLERICO, MELANCONICO; e i
quattro pianeti principali: GIOVE, SATURNO, MERCURIO, VENERE.
Nell'antichità, il numero QUATTRO ricorre insistentemente, sarà
utopia rilevarne una qualche assonanza, insieme a molti sostanziali
dubbi.
I
Segni
Sulle
tante opere dedotte dai testi d'arte, desideriamo fare alcune
riflessioni sul linguaggio visuale. Anzitutto premettiamo una scheda
didattica: “la figura umana ha una sua architettura espressa da
forme standardizzate, organizzate da elementi geometrici e secondo le
leggi della proporzione, in varie epoche stabilite. Sono figure
geometriche derivanti dalle forme base, riconoscibili nel triangolo
equilatero, il quadrato e il cerchio. Contestualmente, gli altri
segni fondamentali del linguaggio e relazionati tra loro mediante la
grammatica visuale, sono: il punto, la linea, la superficie, il
volume, lo spazio, la luce, il colore” . Alcuni di questi, dianzi
detti, possono sembrare accostamenti impropri con la scultura e molto
più affini alla pittura e al disegno, ma non è così. Oggi il
linguaggio è un sistema di segni condivisi, non più riferito
esclusivamente a quello verbale, ma comprende tutto il sistema dei
segni. E nonostante l'enorme portata comunicativa delle immagini è
necessario acquisire tutti gli strumenti per interpretarle e leggerle
se, gradualmente, si desidera scoprire la loro immensa potenzialità
creativa. E' pur vero che ognuno di noi vede ciò che sa' e vi
attribuisce un valore singolare, ma ci si può educare e imparare a
saper leggere e interpretare. Nel contesto delle arti visuali si
sappia almeno riconoscere le differenze elementari: ad esempio, per
una scultura destinata agli spazi del territorio, si pensa che nella
composizione si debba tener conto dei fattori esterni, quali la
morfologia del territorio, il tessuto urbanistico, la preesistenza di
vincoli naturali. Tali differenze sono da considerare, rispetto ad
altre inserite in contesti diversi. Dunque, se i segni utilizzati dal
linguaggio si strutturano e si relazionano in modelli espressivi
diversi, “diciamo anche che un'opera d'arte non si preoccupa
principalmente di indicare contenuti esterni, quanto identificare gli
elementi che costituiscono il modello (forme, colori, superfici,
masse, ecc..ecc..) e assegnare al loro assetto una significazione.”
Tali segni hanno una validità compositiva plurima. Pensiamo solo
alla linea come mezzo espressivo, e dei significati che può assumere
retta rigida (stabilità), curva (movimento), spezzata (dinamica);
linea mista, compendio delle precedenti (tensione), e cosi via. In
una scultura l'impiego di “marcati andamenti lineari continui e
fluenti, possono privare il marmo della sua consistenza di materia.”
Sono alcuni esempi, non sottovalutandone altri: la linea di contorno,
la linea che costruisce le forme e i volumi e la decorazione. Non
desideriamo privarci neppure di superfici texturizzate, non potendo,
qui, esaurire le ampie possibilità di comunicare dei segni. Non a
caso le opere figurative stimolano in noi una forte emozione
estetica. Proviamo, nella scultura, a tracciare alcune parti con la
gradina e/o la subbia, contrapposte ad altre levigate o lucide, il
contrasto è evidente e non è molto dissimile dal tratteggio di un
buon disegno. Oppure ricavare delle ombreggiature scavando nel marmo
e accostandolo al chiaro dei rilievi. “Lavorando e scavando la
pietra in modo da catturare o rimandare la luce in gradazioni
diverse, Bernini ha creato l'illusione di un continuo trapasso di
superfici differenti”. Nei suoi stupendi ritratti, egli affermava
che , lo scultore, più che copiare il modello, doveva creare una
potente illusione di individualità, proprio per “far sì che un
marmo bianco pigli la somiglianza di una persona che ha spirito e
vita”. “ E talvolta per imitare il naturale bisogna fare ciò che
nel naturale non c'è”. Citava l'esempio di come, volendo imitare
l'alone intorno agli occhi, occorreva scavare il marmo nel punto
dove si trova il livido. A questo legava un altra illusorietà: la
vitalità di azione e il saper cogliere un atto caratteristico del
modello ed imitarlo. Ecco!, come, per ottenere tutti gli effetti del
colore, l'arte della scultura, deve poter contraffare il biancore del
marmo. Così come le superfici si possono trattare in maniere
diverse, e ottenere superfici texturizzate composte da segni
organizzati, uguali o simili accostati, intrecciati in maniera
casuale o disposti ritmicamente in modo da formare reticoli omogenei.
Infine renderle morbide e sinuose, predisponendo linee sfuggenti, nel
panneggio come in alcune o tutte le parti anatomiche. Il senso di
questo nostro ultimo approfondimento è supportato dall'opera del
ticinese Stefano Maderno, Santa Cecilia Roma, 1600. “Il marmo
sembra privato della sua consistenza di materia, percorso in
superficie da marcati andamenti lineari, continui e fluenti ( la
Santa è coricata su un fianco, le braccia allungate lungo il corpo
in linea con le gambe, seguono il panneggio ed il copricapo nel
copioso defluire verso l'imbuto dei piedi, NDR ). I rilevi tracciati
lungo i panneggi delle stoffe conferiscono all'insieme un senso di
controllato dinamismo e sembrano segnare le linee di forza della
figura.” Interagendo, arbitrariamente e fantasiosamente, solo da un
punto di vista tecnico, sull'espressività della statua di Maderno,
potremo interrompere detto fluire inserendo un tratto di plasticità,
a contrasto, esclusivamente per dimostrare le molteplici possibilità
segniche disponibili. Guai a farlo!, è brutto anche come paradosso.
Tutto ciò a dimostrare come il segno nella scultura è la parola
data alla mano intelligente, è il manifestarsi di un linguaggio
attraverso il gioco dei riflessi della luce e dei volumi. Nulla
avviene a caso quando si intacca la consistenza materica, altro è
l'approccio tra la pietra ed un materiale nobile come il marmo,
poiché diverse sono le affettuosità ed i metodi della lavorazione;
come diverse e volute dall'artista sono le scabrosità, porosità e
modulazioni della materia. Non è neppure da sottovalutare la
bellezza e l'impatto estetico del materiale grezzo, ne la sue
originali scabrosità e grumi, godibili e plasmabili da chi li sa
leggere ed elaborare, che ramifica in essi gli arbusti della propria
fantasia.
La
scultura è un linguaggio a tutti gli effetti. E non mancano le
convenzioni di segni e simboli che, nel loro valore connotativo, sono
ricchissimi di sistemi segnici, “ che si addensano come a grappolo
intorno al significato primario.” Non mancano le convenzioni di
segni simbolici, riferiti alla storia, alla cultura, ad abitudini e
usi regionali, all'umanità di un'epoca; alle figure retoriche ed
altro.
Le
forme base.
“
Le
forme geometriche elementari sono state considerate depositarie di
significati legati a concetti di equilibrio e di perfezione,
assumendo per questo un elevato valore simbolico”.
Alle
forme base, in vari periodi, hanno attinto varie figure professionali
( scultori, architetti, pittori, ecc. ). “ Poiché sentirono che le
figure geometriche non sono soltanto astrazioni matematiche, ma che
hanno una loro vita, un'intima dinamica estetica, perciò hanno
affidato all'equilibrio di quelle il loro messaggio espressivo”. “
E soprattutto a quella perfezione formale che richiede rigorosamente
l'uso della riga, squadra e compassi”.
“
La
figura geometrica può essere considerata da tre punti di vista, per
rispondere a tre diverse finalità: a) in funzione di calcolo
matematico; b) ai fini della costruzione pratica di un oggetto, c) in
funzione puramente estetica”. Poniamo l'esclusivo interesse su
quest'ultima impostazione, interessati solo alla composizione, in
particolare al movimento e alla forma. L'artista, lo scultore, quando
progetta una statua, utilizza le figure geometriche sul piano
estetico, seguendo delle regole compositive diverse, secondo la
tecnica e la materia trattata: il marmo, il gesso, la creta ecc...
Egli predispone, l'insieme, secondo la sua particolare personalità
e sintonia. Cosicché le luci, le ombre, i volumi, sono organizzati
aderendo ad una stessa logica e stile, in modo da consentire la
medesima lettura organica della composizione visiva, tale da
percepire la totalità dell'assetto dell'immagine e la genuinità del
messaggio dato ( spesso prezioso e godibile anche nei particolari
dell'opera: siano essi di movimento o staticità, di tensione e
drammaticità o frutto di un equilibrio armonicamente costruito). Non
è esclusa la grandezza o dimensione della figura umana in rapporto
alla spazio stabilito che può dilatarsi o restringersi a seconda dei
rapporti tra pieni e vuoti ( nicchia, facciata , pareti di interni
organizzati). L'atteggiamento della figura, in questo contesto, ha il
compito di affidare alle linee principali la definizione della
struttura portante dell'opera, essenziale nel determinare l'impianto
compositivo. Non a caso abbiamo inserito, per meglio precisare, il
rapporto tra significato, la mera espressione geometrica, e
significante, cioè i simboli universali: il cerchio = l'infinito; il
triangolo=concretezza; il quadrato= doppio triangolo, molteplicità
delle cose; i quali fin dall'antichità hanno ispirato l'impianto di
grandiose decorazioni, di monumenti e templi. Perciò
“l'atteggiamento del corpo umano ha un valore essenziale fissato da
assi ( andamenti verticali, obliqui, orizzontali) da parallelismi e
angolature”, nel contesto di un susseguirsi di regole compositive
maturate nei secoli e secondo i costumi, le correnti e le mode, che
hanno via via caratterizzato il messaggio visivo. Dialoghiamo con due
esemplari pittorici (affreschi): - Giotto, San Francesco dona il
mantello. “E' una sapiente costruzione delle principali linee
oblique che hanno origine nel centro in corrispondenza della testa
del santo, dove massima è la forza della composizione, e
conseguentemente il suo centro virtuale nella confluenza dei crinali
delle montagne” ; - Paolo Uccello, Giovanni Acuto. “La
prospettiva è duplice: Il basamento è visto dal basso e il gruppo
equestre ha il punto di vista all'altezza dell'osservatore. Tutto è
sottoposto ad una rigorosa geometria: il rettangolo della
composizione è diviso dalle diagonali e dalle linee di mezzeria
orizzontale e verticale, che convergono al centro, separando il
gruppo equestre dal basamento. Le forme principali del cavallo sono
racchiuse in cerchi, mentre le zampe si dispongono secondo le
direttrici diagonali.”
I
valori espressivi hanno valenza universale, poiché il valore
dell'armonia è comune a tutte le arti, nel linguaggio della
scrittura, come nella musica, parimenti a quelli già citati. Ogni
opera poggia sulla costruzione interiore degli artisti, oltre ad
essere presente anche nella natura e negli oggetti o cose che
provochino una sensazione. Queste sensazioni sono associate al
movimento e all'armonia che proviamo nella vita quotidiana, insieme
al ritmo che ha un ruolo fondamentale nella creazione dell'opera
espressiva. E' sufficiente gustare i passaggi di un genio,
Michelangelo, lo Stradivari Rinascimentale che, oltre a suonare
meravigliose composizioni, fornisce modelli per arrivare alla
perfezione costruttiva ed espressiva. Rivediamoci ogni tanto due
rilievi marmorei, entrambi modelli rappresentativi: la Madonna con il
Bambino e San Giovannino (il Tondo Taddei e il Tondo Pitti).
Al
pari della proporzione, il ritmo dell'immagine, che è movimento, è
dato da una successione di segni, o di colori, o di forme ( in musica
di suoni, nella danza di gesti), che si ripetono ad intervalli
regolari. Il ritmo che è alla base di molte delle nostre forme
espressive, percepisce i segni di un andamento che può essere
misurato o sfumare all'infinito ( una fila di alberi o di case
dileguarsi in una strada; un colonnato che scorre in un ambiente ).
Ma anche la facciata di una basilica, i bassorilievi di monumenti
grandiosi, o gli ampi e lunghissimi corridoi dei palazzi d'epoca,
possono ospitare opere scultorie di ragguardevoli dimensioni. Qui da
un punto di vista estetico si può giocare con le composizioni,
secondo l'armonia e l'estro: sperimentare L'ALTERNANZA, soggetti e
atteggiamenti diversi. LA SIMMETRIA, tra le pareti opposte del
corridoio, o intorno ad un elemento architettonico ritenuto
importante. LA PROGRESSIONE, altezza, profondità e scorcio di
un'opera. LA CONVERGENZA O LA DIVERGENZA, intorno ad un nucleo
centrale ( di tipo statico o dinamico, come abbiamo più volte
illustrato). La stessa fuga di piani che, nella prospettiva degradano
verso l'orizzonte, sono una possibilità espressiva utilizzata anche
da Michelangelo, nella Madonna della Scala con la tecnica del rilievo
“stiacciato” e l'idea di un centro ( dalla torsione del giovane
sulla scala incombente a quella del Bambino in grembo ); ma
sopratutto ispirata all'altra idea geniale di Donatello, suo Maestro
ideale, quella del rilievo marmoreo del basamento per il San Giorgio.
Oltre
a questi, altri elementi concorrono ad aumentare il valore emozionale
in ogni opera d'arte. Riconsideriamo quelli dianzi espressi, quali la
“ripetizione, l'alternanza, la simmetria; la progressione e la
convergenza o divergenza”. Non è necessario neppure uno sforzo di
fantasia per intuire che in una statua la posizione delle varie
articolazioni del corpo o il loro bilanciamento possono assumere
tutte queste posizioni, compreso l'equilibrio di gruppi di figure
intorno al personaggio centrale. Altrettanto lo è il segno quando
vuole andare oltre il normale significato ed assumere un valore
connotativo. E' il caso della molteplicità dei segni grafici e
plastici utilizzabili, progetti di texture e di atteggiamenti
amplissimi, compresi in incisioni variamente modulate. E' il caso di
una ricerca accurata sulle potenzialità della materia, oltre il
trattamento delle superfici, dove l'impasto della stessa ed il
rapporto tra materia - luce - spazio è in grado di generare tutti i
passaggi desiderati: vibrazioni e modulazioni, porosità o ruvidezze;
e nel migliore dei casi il sempre armonioso segno dei ferri.
Ma
in quanti modi (stili) si possono esprimere il movimento e la
dinamica in un'opera, se molteplici sono gli atteggiamenti possibili
della figura umana?, anche volendo definire solamente il carattere di
una persona, la sua interiorità, nonché lo spirito; oppure la
situazione spettacolare, partendo semplicemente dalla descrizione di
alcuni degli atteggiamenti espressivi del volto, in sintonia con la
conseguente motivazione anatomica complessiva? Motivare il dramma, la
disperazione, il dolore profondo, significa contagiare la dinamica
muscolare complessiva adeguandola a tale atteggiamento. Il migliore
dei modi, per descriverli è senz'altro quello dell'osservazione e
studio dei corpi viventi.
Eppure
si parla da tempo anche di un linguaggio del movimento inteso come
organizzazione di segni gestuali o motori o corporei: “ LINGUAGGIO
MOTORIO, DEL CORPO, GESTUALE.
Il
linguaggio del MOVIMENTO.
Se
oggi il linguaggio è un sistema di segni condivisi, di tutti i
sistemi, è bene chiarire di cosa si tratta: " il segno è un
significante che si usa al posto del significato". Come già più
volte asserito.
Ritornando
alla poetica Michelangiolesca, proviamo ad interpretare quell'idea
che vive eternamente e che l'artista ha il compito di liberare dalla
materia: il David, simbolo della repubblica fiorentina, è l'uomo
rinascimentale che combatte i tiranni, e, conseguentemente, è dotato
di una grande superiorità e forza morale, datagli dalla ragione e
dalla fede. Tutto questo come è espresso nella composizione? “Dai
possenti rilievi anatomici del busto", dalla compostezza
classica, da quelle grandi mani: l'una che sostiene la fionda e
l'altra abbandonata lungo la gamba, che impugna il sasso. E' questa
l'interpretazione? Diffonde, l'insieme, il senso di un grande
movimento in potenza? Tutto interno, psicologico. Calma e padronanza
anticipano l'avvenimento straordinario? La concentrazione intensa, la
plasticità di quella meravigliosa testa dominante, pensierosa, ma
consapevole della propria virtù, confortano positivamente? E'
certamente un grande evento che sta' per effettuarsi, per mezzo di
questo eroe nudo, "armato solo della sua spiritualità e ferma
convinzione". Sono questi,consapevolmente, i significanti del
medesimo significato. Lo stesso dicasi per le criticate sproporzioni
della statua: è vero il canone di Policleto non è rispettato, per
questo, le volute e mancate proporzioni, la rendono più espressiva.
E opportunamente, dal busto partono rilievi anatomici accentuati in
un forte movimento che, dall'attacco del collo, invadono la testa
imponente, ampiamente contenuta in quell'arricciolato di capelli.
Una similare simbologia la si può raffigurare nel meraviglioso San
Giorgio di Donatello ( Bargello Fi. ). Del quale il Vasari ebbe a
scrivere: " Fece figura di San Giorgio armato vivissima; nella
testa della quale si conosce la bellezza della gioventù, l'animo e
il valore delle armi, una vivacità fieramente terribile, ED UN
MERAVIGLIOSO GESTO DI MUOVERSI DENTRO A QUEL SASSO" . È la
traduzione poetica di quel movimento a spirale innalzato dal
mantello, a partire da dietro la gamba destra; così esprimendo,
rispetto ai tempi, una realtà segnica innovativa e moderna.
Mentre
non lo è per niente il Mercurio del Giambologna, con il suo slancio
atletico, in equilibrio sì, ma infisso come un palo al suo sostegno.
Più
felice l'Apollo e Dafne del Bernini, nel suo "leggiadro
atteggiamento, quasi ballettistico", con quelle foglie mosse dal
vento del rapimento e dal crescere della metamorfosi, improvvisa,
della donna in albero di alloro: c'è grande musicalità, e
penetrazione nello spazio, in questa forma aperta, rispetto alla
forma chiusa del parallelepipedo Michelangiolesco.
Di
Michelangelo si è tenuto in grande considerazione il " non
finito", che è anch'esso espressione di un significante usato
al posto di un significato. Chi non è scultore difficilmente può
provare il sentire dentro di se' la forza dell'impasto che preme, e
la forma che si fa' ora virtù plastica ora linguaggio coloristico,
mentre il ferro penetra nel marmo cavando, esattamente, quel tanto di
materiale voluto; di poi, proprio queste tracce che, scolpite con
grande godimento dall'artista, si arricchiranno maggiormente con il
passar del tempo, pregnanti di eterno sapere mostreranno, sempre, una
loro particolare bellezza.
Abbiamo
considerato il segno come un significante che sta' per qualcosa di
altro. In questo senso ci piace elencare alcune tecniche del
movimento, purché siano considerate con indulgenza e beneficio
dell'inventario: "vibrante modellazione, movimento in stasi,
plastiche dinamiche e profilo lineare guizzante; nervosità del
movimento muscolare affiorante sotto la pelle, panneggi svolazzanti,
linea a serpentina vibrante. Sono tecniche utilizzate per
rappresentare: - un tipo di texture, - la plasticità e il volume; -
lo slancio atletico come la penetrazione nello spazio; oppure, la
postura classica e l'armonia delle proporzioni, in quell'ordine che
esprime l'idea di bellezza greca".
IL
MARMO
La
stessa estensione del significato della parola marmo, è usata a
denotare i calcari che si dicono solitamente cristallini, cioè le
rocce formate da un aggregato di grani di calcite, ma il vocabolo
sta' per qualcos'altro: dalla qualità del pulimento che gli da'
intensità e vivacità del colore; dal suo impiego greggio; o quando
assume una lavorazione e/o lucidatura parziale a seconda della sua
finezza di grana. Infine, se il significato e proprietà del marmo è
quella di lasciarsi scolpire, segare e lucidare per mezzo di adatti
strumenti, la sua connotazione è la diretta conseguenza delle
molteplici espressioni e lavorazioni che può assumere la materia a
seconda dello stile, del linguaggio e poetica dell'artista. Il marmo
in se' già esprime notevoli eccellenze per la sua perfetta
scolpibilità, ma ciò non nega ulteriori scelte per colore e
venature. Infine, i marmi teneri e duri: teneri per delicati lavori
di ornato; duri quando si devono ricavare stacchi fragilissimi. E'
comprensibile, che la scelta dipende "dalla espressione "
propria dello scultore.
SCULTURA:
la poetica, le tecniche, il punto di vista.
Ragioniamo
su alcune osservazioni, allorquando un artista si accinge a
rappresentare un'idea.
Si
da' per certo che si vuol realizzare ciò che si è già concepito
nella mente: ossia l'oggetto preciso della nostra immaginazione. La
differenza sostanziale tra opere fatte e finite è, nel confronto,
tra la freschezza dell'una, nell'esprimere di getto l'idea originale,
e un'altra troppo cincischiata e leccata, che può soddisfare
l'occhio, essendo di grande pulimento, ma alla fin fine inespressiva.
Naturalmente,
non vi è contrasto con l'adoperarsi a perfezionare il massimo di
carica espressiva. Non vi è debolezza nel voler strutturare un
messaggio più complesso, purché questa sia la vera intenzione e
tensione iniziale: è giusto che l'idea sia fatta crescere, maturare,
e sia precisata ulteriormente con uno studio ed una lavorazione
sempre più raffinata, fino a portare le superfici anche al massimo
di pulimento (lucide a specchio). Poniamo di assumere il tema del
rapporto uomo – ambiente, uomo soggetto e/o protagonista; come
realizziamo o consideriamo lo spazio in cui collocare tale figura? La
pittura e l'architettura possono far ricorso alla prospettiva lineare
dandovi profondità ed indicando spazi e oggetti umanizzati. Lo
scultore lavora sul pieno e sul volume, non sul vuoto dello spazio.
Ripetiamolo, per esso, fin dalla sbozzatura più che nella
smodellatura, esiste il valore espressivo ed estetico della
geometria, utile per meglio orientare l'opera. Già qui comincia a
rendersi conto del volume, dei contorni e delle masse ( sporgenze e
rientranze ); per mezzo delle quali, con lo scolpire per piani
degradanti, si precisano meglio l'andamento degli assi ( orizzontali,
verticali, obliqui ) che determinano il ritmo della composizione.
Sono gli assi che suggeriscono la direzione dei piani da fissare con
l'ausilio del trasporto dei "punti" nelle varie fasi della
lavorazione. Viceversa nell'intaglio diretto è la buona conoscenza
del disegno e lo studio accurato in tutte le sue parti dell'opera,
che guida la mano dello scultore, anche attraverso varie simulazioni
di un modellino in creta. Ci si riferisce, a mo' d'esempio, all'arte
dei grandi: ( Donatello, San Giovanni Evangelista, Firenze ) - “
l'Apostolo si gira leggermente, collocandosi nello spazio sia con la
sporgenza delle gambe, sia con il busto che vi si collega mediante la
linea obliqua della mano e il passaggio graduale, verso la verticale,
dell'avambraccio e del braccio...” ; - (Donatello, San Giorgio,
Firenze ) “ Ha la sua radice nell'identificazione stilistica del
moto, spazio e saldezza plastica. Lo scudo, oltre a segnare col suo
spigolo l'asse della composizione , con l'obliquità delle sue due
ali traccia confini sicuri nello spazio alla figura, abbracciandola
completamente nella postura delle gambe e, attraverso la spirale
avvolgente del manto, afferra ruotando il braccio sinistro per
concludersi nel nodo quasi all'altezza della spalla destra.”
Queste
citazioni ripropongono l'uomo e lo spazio in una antica dialettica
classica dai termini noti: la composta staticità e la dinamica che
esprime la continuità del movimento delle figure soggetto nello
spazio. "Il contenuto spaziale della composizione in sintonia
con l'accamparsi dinamico del volume , rilancia l'aspetto di una
umanità rinata e fieramente armata di nobili ideali più che una
immagine emaciata". Ma come vengono percepiti questi genuini
tentativi di rinnovamento? Nel primo Rinascimento la postura esprime
equilibrio e compostezza della figura, recuperando la bellezza
Classica. Privilegiati due punti di vista frontale e posteriore: la
figura è inserita in un perfetto parallelepipedo. I corpi sono quasi
dei solidi geometrici. Nel tardo Rinascimento, l'abbandono
dell'equilibrio e la figura tormentata, costruita sullo schema a
spirale, moltiplicano i punti di vista. Perciò Il Mercurio del
Giambologna anticipa un'identificazione stilistica più moderna:
esprime una infinità di punti di vista, la sua struttura visiva è
stata definita stellare o raggiata, proprio perché la figura
costituisce il punto centrale intorno a cui si può girare. L'arte
moderna inizia con il negare la frontalità per cogliere più
superfici, sperando di rendere visibile “una quarta dimensione” ,
con la sovrapposizione di più immagini di uno stesso oggetto per
proiettarne contemporaneamente l'insieme. Si può cambiare
continuamente il proprio angolo visuale girando intorno alla statua,
l'osservazione non esaurirà mai integralmente tutte le dimensioni
prospettiche, e il risultato non cambia. Ciò che vale per il
disegno tecnico teso alla realizzazione di un progetto, non ha alcuna
valenza, se non per l'aspetto dinamico, il proporre infiniti punti
di vista, intorno al tutto tondo o ad un qualsiasi altro oggetto. Un
numero infinito di prospettive non rende migliore il possesso della
realtà, che non è meglio rappresentata, neppure proiettandola in
un solo tempo l'insieme, come fecero i cubisti, sovrapponendo le
immagini di uno stesso oggetto. Con più efficacia, il Barocco mise
in campo nuove capacità espressive volte a stupire, che non
sarebbero state possibili con la postura classica e senza il rifiuto
delle normali linee rettilinee, sostituite dalla spirale, e con il
costante ricorso alla linea curva, spezzettata, contorta. Qual'è la
differenza? Nella produzione impressionista di Rodin e Rosso si parla
del migliore dei punti di vista, quello che riesce a farti apprezzare
meglio l'opera e l'artista, elevando persino il singolo frammento ad
opera d'arte completa. Già con il Barocco, un' opera la si può
apprezzare gustando anche singole parti, una volta assimilato
l'insieme ( lo stile, la forma, il significato segnico del contesto).
L'effetto è la teatralità del Barocco, fondamentale per
riacquistare i fedeli e punire i trasgressori, per riconquistare
quelle verità divine che non è stato possibile dimostrare nella
realtà dell'uomo contemporaneo. Se questi sono i contenuti, la
struttura , tesa a stupire, va ben al di là di questi.
“
Quello
che apparenta Rodin e Rosso è il senso della continuità dinamica
dello spazio e l'intuizione della luce come mezzo per esprimerla”.
Entrambi negano la frontalità: che non è una novità, come abbiamo
visto fin dal tardo Rinascimento.
Medardo
Rosso impone un rigoroso punto di vista; Rodin vuol essere
espressione in tutte le direzioni dello spazio reale.
Poetiche
in gioco.
La
poetica e la tecnica fondamentale di Michelangelo è che dentro ogni
blocco di marmo esistono infinite forme. Michelangelo parte da questa
teoria: ciò che deve essere rappresentato esiste già nella mente
dell'artista, l'esecuzione consiste nel levare il marmo superfluo: la
scultura è quella che si fa' per forza di levare e non di porre. La
statua in potenza già vive dentro il blocco. Tecnicamente e
poeticamente “il processo creativo Michelangiolesco”, privilegia
l'unicità del punto di vista centrale, cavando per piani, arretrando
fino a quello posteriore, (in linea con il perfetto parallelepipedo).
Si ritorna sull'esempio del San Matteo che tenta di uscire dalla
materia con fatica dove tecnica e poetica concorrono insieme.
Michelangelo è moderno in tutto: dall'uso della copia, per
l'importante esperienza fatta nel “Giardino San Marco” dei Medici
( più simile all'insegnamento delle nostre Accademie e diverso dalle
“botteghe” di allora); all'uso delle tecniche. Il punto di vista
frontale, la concezione dei piani ( la sommità piana della vasca
d'acqua che scende nel suo defluire ), è fondamentale per
comprendere tutte quelle tecniche che, mano a mano, porteranno
nell'Ottocento e oltre all'esplosione di sistemi e tecnologie
innovative. Questo processo segnerà sempre di più la tradizione
scultoria, moltiplicando l'uso delle copie, caratterizzando
l'insegnamento nelle scuole moderne, per imparare le regole e la
tradizione. Anche se l'utilizzo del modello, per una migliore
riuscita del lavoro, Michelangelo lo considerava più un aiuto dovuto
ai suoi allievi. Egli preferiva scolpire d'acchito disegnando
direttamente sul blocco, rincorrendo quell'idea, che già preesiste
nel marmo, che vive eternamente e che l'artista ha il compito di
liberare dalla materia, lottando con essa. Qui, il confronto è
radicale, “si fa' angoscioso problema dell'esistere, e sfida
quotidiana nella ricerca di una soluzione religiosa, di salvezza, in
un conflitto irrisolvibile e senza speranza con se stesso e con le
grandi aporie dell'arte ( difficoltà o incertezza derivante da un
eguale validità di due tesi contrarie: non l'imitazione in se stessa
della natura o dell'antico – ma la mimesi come atto di servitù e
di possesso ).” Non è il rapporto sereno del Brunelleschi: la
virtù della ragione che domina le cose.
Nonostante
la critica, è la poesia michelangiolesca che riflette preminente
sull'idea dell'arte, sulla “fatica corporale che genera sudore”,
sulle tante insoddisfazioni e amarezze: “Non ha l'ottimo artista
alcun concetto c'un marmo solo in sé non circoscriva col suo
superchio...”. Non è la copia fedele del modello, ma è
l'ispirazione, quell'idea che solo in corso d'opera si precisa
gradualmente e si perfeziona completandosi e realizzando ciò che è
pur sempre dentro la materia e nei suoi contorni (circoscrizione). E'
quantomeno ingeneroso il giudizio di Leonardo sulla scultura,
qualificandola arte meccanicista che genera sudore, quando la
scultura, rispetto alle altre è arte di grande ingegno e scienza
sublime, tutt'altro che meccanica e rozza.
“
Dopo
la morte di Michelangelo è iniziato un lungo processo di distacco
tra modellatore ( cera, argilla) e colui che lavora la pietra, fino
al punto di considerare la scultura subordinata al modello che è
dell'artista. Una autentica frattura tra invenzione ed esecuzione: un
tempo l'artista riassumeva in sé i termini antagonisti di Statuario
(l'artista) e scultore (chi scolpisce con lo scalpello: l'artigiano).
Oggi
lo scultore è solo il copiatore: un esecutore sempre in ombra e il
mestiere ininfluente; così pure l'utilizzo delle tecniche e dei
ferri. Ma chi sceglie la materia ed è a contatto con essa? Chi ha
consentito di veicolare l'arte, i tutto il mondo, attraverso le
innumerevoli riproduzioni?
Pensare
la scultura sulla base di un piccolo modello non è la stessa cosa
che pensarla in pietra. Siamo di fronte ad un contrasto evidente. Nel
mezzo stanno tutti i passaggi relativi all'esecuzione, e alla
sintonia necessaria per armonizzare collaborazioni, spesso, tra
personalità ed esperienze tanto diverse. Un tentativo di vicinanza
alla conciliazione, lo si ha quando si ricorre a modelli uguali al
vero, meglio se perfetti e ben strutturati: accuratamente studiati e
frutto di una costante collaborazione. Canova, già dalla tomba di
Clemente XIV, introdusse questa innovazione, portando all'estrema
perfezione il modello: non più come semplice riferimento, ma guida
fedele per la smodellatura. Éi riservandosi l'ultimo strato di
marmo, lasciatogli dalla lavorazione precedente, rifiniva e si
riappropriava delle finalità dell'esecuzione, portando all'ultimo
grado tutto il valore segnico dell'opera e dandogli una definitiva
impronta di sé.
[(E'
corretto non dimenticarsi di un'altra manualità che interviene
immediatamente dopo il puntatore: è uno scultore che, spianando i
punti, conduce la scultura all'ultimo grado di rifinitura, lasciando
una piccola grossezza di marmo, alla magistralità del tocco di
Canova). La manualità dello sbozzatore e smodellatore è importante;
certo la direzione dell'artista deve essere presente e il loro
concerto appropriato ed affidabile. La realizzazione “dell'idea”
non è mai scontata e lineare, per possibili imprevisti insiti nel
marmo o le relative difficoltà di lavorazioni. Torna alla mente un
frase di Martini: “molti artisti mandano incompiuti modelli in
gesso, fidando di trovare, a Carrara, i geni che rimettono a posto le
loro magagne” ].
LA
materia, LE TECNICHE, i ferri.
E'
delittuoso lavorare il marmo e renderlo più brutto di quando era un
semplice sasso, e quando, già al naturale, esprimeva molto di più.
Non
si può disonorare e maltrattare una materia nobile: sottoponendola
a spaccature e pestature, o snaturarla e snervarla, eccedendo nella
pulitura con le smerigliatrici. Le sculture ne soffrono sia per i
difetti indotti, che per l'appiattimento dei loro contorni, quando
vengono alterati, fino a divenire insignificanti. I costi di mercato
costringono a comprimere il fattore tempo, predisponendo che si
avvii, con il fordismo, una produzione industriale e/o commerciale
solo seriale, e tesa a menomare il mestiere con brutte e
insignificanti sculture. Così il ricorso ad una lavorazione
industriale rapida ( quanto squallore nell'arte funeraria! ), per le
tecniche usate, elimina o rinnega il vero linguaggio della scultura.
Un altro dileggio: non si comprendere perché il primo “Bischero”
che capita a Carrara, carico di soldi e di raccomandazioni più che
di “illuminate idee”, lo si debba osannare e super gratificare, e
non si possa, cambiando referente, organizzare e finanziare la
gloriosa tradizione scultorea Carrarese.
Le
tecniche e l'uso dei ferri debbono, non solo essere appropriate ,
personalizzate e ideate sul campo alla bisogna, secondo il lavoro da
farsi; ma anche tener di conto della qualità del materiale rispetto
alla sua durezza e lavorabilità.
Questo
ci ha insegnato il Canova che portava a perfezione la rifinitura,
consapevole che la sua tecnica espressiva era cominciata da una
eccellente qualità del materiale, dalla perfezione della
smodellatura, da tecniche innovative sul finito , compresa la
lustratura. Per avere una idea dell'affezione del Canova verso la
scultura, pensiamo a questo : – intanto la cosiddetta ultima mano
era tutt'altro che un sigillo formale; - spesso, lasciava e
riprendeva il lavoro dopo un lasso di tempo, iniziando una rifinitura
particolare: al lume di candela, per attuare le molteplici
affettuosità delle superfici, studiandone i trapassi delle ombre e
l'effetto delle luci proiettate dall'alto. Infine considerava
l'opportunità delle rugosità e i riflessi da armonizzare con le
tracce dei ferri, diversamente da quelli che lasciare all'opera del
lustratore. Da considerare che tutte queste osservazioni e
precisazioni erano già state anticipate nello studio del modello in
gesso portato al vero .
Non
sembrino meticolosità inutili, la pedante descrizione della luce di
taglio dall'alto, che simile a quella degli scuri laterali (luce
radente) evidenzia rugosità indisponenti. Nessuno si allarmi oltre
il dovuto, perché anche questo effetto indotto ci consente da una
parte l'apprezzamento del marmo e il suo essere trasparente,
brillante e carnicino; dall'altra, per tracciare e lasciare segni
voluti e sentiti, facendo apprezzare anche i più impercettibili
elementi di uno stile: tant'è che la stessa verosimiglianza della
pelle ha integrato l'idealizzazione dell'arte greca. “ Fra i
diversi marmi che si estraggono dalle cave di Carrara il più
prezioso senza dubbio è quello detto volgarmente statuario bianco. A
fronte che assai densa ne sia la materia e grave il peso, ciò
nondimeno la sua omogeneità, candidezza, traslucidezza e pulimento,
armonizzandosi con la diafaneità dell'atmosfera lo rendono atto più
di qualsiasi altra sostanza a rappresentare la leggerezza, e le forme
quasi aeree di quegli esseri mitologici ed eroici, i quali si costumò
essere celesti. Le statue di marmi coloriti e di metallo sono belle
per convenzione ( il diaspro, il basalto, il bronzo), ma pesanti e
compresse verso il suolo..... Apollo, Diana, Ebe, Mercurio nel
sortire sotto lo scalpello dal bianco masso marmoreo non molto
differiscono da quelle stesse divinità, sporgenti dalla nube alla
voce di Omero per manifestarsi ai mortali.” ( Eman.le Repetti).
Ombre, pieghe, semi trasparenze, il rosato della carne viva (qualità
proprie del buon statuario), pongono gli scultori alla pari dei
coloristi e dei pittori . Essi infatti si servono di tutte le risorse
del rilievo: luce (forte) con ombre tenue si alternano,con gli scuri,
quando non si coniugano in una sinfonia. Il colore è come il fare
del bel modellato: veri passaggi, varie texture. E infine il
linguaggio liberatorio del NON FINITO, non solo dalla materia, ma
anche dalla perfezione di un modello: una scelta radicale, “per ciò
che nel compiuto è immutabile in contrasto con l'incompiuto che si
apre ad infinite possibilità di soluzione; a qualità infinite,
impreviste” (Michelangelo).
ANALISI
PARTICOLARI
Figure
Intermedie
Non
è di troppo neppure l'analisi e lo studio delle cosiddette figure
intermedie ( singole attività lavorative parcellizzate ). Ciò che
più ha fatto disgustare, anche per gli eccessi non virtuosi, il
marmo di Carrara è l'abilità, o meglio l'insufficiente abilità, a
ripetere, di mestieranti/specialisti, un lavoro industriale che ha
suddiviso varie parti della scultura: mani, piedi, volti ( estremità
curate dallo scultore); le vesti (pannista), fiori, capelli,
ornamenti vari ( ornatista ). Allo scalpellino gli elementi
architettonici ( capitelli, basi, ecc). Questi sono alcuni indicativi
elementi di parcellizzazione che hanno disaffezionato nell'apprezzare
le qualità vere del marmo, che piuttosto richiede più armonia nella
lavorazione e originalità nelle espressioni: come ad esempio nella
postura della figura, nel taglio e caduta delle pieghe, nelle
tecniche dell'impasto come nella rifinitura. Insomma, è mancata la
cultura della tradizione, quella preziosissima dei maestri delle
botteghe carraresi, insieme al deperire di ogni apporto scolastico.
Cosicché i manichini nelle loro rotondità asettiche e legnose sono
meglio formati e vestiti. È mancato il modo della rappresentazione,
tipica degli usi estetici del linguaggio: quella modellizzazione
strutturale “ di un segno (significante) che mostri in se stesso il
senso: cioè che costituisce una immagine concreta del senso”,
nella sua organizzazione formale. E si preoccupa non di indicare
realtà conosciute, ma di costruire in modo diverso i contenuti
presenti nella quotidianità; quelli inediti!
Il
Marmo.
La
qualità del marmo non può prescindere: dalla lucentezza, pastosità,
gradevolezza, sensibilità e trasparenza. Un marmo che sia anche
consenziente: cioè suscettibile di ottimo pulimento e di plasticità
notevoli e surreali. Tutto ciò è in fieri: un marmo la cui pasta
finissima e tenace si presta ai lavori di scultura e di ornato, per i
lavori più finissimi e delicati; che sia resistente agli stacchi e
può tirarsi a capello, se vogliamo ricorre ad una espressione
gergale.
Occorre
aver respirato l'aria delle nostre cave, assaporato le sue abitudini
lavorative, i suoi richiami, visto i camminamenti sui ravaneti, per
immedesimarsi in quella tradizione che pregna di sé ogni atto e modi
di dire, per intuire quanto questa identità possa aver influito, in
passato, sulla produzione artistica e scultoria. Insomma il marmo è
tante cose della nostra tradizione: nei termini dialettali come
nell'esprimere con una certa durezza atteggiamenti. Sembra la nostra
indole somigliante a quel marmo che tanti momenti avversi della
nostra vita ha rappresentato: in sintonia con le sue sorti
altalenanti, i suoi difetti e imprevisti. Sentirlo dentro di se', il
marmo, lo si trova più docile e consenziente, soprattutto nello
scolpire: una disposizione d'animo sensibile è importante e si
colloca in armonia con un materiale prezioso e buono. Avversarlo lo
rende ostile e caparbio: resistentissimo alla ottusità dei colpi mal
diretti, non coordinati. Dal cattivo suono materico , con il ferro
che via via si fa' più bolso, si evince la contrarietà del
materiale all'insensibilità più che all'imperizia. L'artista, dal
tocco malevole, che maltratta l'armonia degli strumenti, con
eccessiva pesantezza di mano, non coglie alcun risultato propostosi,
bensì il suo contrario. Non sente “il rude” che ben non
iscaglia, con i colpi dati alla cieca pesantemente. Non sente che il
suono non è ritmato e non segue trame ordinatamente dirette? Alla
gradevolezza del suono ritmato corrisponde un marmo arrendevole e un
tessuto omogeneo tracciato dal ferro. La forza va' calibrata, mentre
i colpi possono essere virtuosi. Con il martello pneumatico occorre
una mano miracolosa che sa' prendere il verso e deve esercitare una
giusta pressione, tale da consentire al ferro di mangiare il marmo
statuario gradualmente, o di penetrare segnando dolcemente quei
passaggi di ugnetto, gradine, scalpello tagliente, e consentire al
marmo di prendere lodevoli forme e tramare. Insulso anche l'uso,
mortificante, di portare la superficie della scultura tirata a
lucido, ad ogni costo, fino a far scomparire ogni traccia della
lavorazione , che è la conseguenza del modo in cui ci si avvicina
all'impasto della forma e alla texture desiderata.
Va
recuperato tutto il mestiere, altrimenti rischia di isterilirsi: il
praticantato nelle botteghe e nelle scuole è importante, perché vi
è una osservazione diretta su tutte le fasi delle lavorazioni;
occorre rispettare tutti i passaggi del modellare, le scorciatoie
sono dannose, come impuntare eccessivamente il ferro, tagliare e
trapanare in profondità. Il lavoro deve poter emergere gradualmente
dalla materia, quasi liberandosene, sfruttando la scala dei piani e,
mano a mano che si rendono più visibili le parti più sporgenti,
parimenti, dar corpo da un lato e dall'altro, all'immagine già
realizzata, completandola. La scalpellata deve essere lunga ed a
correre, altrimenti le pestature e le scalette comprometteranno
alcune parti dell'opera. E' impensabile spianarle con le macchine
abrasive per porre rimedio ad un marmo irrimediabilmente squamato. Se
senti che il ferro non morde adeguatamente, devi essere meno teso e
meno rigido nel colpire, cercando una percussione tranquilla e meno
nervosa, rilassata. Istintivamente, quando incontriamo una qualsiasi
resistenza, si è portati a colpire con più veemenza, a forzare la
mano; al contrario con la materia nobile occorre recuperare
affettuosità e sintonia, lasciando alla intelligenza della mano di
condurre il ferro ad un intaglio sentito, di ridurre la pressione -
rallentare, se non fermarsi, per riprendere più dolcemente -
affinché si morda lo spessore del marmo con quella gradualità
possibile e consentita, portando percussioni a comporre una trama
strutturata e unitaria. È questa la grande sensibilità richiesta,
non facile stato d'animo ma consapevolezza della materia lavorata.
Togliere spessore in maniera omogenea, significa impugnare
adeguatamente i ferri, secondo l'angolatura richiesta, ora ferma, ora
rilassata, per meglio mangiare, nella piacevolezza, l'impasto del
marmo, assecondando il movimento della mano al ritmar dei colpi e
calibrandone l'impatto. Niente impuntature ne scintille a correre.
L'impugnatura del mazzuolo, così come il suo peso, la potenza e
velocità dei colpi, non dovrà essere a casaccio, ma calibrata alla
levità e profondità della traccia. Insomma, con garbo finché non
senti la materia con te fisicamente, dandosi a quello scagliare
voluto e consenziente. Lavoriamo pochissimo con la subbia per
sgrossare, pensandola solo come momento di forte impatto, ma che
invece ci dovrebbe aiutare ad essere vicinissima ed utilissima per
ottenere quel modellato e quel geometrismo grezzo delle figure che,
avvicina la somiglianza; e di subbie ne abbiamo di ogni misura, fino
alle piccole utili per penetrare nei sottosquadra. Anche l'uso
delle raspe e degli smerigli non può essere né anticipato né
abusato eccessivamente nella rifinitura: ne l'un caso si pasticcia
solamente; nell'altro si toglie incisività al segno ed i contorni
perdono forza, mentre i chiaro scuri scemano nell'inespressività,
afflosciandosi. Volendo attutire le asperità della pelle del marmo,
negli incavi, è consigliabile strofinarlo con sabbia di mare, che
non è purgarlo, perché, il termine, nel linguaggio carrarese ha il
significato più di una operazione fatta anticipatamente e in
profondità.
AFFETTIVITA'
DELLA MATERIA
La
luce bagna con dolcezza i volumi; dà risalto ai rilievi che si
staccano rispetto allo sfondo o piano di base. La luce radente che
spesso ignoriamo - oltre ad evidenziare difetti ed inopportune
asperità, spesso nell'intaglio ostenta bruttissimi ematomi (squame)
– consente di intervenire, adeguatamente, nei vari passaggi: dalla
gradina allo scalpello, fino al raschietto. Anche la raspa può
aggiungere dolcezza e morbidezza, donando carnosità al marmo. È
l'abuso della raspatura o il suo uso improprio che rende le figure
inespressive (afflosciate), togliendo incisività al segno. Al
contrario, una rifinitura, una pulitura, con l'uso adeguato dei ferri
soggetti ad una percussione misurata e sentita, oppure a schiacciare
il ferro, con la sola pressione della mano, alla stessa maniera degli
scultori in legno, mimando lo stesso movimento usato nella
raschiatura e raspatura, che intagliano il modellato mentre corrono
lungo il verso, donandogli il senso ispirato. Sono gli ultimi
tratteggi che decidono il senso plastico, la linearità, gli scuri,
che possono render palpitante o scabrosa la materia.
Se
non è semplice l'uso del raschietto, più accorto dovrà essere
l'uso della raspa: segnare trame di graffi sovrapposti, limando i
tratteggi nel verso della trama e accompagnando il taglio del ferro
fin nelle scabrosità più inaccessibili e difficoltose a spianare;
ciò per esaltare quell'armonia che coordina le diverse parti, così
come lo sono i suoni ed il ritmo nella musica, a seconda delle
tonalità, rispetto al livello cromatico e della sua intensità (
chiara, scura, più marcata nei trapassi di ombre). Nella
composizione il complesso dei legami armonici può, nelle rifiniture,
legarsi al di là di esse, a diversi ordini di levigatura e
lucidatura a specchio. A seconda dell'esaltazione di luci ed ombre,
esiste un'amplissima gamma di interventi: dallo strofinare la sabbia
di mare, con stracci e utensili adattati, fino sfregamento di
diversi abrasivi.
Certo
il magico tocco del ferro è altra cosa, in omaggio agli amanti della
scultura, penso ai passaggi del trapano (violino), e alla magia di
ricavarne quei chiari e scuri, quelle movenze nei capelli, in tutti
i tagli, deliziose nei boccoli; non è minore l'esaltazione degli
strafori nel floreale e in tantissimi altri ornamenti.
Non
dimentichiamo la grande quantità e disponibilità degli strumenti,
divisi in due grandi gruppi: a percussione o ripercussivi ed
abrasivi. Se escludiamo vari tipi di martelli dalla mazza alla serie
di martelline e bocciarde, abbiamo la disponibilità di una grande
varietà di ferri, dalla subbia, gradina, che solcano la superficie,
fino agli scalpelli dal bordo piatto ed affilato, di grande
pulimento, capaci di lisciare le superfici. Il solcare ed il pulire
dipendono dall'angolo, più o meno obliquo, del ferro che la mano
tiene con movenze ritmiche sulla pietra; sia dalla forza e battuta
effettuata dal mazzuolo, che può essere di vari tipi, ferro, legno,
acciaio; sia dalla capacità di entrare in sintonia con il marmo e
scagliare con la consentita gradualità, dovuta all'innato mestiere
che guida la mano. Anche l'impugnatura del mazzuolo ha la sua
originalità, grandezza e foggia, secondo i diversi tipi di
lavorazione: la battuta può essere più o meno forte, impugnando il
manico del mazzuolo all'estremità, vicino alla sua metà ed oltre,
ma anche afferrando lo stesso massello di ferro; oppure con una presa
appena sotto a questi che lambisce anche il legno. Così lo
scalpellare ha la penetrazione voluta, fino al lisciare; “secondo
la gentilezza, con dolcezza della mano, che arrotonda le pieghe ed i
muscoli, tratteggiando la figura con grazia mirabile”. [
Se la lingua fatta di parole è il più potente mezzo di
comunicazione, e
nel linguaggio verbale, con il meccanismo dei suoni e delle parole,
si possono formulare milioni di frasi, altrettanto lo può il segno
incisore dei ferri, sia vecchio ( traccia, vestigia ); sia attuale,
adatto a comunicare, nell'immediato, un pensiero, uno stato d'animo,
il ricordo del passato o il presente di un nostro modo essere; e
l'anticipazione del futuro. In sintesi, il segno dei ferri e gli
elementi strutturali del modellato non sono altro che una funzione
degli infiniti mezzi espressivi a disposizione dell'artista].
IL
Canova è stato un esempio di armonia, di purezza e fedeltà al
linguaggio della scultura, curando quella affettuosità delle
superfici, l'insieme degli affascinanti riflessi e le varie
profondità di ogni scuro. A contrasto, l'odierna uniformità della
cultura commerciale, produce un'offesa alla nobile materia, con
inanimate figure e per l'appiattimento dovuto allo spianare
eccessivamente i lavori, che restano brutti ed anonimi perché privi
di incisività segnica. Perciò anche la pulitura e lucidatura devono
poter rientrare nell'armonia della composizione, comprendendo un uso
adeguato degli agenti chimici e dei prodotti naturali.
-
Lucidatura -
Alcuni
in uso alla lucidatura: pomice umettata – pomice naturale e zolfo
in polvere-; - anche acido ossialico – tintura in acqua di tabacco
– bucce di cipolla e zucchero – infuso di caffè – alcool ed
erbe grasse....
-
Fordismo -
Qualche
altro dubbio lo porta il processo di parcellizzazione del lavoro che
vede impegnate diverse figure professionali, soprattutto se sono poco
coordinate e di incerto mestiere. Il Repetti paragona l'esecuzione
di una qualche statua al lavoro degli orologiai di Ginevra, nelle cui
fabbriche usasi spartire i dettagli tra diversi operai, dove riescono
in questi esperti ed esatti, cosicché ciascuno si applica ad un
diverso meccanismo, con gran risparmio di tempo, di fatica, e di
spesa, e alla fine conclude: “ ma l'artista solo è quello che le
da' l'esistenza”.
Del
processo di parcellizzazione viene criticata, soprattutto, la
trasposizione meccanica dei punti, perché genera uno scadimento dal
sapor di copia. Molte volte anche le vicende storiche giocano a
contraddirsi: nella seconda metà dell'ottocento, dal Bonanni a
Carrara, inizia la meccanizzazione ( torni e pialle), mentre nella
stessa città, dal Nicoli, inizia il ritorno al taglio diretto e la
ricomposizione del processo del lavoro e la riappropriazione, nelle
mani di una sola persona, delle tecniche e dei trucchi del mestiere;
ritorno come frutto di una intensa collaborazione tra gli artisti che
frequentano lo studio, e la maestria degli scultori presenti.
Sennonché nulla è esaustivo, poiché la bramosia di danaro è
portatrice di molti scadimenti, non tutti giustificati, sia negli
eccessi della divisione del lavoro, sia riscontrabili
nell'imbellettare ogni parvenza delle figure, per poter guadagnare
concorrenza e profitto, che è del tutto improprio rispetto al valore
aggiunto.
Una
certezza esiste, è che né la sbozzatura né la smodellatura
possono compromettere, in maniera definitiva la scultura, salvo
errori grossolani. È l'ora dell'artista modellatore che, nell'ultima
fase della lavorazione, si dispone a recuperare tutta la forza della
materia e dare un senso originale all'opera. Esso interviene, con
gli eventuali collaboratori, per portare a compimento l'idea
originale, quando vi è ancora quel margine e quello spessore
(strato) di roba che può ancora tradurre, fedelmente, l'ispirazione.
Tutto è recuperabile, se si evita l'automatismo e il troppo presto;
nei fatti, se la separazione tra arte e mestiere ha lasciato
l'esecuzione a diverse figure professionali nella lavorazione della
pietra, non delude l'esclusivo l'affidamento alla specialissima
bravura dei nostri numerosi artigiani. Bensì è ora di chiudere con
la piattezza della lavorazione commerciale e ritornare al ciclo
virtuoso scuola, bottega, apprendistato, qualifica di merito. Tant'è
che i migliori tra gli anonimi banauso, esecutori in marmo, quale
prodotto della grazia di una civiltà artigiana, sono portati allo
studio e alla contemplazione degli stilemi e della personalità del
modellatore: sono figure uniche di lavoranti, sempre più rare,
adatte a comprendere il senso connotativo essenziale, a produrre una
mimesi che entra nello spirito dell'opera, tramite una lavorazione,
anch'essa consonante. Questa riflessione può stupire, ma non quando
ci troviamo di fronte ad un lavoro di rifinitura, giunta oramai alla
restante fitta punteggiatura delle gambe, come quello che ha fatto
L. Bistolfi, durante l'esecuzione de l' Armonia e riprodotta in una
foto dell'epoca. Dobbiamo solo aggiungere che la statua è,
nell'immagine, la copia perfetta del modello; un modello studiato e
rifinito perfettamente fin nei minimi particolari, che sarà ben
realizzato e la superficie portata al massimo grado di finimento.
Un'ultima considerazione su Bistolfi: quella restante fitta
punteggiatura è già di per sé un gradevole capolavoro segnico, e
già si intuiscono i susseguenti “ passaggi di come ci si avvicina
alla forma, con quali attrezzi e con quali effetti, senza far
scomparire qualunque traccia della lavorazione”. E la dice lunga,
nella predisposta tornitura delle gambe, non solo sull'abilità
tecnica di un grande artista/esecutore, ma di più sul rapporto di
osmosi che ha con la materia e del suo sentito impasto. [
Osservazione già fatta, e sulla quale ritorneremo ].
È
pertanto, esclusa ogni interpretazione meccanica del virtuosismo
dello scultore Torinese, con gli utensili ben in mostra nella foto
(Ottocento a Carrara). È la conferma e la dimostrazione di come i
ferri possono essere usati nel migliore dei modi, e, per farlo,
occorre uscire dal loro uso malverso e stentato, se è tal quale a
tarli biascicanti. Lo scadimento si attua quando si prendono
esecrabili scorciatoie. La ragione del malinteso è evidente: di
solito, le figure sono levigate o lucidate ( alcune anche a
specchio). È inevitabile che si arrivi a spianare ogni traccia dei
ferri, se il fine è quello di ottenere un risultato definitivo di
artificioso massimo pulimento, purché comporti un ampio risparmio di
tempo e di danaro. Quindi, massima licenza al libero impiego di
bocciarde, levigatrici e smerigliatrici e molto spazio alla
moltitudine di mole abrasive, frese e fresette di ogni tipo e misura.
Via avanti di questo passo, tecnica e scienze moderne permettendo.
Nessuno può negare il progresso tecnologico, o l'insieme delle
conoscenze razionalmente organizzate, purché si abbia ben chiaro
ciò che si vuol realizzare, soprattutto con una materia nobile, e
come rappresentarlo, in maniera chiara, condivisa e percepibile
all'umanità presente. Ciò comprensivo della sua funzione o utilità
nel tempo, se diamo ancora un valore all'importanza del lavoro e alla
laboriosità dell'uomo, di oggi, di ieri, di sempre. Un'idea, una
invenzione, non può essere lasciata alla libera interpretazione,
considerata polivalente e onnicomprensiva. L'artista non è né
onnipotente né onnisciente; e, forse, non è ancora risalito
“all'idea unica?”.
L'idealizzazione
è quell'ispirazione che spinge l'individuo a dar vita ad un'opera;
in molte culture la si trova vicina al respiro di Dio e causata dal
genio. Lo lascia intendere l'idealizzazione greca: “l'uomo è
misura di tutte le cose, e seppur transitorio, la sua idea è eterna,
immutabile, perfetta; mentre la realtà è apparenza transitoria e
solo una copia dell'idea”. Qual'è la percezione che ne abbiamo
nell'attualità? La percezione delle cose non è mai un atto
univoco, meno che mai oggi, data la complessità dei tempi e dei
messaggi, polivalenti e mutevoli. Mentre le tecniche di comunicazione
possono diventare angosciose e chiuse, anche di fronte ad ogni
esperienza piacevole rappresentata dalla poesia del bello, e
coltivare un sentimento di avversione verso tutto e tutti. Le
comunità non sono stimolate a nutrire una crescita vera, collettiva,
ma solo promozioni individuali; comunque feticci autoreferenziali:
dove tutto è giustificato e giustificabile; dall'uso di materie
spregevoli ai marchingegni provocatori da sballo. Tale malverso è
il risultato della cultura del politicamente corretto e degli amici
solidali tra loro, mima solo gli effetti più deleteri del
“fordismo” strettamente industriale e commerciale, che altro non
è che l'impoverimento della materia, sottratta al suo naturale
impiego usando mezzi meccanici eccessivi: nell'affettare, spianare,
lucidare, togliendo, infine, quell'affettuosità del bianco marmo e
quel valore aggiunto che è un'altra cosa; proprio per i doni che
porta in grembo: il verbo dei rilievi, la creatività della luce, la
timidezza od il rancore delle ombre, laddove la materia è carne viva
e panno frusciante. Qui, non è rilevante il passaggio dalla civiltà
fondata sulla scrittura a quella dell'immagine, al contrario è la
continuità del segno e dei linguaggi, archetipi condivisi. Certo
quando si scolpisce una figura non tutto è programmabile al cento
per cento, vi possono essere margini di errori per difetti nella
materia o inconvenienti. L'uomo non è un automa, la lavorazione non
è paragonabile alla filiera degli orologiai di Ginevra, dove ognuno
si applica diversamente ad uno stesso meccanismo. Diversamente, si è
detto che ogni artigiano o lavorante acquisisce un proprio modo di
plasmare la materia, i segni si possono comporre o ricomporre, come
si fa con la lingua parlata, articolando le tracce dei ferri. Non è
la stessa cosa nel combinare tra loro le parole per formare le frasi,
o intrecciare, nell'intaglio, tracce di trame; ma il senso anche qui
è compiuto, l'espressione strutturata, ben oltre il legame ai
modelli e alle cose. Non è necessaria una dettagliata teoria
dell'arte, per certificare che il segno è l'espressione più
immediata per comunicare un pensiero o uno stato d'animo; può
essere un messaggio semplice o complesso, suono, parola, incisioni
multiple sulla pietra, disegno. La sua naturalità visiva, immediata,
può raccontare di grandezze e di povertà, essere lontano o vicino
all'osservatore, nel tempo reale come nella profondità prospettica;
essere una voce narrante esterna ma dentro le vicissitudini, o
percepire lo spazio, anzi viverlo negli illimitati modi
occupazionali dei suoi pieni e vuoti. Ed altro ancora, accogliendo
le variabili dello svolgersi dei fenomeni fisici. Il rapporto è con
la sostanza culturale di ogni essere umano, alle esperienze che ogni
gruppo vive nel territorio, alle cose che vede intorno a sé, a come
le vede e le descrive e le esprime usando codici comuni.
La
tradizione, il tramandare i sensi di una evoluzione, attuata
attraverso vari processi di trasformazione, sono sempre più uguali,
nella mimesi, alle diverse immagini della natura, al suo essere
modello formale nella realtà data, con processi simili alla
struttura delle griglie di trasformazione civile e sociale,
anch'esse presenti in forme modulari organizzate,
regolari/irregolari. Tutto questo non può essere banalmente
superato. Noi non siamo altro, siamo quel che siamo. Penso a Carrara
permeata dall'esperienza delle cave, sfidate da intere generazioni,
dove, dentro l'anfiteatro maestoso delle Alpi, hanno inscenato uno
spettacolo unico al mondo: piccoli uomini, con la tenacia del loro
vissuto, hanno affrontato le immani masse marmoree implementando le
particolarità di essere del territorio e la sua organizzazione
sociale. Ognuno si è abituato a vedere e subire una tradizione
preponderante, contaminata da un originale modo di essere del
paesaggio ed il suo sbocco alla marina. Tradizioni, dialetti,
l'esperienza di tutti i gruppi umani e la loro particolare cultura –
intaccata da lavori pesanti e debilitanti – hanno reso un popolo
unico ed orgoglioso nel rispetto delle proprie radici. Oggi dové
tutto questo? Cosa è rimasto di un patrimonio dedito alla
laboriosità e al sentirsi parte identitaria di una particolare
comunità? poco o nulla! Al centro pur sempre il lavoro, simbolo e
dignità dell'evoluzione.
Ma
ritornando al tema della scultura, possiamo affermare che la sua resa
ed abilità può essere maggiore o minore nei vari momenti delle
prestazioni: è ovvio che il lavoro meccanico, del riporto delle
misure a punto, possa ingenerare uno scadimento, dovuto a movimenti
ripetitivi sempre uguali, per questa via il mestiere rischia di
isterilirsi, sennonché scolpire è un mestiere. È prassi, per molti
modellatori cambiare la lavorazione in corso prestandosi, o
portandosi, al servizio di un'altra opera, sia per non soffrire della
“cotta”, restando troppo stanziali; sia per sveltire il lavoro.
Se, confidare nel mestiere e nell'importanza della tradizione ci
consente di motivare meglio una riflessione, nel contempo potenziare
l'apporto scolastico e la ripresa e sviluppo degli Istituti
Professionali è una realtà ineludibile, che va incentivata, poiché
trascina con sé esperienza e avita professionalità. Nei fatti, si
pone il problema, oggi rilevante, di un'unica direzione che coordini
la scomposizione del lavoro in molteplici e indefinite figure
professionali; perciò l'apporto scolastico è fondamentale, se
vogliamo gestire e soddisfare quelle eccellenze artistiche, che ci
consentono di superare la trita commercialità.
Ritorniamo
alla criticità del mestiere, al suo essere meccanico, per
riconsiderare anche le minori e diverse prestazioni dell'uomo nel
tempo, che possono incidere, eventualmente, nella sua resa, la quale
può essere maggiore o minore a seconda degli stati d'animo e degli
eventi. Ma questi alti e bassi nulla possono di fronte alla
genialità delle mani ed alla padronanza del mestiere, alla fantasia
e inventiva, allorquando la professionalità è altissima. Non è
esclusa l'improvvisazione; e neppure la sostituzione dell'idea
originale con un'altra, in corso d'opera: Arturo Dazzi disegnando sul
marmo stesso la figura, si lasciava ispirare dai movimenti del
volume, dai rilievi, dai giochi stessi delle asperità e sinuosità
offertegli dal blocco. Detto questo, almeno ad un livello dignitoso
della professionalità, sconfessiamo chi considera lo scolpire arte
meccanica, che genera solo fatica e sudore.
L'Anima.
Nulla
può essere lasciato al caso: la scultura deve poter aver un'anima
che è la spiritualità dello scultore, il senso e l'espressività
della sua personalità: non altro. Lo scolpire è questione
personale, anzi personalissima, un cimentarsi a tu per tu con la
materia, un patto a compenetrarsi. Perciò nulla è lasciato al caso:
non lo è la plasticità, in omaggio alla quale alcune parti si
debbono considerare in rilievo rispetto ad altre più scavate; perciò
va' stimato quale armonia riservare a ciò che deve essere lasciato
in piena luce, dandogli più o meno forza e ombra; e quali altri
risalti dare agli effetti di superficie, con una linea più morbida e
delicata, oppure rimarcarne le tracce e tormentando le stesse linee
con profondi scuri, spezzandole. Questi ed altri effetti, dalla
ruvidezza alle tracce ordinate di ogni scalpello, fino alla pulitura,
sono contrasti e parti di un linguaggio ricercato e semplice nello
stesso tempo, e, nell'insieme, esteticamente piacevole. Particolari
rifiniture delle forme, effetti di chiaro scuro e particolari
ombreggiature, si ottengono con una impugnatura del ferro morbida e
con un angolo perpendicolare (vicino 90° ); oppure, impugnatura
rigida con lo scalpello sfuggente, più a lisciare. Tra gli utensili,
l'ugnetto per particolari sottosquadra e intagli fini, virtuosamente
anche in parti delicatissime ed in superficie, molto più spesso in
profondità, a scavare.
Ritornando
alla diatriba iniziale tra l'ideatore (artista) e l'esecutore
(scultore), entrambi sono obbligati ad incontrarsi a un preciso
crocevia: il requisito fondamentale di un opera è che deve
corrispondere all'idea per la quale è stata concepita, o a
qualsivoglia soggetto, somiglianza o rappresentanza per la qual cosa
essa è stata pensata e originata. Due secoli fa' quando l'arte a
Carrara seduceva con l'armonia della creazione e della bellezza
naturale, l'imitazione attingeva ad una fonte di perfezione e
l'ispirazione riusciva a far vibrare i nostri sensi. Mentre la
commozione ed il piacere non era semplice svenevolezza e supino
consenso.
Ai
nostri maestri “ non era bastevole copiare ed essere considerati
copisti di un'arte meccanica: essi dovevano impadronirsi dell'arte
del comporre con maestria, come i più grandi poeti e musicisti,
altrimenti nulla si saprebbe dell'estro proprio, della poesia e
dell'armonia, così come in molteplici altre espressioni seducenti”
. Artisti ed artigiani dovranno rientrare in possesso di questa
grande passione. “ E con i nostri più bravi maestri istruirsi nel
solco di una grande stagione, far leva sul genio dei Carraresi, per
uscire dalla banalità delle imitazioni attuali e scoprirsi originali
inventori”.
Fondamentale:
la casualità non potrà mai essere una facile scappatoia, affinché
il tutto si possa giustificare banalmente, sia con l'incidente
occasionale, sia omaggiando lo strafalcione miracoloso. Gli è che il
segno, in libera uscita, può essere qualsiasi cosa o qualsiasi
processo di identificazione; sfacciatamente null'altro che marketing
per vendere al meglio nel variegato mondo del “politicamente
corretto” e corrotto. L'artista gode di un ottima pubblicità e
consenso? Bene. Ne ha tutto il diritto se ha anche un buon conto in
banca oltre che amicizie potenti. E l'arte, beh! l'arte è un altra
cosa.
Resta
una sola considerazione: i sentimenti genuini restano tali nella loro
immediata e libera espressione, cagione nostra dello scambievole
godimento e assorbimento, che non è mutabile in una qualsiasi
valuta.
UN
PUNTO DI VISTA DIVERSO
Quante
sculture sono concepite con un unico punto di vista, frontale o
laterale? Il buon senso ci induce a pensare che ciò dipenda dalla
loro funzione o significato; dallo spazio che si è voluto occupare
o corredare. Perciò è ingiusto negare la validità di un solo punto
di vista, che lascia le altre parti in ombra; altresì la
possibilità di esprimere il dinamismo come un prolungamento di
continuità nello spazio, attraverso una sequenza stilistica. Si
pensi anche alla funzione ancillare rispetto alla architettura e al
suo uso modulare, ritmico, o di supporto (cariatidi). Il problema di
uno scultore è quello del rapporto con l'ambiente, di organizzare
una collocazione e farla vivere ed essere protagonista in quel
determinato spazio. Spesso gran parte della figura sono nascoste alla
vista: la parte posteriore, se collocate in una nicchia, non è
neppur rifinita; la stessa cosa avviene per la loro collocazione
nelle facciate delle chiese e dei palazzi, ma anche negli stessi
ambienti interni. Perciò lo studio del posizionamento dell'opera non
può che seguire un preciso significato, anche coreografico, se
desideriamo progettare altri punti di vista. Non dimentichiamoci
della luce, sempre determinante nella scultura, il cui protagonismo e
la gamma di gradazioni meritano uno studio attento e non
superficiale, essendo il principale artefice con il precipuo compito
di modellare, definitivamente, la struttura delle superfici,
scivolando o incuneandosi dentro esse. Va da sé che ogni scelta
soggettiva è la più efficace, ma non quando si vuole stupire in
ogni modo e in mille modi insignificanti, spacciandoli per le nuove
frontiere espressive. La questione, sempre, attiene alla
progettazione, stile e funzioni attribuite all'opera. E forse anche
la committenza avrà, con diritto, dato indicazioni.
Nel
merito, osserviamo la bellezza classica del Davide di Michelangelo,
anche qui la critica si sofferma sull'eroico simbolo esclusivamente
attraverso una visione frontale: “la figura gigantesca è tesa,
concentrata, compressa come un elastico che accumula tensione per poi
liberarla in un solo gesto, nella statua ancora implicito”. Segue
la descrizione su di un movimento imminente, in potenza, che sta per
esplodere; ma tutta la descrizione si sofferma sulle parti anatomiche
anteriori (frontali).
Il
senso poetico è compiuto, anche se in ombra il posteriore, ben
fatto, completa il capolavoro senza la benché minima stonatura.
Infatti, il Davide è il simbolo della repubblica fiorentina. Ciò
conferma le osservazioni sulle funzioni soggettive della figura e sui
diversi modi di organizzare lo spazio e, conseguentemente, sulla
scelta del punto di vista: quando si trattò di trovargli una
collocazione, Leonardo propose la nicchia all'interno della Loggia
della Signoria; mentre Michelangelo e la commissione proposero il
piano di appoggio del grande muro del palazzo nella stessa piazza.
La
questione della scelta del punto di vista attiene più ai
proponimenti progettuali e ideali e non può essere affatto
occasionale; certamente può corrispondere, semplicemente, a una
scelta estetica o modulare, eppure anche in questo caso esprime un
senso compiuto.
Non
è possibile dimenticate il tema del “non finito” di
Michelangelo: la tecnica eccelsa che diventa essa stessa linguaggio e
poesia, nei modi del plasmare, nei passaggi gustosissime tracciati
dai differenti ferri. Così è, almeno per chi ama la scultura,
quella vera. Sul problema del non finito, di Michelangelo, occorre
operare una distinzione, nel contesto delle opere non portate a
termine: tra quelle incompiute per cause accidentali da quelle
effettivamente non finite, ma poeticamente concluse in maniera
definitiva per volontà dell'artista. Per alcuni critici, “
l'improvviso arresto del lavoro è stato causato dalla soddisfazione
di aver raggiunto il termine della propria visione, che in questa
tecnica vedeva il completamento supremo della propria opera”. Ma
quanto è bello il contrasto plastico tra le parti abbozzate e quelle
finite!, se improntate da mani virtuose; e quanto movimento esprime
una forma che levitando tenta di liberarsi dal blocco. C'è chi,
invece, apprezza “ la maggiore espressione di pathos che balza da
una sintesi estremamente rapida e ardita”. “Da parte sua l'ARU
dava nuova validità alla tesi celliniana dell'unicità di visione
per cui, Michelangelo si sarebbe, nella sua pratica di scolpire “per
forza di levare”, fermato allorché, nel processo in cui la
scultura prende forma a poco a poco, la sua eccellenza plastica
sarebbe stata attenuata dalla creazione di altri punti di vista”.
In
definitiva, nella pratica di scolpire, Michelangelo avrebbe
privilegiato l'unicità del punto di vista frontale ( secondario il
posteriore e tutti gli altri ).
Ma,
questa visione è, grossomodo, in sintonia con la tecnica
dell'arretramento del piano anteriore ( di partenza o inizio lavoro
), verso altri piani, rendendo mano a mano visibili le parti più
sporgenti, che saranno rifinite, in contrasto con la materia che
tiene prigioniera l'immagine. Perciò, gradualmente, gustiamo
sequenze e parti opposte, in tempi diversi, così come si esprime un
qualsiasi linguaggio, che si fa' sentimento e/o pensiero, e poi
parola, gesto, umana socialità: poiché è sempre di noi che si
parla.
Michelangelo,
alla pari o ancor più dei grandi artisti carraresi, conosceva il
verso del marmo che è il segreto con cui i cavatori, a colpi di
mazza decisi e sicuri, sbozzavano l'opera. Entrambi possedevano la
magica capacità di liberare dal blocco meravigliose sculture. Un
illustre visitatore così dipinse il carattere dei carraresi: “ la
loro indole è assai somigliante al bel marmo in mezzo al quale sono
nati; la materia ne è preziosa e buona, renitente bensì ai colpi
mal diretti, ma altrettanto suscettibile di prestarsi alle più
lodevoli forme sotto la mano, che ne sa' prendere il verso” ( E.
Repetti).
I
CARATTERI CHIMICI DEL MARMO
“
I
caratteri chimici dei marmi risultano composti dalla loro
composizione mineralogica.....I calcari, detti puri, sono costituiti
da carbonato di calcio a cui si associa sempre una quantità più o
meno grande di carbonato di magnesio......Questi marmi sono tanto più
facilmente attaccabili dagli acidi quanto minor quantità di magnesio
contengono. Si sciolgono nell'acido cloridrico ordinario o diluito a
caldo. Siccome non sono mai puri, lasciano sempre un residuo
insolubile dovuto a varie sostanze: al carbonato di magnesia è
meccanicamente mescolato una quantità variabile di sostanze
argillose (caolino) che rimane insolubile. Una parte importante di
detti marmi appartiene ai calcari marnosi”.
L'esempio
che segue inerente alla lavorazione del marmo non è di quelli
calzanti; ma in senso lato chiaro e pratico. “ Riportiamo qui come
si fanno le mine, alla francese, nella lavorazione ordinaria, quando
si vogliono staccare grandi blocchi. Descriviamo esclusivamente come
si ricava la cavità da riempire con la polvere esplodente. Siamo
interessati, esclusivamente, al solo processo di scioglimento del
marmo, traendo partito dalla proprietà che hanno gli acidi
(Muriatico) di scomporre il carbonato di calcio: nell'esempio delle
mine menzionate, vien fatto un foro con il trapano e successivamente,
dovendo allargarlo, vi si versa, con un tubo di gomma, l'acido , il
quale attaccando il marmo fa' sviluppare l'acido carbonico e forma
poi del cloruro di calcio solubile, che può essere prosciugato e
tolto. Si viene a formare una tasca per la polvere esplodente”. Lo
scultore non ha certo bisogno di far esplodere delle mine, ma di
utilizzare un processo simile per scavare in profondità e rilevare
stacchi delicati senza far danni.
Acido
cloridrico.
Non
sempre il ferro è sufficiente per l'intaglio, fosse anche ricurvo e
ben forgiato, in tal guisa da poter penetrare dentro inaccessibili
sotto squadri o trafori nelle profondità del marmo; e neppure il
trapano o fresette smerigliate, anch'esse sagomate all'uopo, possono
essere determinanti per delicatissimi stacchi. In questi casi si
ricorre all'acido: con le dovute cautele si intinge un pennello,
delle dimensioni adeguate, nell'acido e si passa ripetutamente sulle
parti da eliminare; poi si lascia riposare e ponendo la massima
attenzione sulla quantità di materia da asportare, si smette quando
si è tolta quella grossezza che è ritenuta sufficiente. Indi, con
l'acqua, si annaffia abbondantemente la parte coperta dall'acido, ben
lavandola e badando che l'effetto della formazione del cloruro di
calcio solubile sia concluso e che tutto è stato prosciugato.
EQUILIBRIO
DEL CORPO UMANO
La
Ponderatio.
“
Nell'arte
Egizia, Assira e Greca primitiva tutte le figure posavano i piedi
simmetricamente allineati. La linea di gravità cadeva in mezzo ad
essi. E' merito di Policleto (V secolo A.C.) la posizione naturale di
equilibrio, detta della gamba libera, la quale concludeva le ricerche
delle sculture arcaiche (Koùros). Policleto, oltre al canone (il
trattato sulle giuste proporzioni), eseguì il Doriforo detto appunto
Kànon che è la dimostrazione visiva del suo trattato
nell'illustrare bene i principi della ponderazione ( la precisa
distribuzione del peso nella posizione verticale asimmetrica ). La
figura non è più sostenuta dalle due gambe, ma poggia su una sola,
la destra, detta portante o tesa, sulla quale grava tutto il peso.
Mentre la sinistra detta flessa o libera, leggermente arretrata,
bilancia il corpo, posando in terra, senza compiere sforzo, solo le
dita del piede”.
“
Da
questa posizione naturale di riposo, mantenendo l'equilibrio
prevalentemente sopra un solo piede, la linea di gravità scende
lungo l'arto destro; ne nasce una diversa articolazione delle parti
superiori del corpo: il bacino è inclinato scendendo sulla gamba
flessa, invece il torso, riequilibrando, volge in senso opposto
seguendo la linea delle spalle, che è inclinata. Il braccio destro è
libero, mentre è portante quello sinistro e il collo e la testa
piegheranno verso destra. Sono una serie di relazioni, quelle inverse
della gambe e delle braccia, che danno luogo ad una struttura
armonica (determinata da un incrocio a X detto chiasmo). La gamba
sinistra è a riposo come il braccio destro, mentre la gamba destra è
portante come il braccio sinistro che tiene la lancia. E' un sapiente
gioco di rapporti detto ponderazione perciò immutabile: il Doriforo
rappresenta un modello di equilibrio che esprime l'ideale greco di
coerenza razionale; insomma l'ideale di perfetta proporzionalità”.
STATICA
Quando
una scultura è sbilanciata rispetto al suo centro di gravità, si
dice che non pianta, poiché la sua posizione è errata e fa'
l'effetto di cadere da una parte o dall'altra. Nel posizionare una
statua, gli scalpellini sono particolarmente accorti nell'intaglio
della base (piedistallo). Solitamente, nel metterla nella posizione
eretta, utilizzano, per la perpendicolare, il filo a piombo e la
livella: lo scopo è quello di segnare, nella base di appoggio, a mo'
dei praticanti, la linea di un equilibrio stabile, partendo, in alto,
dalla fossetta giugulare verso il basso, a traguardare (come se fosse
un ipotetico piano sagittale). Detta fossetta, seguendo una
esperienza tramandata, rappresenta il punto di corrispondenza nel
quale va' posto il filo, la linea a piombo deve cadere, sempre, sul
piano trapezoidale costituito nella base di appoggio dalla posizione
dei piedi ( tale configurazione lineare del trapezio, è costituita
dalla posizione dei due piedi, con i talloni ravvicinati e le piante
leggermente divaricate). “ In ogni postura rileviamo: - che il
centro di gravità o baricentro di un corpo è il punto sul quale si
bilanciano, da tutti i lati, le parti del corpo stesso, ed è la zona
più grande e pesante, il bacino; - che la linea di gravità è una
perpendicolare tracciata da questo punto al suolo” . Consideriamo
inoltre che nella stazione eretta simmetrica questa cade in mezzo ai
due piedi. “Si utilizza il filo a piombo come linea di riferimento
(linea a piombo)... perché rappresenta uno standard che si basa
sulla legge naturale di gravità e ci permette di utilizzarla”.
Ovviamente, vanno seguite alcune posizioni mediante le quali si
compie il passaggio dalla stazione eretta simmetrica alla stazione
eretta asimmetrica. In ogni posizione asimmetrica il divaricarsi
delle gambe produce un inclinarsi del bacino e un conseguente
spostamento del tronco per riportare la linea di gravità sulla base
di sostegno.
La
linea del filo a piombo per seguire tali spostamenti deve fissarsi su
un punto preciso: crediamo sia quello della gamba portante o tesa,
puntando direttamente il filo in corrispondenza del malleolo mediale
della tibia.
“
Sappiamo
dalla meccanica che il centro di gravità di un corpo è un punto sul
quale si bilanciano esattamente da ogni lato le parti del corpo
stesso; e che la linea di gravità è una perpendicolare tirata da
questo punto al suolo: quindi si conviene che “il centro di
gravità di un corpo è corretto quando la linea di gravità scende
al suolo entro i limiti della sua base di sostegno”. Tale piano
viene definito base di appoggio, e si ottiene unendo i punti di
contatto del corpo con il suolo: la stabilità di un corpo sarà
tanto migliore quanto più la base di appoggio sarà grande e il suo
centro di gravità sarà basso. ( Spesso, gli artigiani utilizzano
anche un piccolo accorgimento: secondo alcuni atteggiamenti, danno
alla statua pochi millimetri di leggera pendenza in avanti, poiché
la tradizione suggerisce che adottando una perfetta perpendicolarità,
si ha la sensazione che la figura cada all'indietro). Nella “postura
normale in veduta laterale, la linea di gravità passa attraverso il
processo mastoideo, la metà della clavicola, l'acetabolo e le
articolazioni metarso-falangee. Nelle posizioni atletiche o militari
la linea di gravità si sposta dietro l'acetabolo”. Naturalmente,
dobbiamo confrontarci con diversi atteggiamenti: ad ogni figura
appartiene una propria postura e un diverso punto di vista, con il
cambiare delle posizioni e collocazioni. Permane una regola
immutabile: “nei vari spostamenti, simmetrico e/o asimmetrico,
cambiare la posizione anche di una sola delle parti del corpo,
significherebbe cambiare, contemporaneamente, tutte le altre, fino a
raggiungere un nuovo equilibrio”.
“
L'equilibrio
raggiunto da Policleto, detto ponderazione, è un equilibrio stabile,
ottenuto con un gioco sapiente di rapporti. C'è dunque una serie di
relazioni, la più evidente è quella, inversa, delle gambe e delle
braccia”. “Se la gamba destra è portante, sostiene tutto il
peso, il bacino è inclinato scendendo verso la gamba libera, di
convesso il tronco per contenere tale spostamento, e per riportare la
linea di gravità sul piede destro, si inclina lateralmente dal lato
opposto, producendo una linea concava verso destra. Il centro di
gravità è sempre in un punto all'interno dei piedi. Nell'esempio
detto, è più aderente alla gamba tesa e coincidente con l'interno
del piede di appoggio”.
LA
POSTURA
Appunti
dal Prof.. F. Perrotta.
“
Si
definisce postura la posizione che il corpo, o una sua componente,
assuma grazie alle proprietà passive dei legamenti e dei vincoli
articolari ed alle proprietà attive dei muscoli tonici, in armonia
con la forza di gravità (Caradonna).
“
Con
postura si intende qualsiasi atteggiamento, definito dai rapporti che
si stabiliscono tra i vari segmenti corporei, che possiamo assumere
nello spazio (Boccardi).
“
La
postura può essere considerata l'insieme dei rapporti esistenti tra
l'intero organismo, le varie parti del corpo e l'ambiente che lo
circonda (Tribastone).
“
La
postura è l'espressione somatica di emozioni impulsi e
regressioni...riflessione inconscia nell'atteggiamento esteriore
della propria condizione interiore, la propria personalità
(Cailliet).
E'
bene chiarire che non esiste una postura ma un numero infinito di
posture: esse corrispondono a qualsiasi posizione in equilibrio.
Quando parliamo di postura ci riferiamo ad un'idea, rappresentante
quella condizione strutturale e funzionale del corpo umano che
permette l'acquisizione di ogni posizione normale per l'espletamento
delle funzioni motorie, statiche o dinamiche, con il massimo di
equilibrio (stabilità), la massima economia (minimo consumo
energetico), il massimo di comfort (minimo stress sulle strutture
anatomiche). In pratica la postura è il modo di stare in equilibrio
del corpo umano sia esso fermo che in movimento, e tale equilibrio è
il risultato dell'adattamento delle varie strutture del corpo: S.N.C.
(sistema nervoso centrale), colonna, arti e loro interconnessioni con
il mondo esterno”.
Ci
rendiamo conto che lo studio e la documentazione del presente
elaborato preso dai vari AUTORI può sembrare superfluo: gli è che
ampliando le conoscenze si padroneggiano maggiori possibilità di
espressione e rappresentazione. Migliorare il proprio bagaglio
segnico può essere positivo, per molti, aiutandoli ad aprirsi a
nuove possibilità poetiche; oltreché evitare rappresentazioni del
corpo inanimate (prive di sentimenti), squilibrate ed ingessate tal
quali le mummie o pencolanti manichini, che nella loro specifica
caratteristica ben rappresentano il loro essere (N.D.R.).
“Consideriamo esemplare che ogni corpo o forma occupa uno spazio e
in qualche modo ne è occupata. E contemporaneamente non si può
considerare la luce un elemento di casualità, casomai quale evento
sopranaturale che ha “ il potere di svelare il mondo naturale e di
dare una definizione alle cose: la luce, materia tenue che scivola
sulle superfici, indaga, rivela, da risalto agli oggetti e descrive
la realtà. Oggetto di studi fin dal Rinascimento, essa misura lo
spazio e il tempo, modella e forgia gli oggetti, suggerisce la
tridimensionalità e la profondità spaziale”.
“
La
postura eretta è caratteristica dell'uomo. Essa dipende
dall'attività integrata di tutta una serie di meccanismi riflessi e
coordinati che la determinano, la mantengono, la ristabiliscono
(Houssay).
“
La
stazione eretta è un riflesso (risposta) posturale ampio e composito
nella cui attivazione è di importanza fondamentale la contrazione
dei muscoli ANTIGRAVITARI che si contrappongono all'azione di gravità
che altrimenti causerebbe la flessione delle articolazioni e la
caduta del corpo (Sherrington,1940).
BIOMECCANICA:
IL CENTRO DI GRAVITA'
(di
Cristina Urbisaglia)
…
.La
forza di gravità è il risultato dell'azione terrestre sui segmenti
(parti) corporei. Possiamo considerare un corpo solido come un
insieme di particelle pesanti, legate rigidamente le une alle altre.
Poiché l'attrazione terrestre si esercita su tutte le particelle,
il corpo si può ricondurre ad un insieme di forze parallele che
agiscono simultaneamente, le quali possono esser sostituite dalla
loro risultante, che è la forza capace di effettuare da sola il
lavoro dell'intero sistema di forze ed il cui punto d'applicazione è
detto centro di gravità (punto G) o baricentro. Praticamente tutto
accade come se l'intera massa del corpo fosse concentrata in quel
punto G che, soggetto alla gravità terrestre, diviene il punto di
applicazione della forza del peso del corpo.
Nella
posizione eretta, il baricentro cade a livello della 3^ vertebra
sacrale. L'asse del corpo è ortogonale a quello trasversale, che
collega le articolazioni dell'anca, e la loro intersezione avviene a
livello della 3^ vertebra sacrale. L'asse del corpo interseca ,
inoltre, l'asse trasversale delle articolazioni del ginocchio e
quello tibio-astragalica. Riferendoci alla statica umana, il corpo,
nella postura verticale, ha la necessità fisica di far cadere il
baricentro del peso corporeo su un piano trapezoidale, costituito
dalla posizione dei due piedi con i talloni ravvicinati e le piante
leggermente divaricate. Tale piano viene definito base di appoggio, e
si ottiene unendo i punti di contatto del corpo con il suolo: la
stabilità del corpo sarà tanto migliore quanto più la base di
appoggio sarà grande ed il suo centro di gravità sarà basso ( ...”
tanto minore quanto questi lo sarà rispetto all'altezza del
soggetto. Quindi il baricentro può variar da persona a persona, in
base alla distribuzione del peso, all'altezza, all'età e sesso.
Inoltre esistono automatismi posturali che consentono alla linea di
gravità di cadere sempre all'interno della base di appoggio”..
N.D.R.).
Perciò,
nella posizione eretta, con i piedi uniti, le parti del corpo,
sovrapposte le une alle altre, risultano in equilibrio poco stabile,
poiché il baricentro cade all'interno di una base di appoggio
ristretta compresa tra le proiezioni delle teste dei femori sul
suolo. Il corpo, quindi, tenderebbe a cadere in avanti se il tono
muscolare non lo tenesse continuamente fermo nella posizione eretta:
divaricando le gambe la base di appoggio diventa più ampia e
l'equilibrio più stabile.
Alla
perfetta posizione del baricentro del corpo collaborano le curve
fisiologiche della colonna vertebrale...” . “ Esaminando la
stazione eretta, vista posteriormente, il punto fisso di riferimento
si trova a metà tra i talloni e rappresenta il punto del piano
medio-sagittale del corpo in allineamento ideale che si ha, secondo
Kendal, quando la linea a piombo si estende iniziando a metà
distanza tra i due talloni, verso l'alto a metà strada tra gli arti
inferiori ed attraverso la linea mediana del bacino, della colonna,
dello sterno e del cranio”.
CONTINUA
POSTURA (Perrotta)
“ Il
baricentro è il centro esatto della massa di un soggetto, ossia il
suo centro geometrico, quando tale soggetto possieda una massa
simmetricamente distribuita e sia omogeneo. Se la massa come nel
corpo umano, è distribuita in maniera asimmetrica rispetto al piano
orizzontale (trasversale), il baricentro sarà collocato
proporzionalmente più vicino alla zona più pesante”. E, nella
simmetria, il centro può considerarsi il bacino, così come è
comparabile nell'esposizione dell'uomo Vitruviano?, dal quale
Leonardo accettò la regola del quadrato degli antichi, proponendo,
in questo studio, anche il canone delle proporzioni del
Rinascimento: “L'uomo con le braccia aperte può essere iscritto in
un quadrato formato da due lati perpendicolari agli arti superiori e
da altri due lati, dei quali uno passi a livello della pianta dei
piedi e l'altro alla sommità del capo. Se le braccia sono alquanto
sollevate oltre la posizione orizzontale e gli arti inferiori sono
divaricati, la figura umana si può inscrivere in un circolo il cui
centro corrisponde all'ombelico”. (Vedi disegno).
All'idea
di eleganza e di animazione risponde il canone di Lisippo, che ci è
stato tramandato da Vitruvio. Le regole sono le seguenti:
l'altezza
della faccia si divide in tre parti uguali: una compresa fra il
mento e la base del naso; una seconda tra la base e la radice del
naso; ed una terza fra la radice del naso e l'impianto dei capelli
l'altezza
della faccia, dalla base del mento alla linea dell'impianto dei
capelli, è uguale alla decima parte del corpo ( purché sia un uomo
di m. 1,80 e m. 2, n.d.r.)
l'altezza
totale della testa è uguale all'ottava parte dell'altezza del corpo
( in un uomo di m. 1,80 n.d.r.)
l'insieme
dell'altezza della testa e del collo corrisponde alla lunghezza del
piede, e ad un sesto dell'altezza del corpo ( sempre m. 1,80 )
l'ombelico
si trova al centro del corpo
l'altezza
del corpo è uguale alla dimensione delle braccia aperte in croce.
Gli
artisti del Rinascimento adottarono, in preferenza, i canone di
Lisippo, tramandatoci nell'opera di Vitruvio.
I
canoni sono molteplici, sia quelli moderni, sia quelli classici,
preferiamo impiegare un modulo semplice, che utilizza l'altezza della
faccia anziché quella della testa. Tralasciamo i trattati di
composizione del corpo umano, esclusivamente a scelte di
specializzazione individuale. Per chi desidera approfondire la
materia, IL MORELLI, ANATOMIA DEGLI ARTISTI, è un testo scolastico
esaustivo. Qui desideriamo segnalare un procedimento pratico, che
utilizza la nostra mano aperta, con le dita unite, come modulo
equivalente. Constatiamo che essa ha la stessa all'altezza della
nostra faccia. Lo possiamo accertare, provando a coprire la faccia
con la mano sovrapponendola ad essa, partendo dall'attacco del
polso, sopra la base del mento, fino ad arrivare con le punte delle
dita all'impianto dei capelli.
Il
modulo della faccia, come già detto, si divide in tre parti uguali:
mento e base del naso, da questa alla radice del naso, dalla stessa
all'impianto dei capelli. Perciò è utile comporre altre divisioni
simili per meglio proporzionare il viso: - una di queste corre dalla
proda (radice) del naso, per tutta la lunghezza dell'occhio; -
l'altra, dalla fine dell'occhio alla fine delle orecchie; - invece,
dall'uno orecchio all'estremità opposta dell'altro, un viso di
lunghezza. La gola una delle tre misure: sotto il mento, è la parte
anteriore del collo, fino alla fossetta giugulare. A partire da
questa, dal manubrio dello sterno, fino alla sommità dell'omero un
viso, sia a destra che a sinistra. La lunghezza totale della mano
corrisponde all'altezza della clavicola e della scapola; ma nella
metà dell'omero è contenuta una volta e mezzo nella lunghezza
dell'avambraccio: una mano dall'inserzione del deltoide
(articolazione della spalla) al gomito; e da questi al nodo della
mano una corrispondente altezza del viso e una delle tre misure.
La
statura è uguale a sette volte e mezzo il modulo.
Con
la mano aperta è possibile misurare il nostro corpo: dalla fossetta
giugulare ai pettorali, dai pettorali all'ombelico, dall'ombelico al
pube e da questi a metà della coscia; dalla metà della coscia al
ginocchio e da questi a metà delle gambe, dalla metà delle gambe
alla caviglia; dalla caviglia alla pianta del piede. Il piede è
lungo quanto la faccia, più una delle tre misure. Se l'uomo, in
posizione eretta, distende le braccia con le mani aperte arriva a
metà delle cosce.
Nelle
donne le misure sono leggermente inferiori: diversità sostanziali si
rilevano nel tronco dell'uomo, più largo in alto. Mentre nella
donna, per il maggior sviluppo del bacino, è più largo in basso.
Queste
empiriche nozioni possono aiutare nel lavoro di scultura, molte altre
sono degne di menzione, ne citerò solo una, relativa a presunte
sproporzioni, rivelatesi, ad uno studio più attento, intelligenti
accorgimenti. Sono quelle correzioni di proporzione dovute a
particolari vedute di scorcio e a taluni effetti prospettici: sono
principalmente punti di vista, frontali o laterali, talvolta
seminascosti, che realizzano o collocano delle figura in certe
altezze o distanze che possono mutarne le apparenze. In questi casi
si evade da alcune lunghezze per compensarne l'effetto ottico. Un
esempio di correzione, nei templi Dorici, che mi preme comparare, a
mo di esempio e merita di essere studiato, è quello del
rigonfiamento, nell'ordine Dorico, delle colonne (èntasi), utile a
correggere l'effetto ottico di un suo assottigliarsi, negli spazi
maggiori, insieme ad altre correzioni per contrastare le convergenze
prospettiche.
CONSIDERIAMO
LO SPAZIO IN CUI SONO POSTI I SOLIDI.
Lo
spazio è una estensione di superficie non occupata, l'ambiente del
mondo sensibile dove si muovono gli uomini e le cose: un immenso
vuoto limitato/illimitato nel quale si muovono i corpi, libero e
disponibile, che pertanto può essere occupato, nel movimento del suo
perenne ampliamento. Perciò concepiamo lo spazio come volume che si
sviluppa lungo le tre dimensioni: altezza, larghezza e profondità.
Misurare lo spazio si può se misuriamo quello occupato da un corpo
nelle tre dimensioni. Osservando un oggetto cominciamo ad avvertirne
una dimensione, una grandezza, la paragoniamo e separiamo da altri
corpi, e ne misuriamo, rispetto a questi, le dimensioni e la massa; a
tal punto da sentirli in maniera anche tattile. Perciò un corpo
occupa lo spazio, ma anche esso ne è occupato; fino a percepirsi
reciprocamente : un oggetto finisce dove un altro comincia, si
intersecano, si contaminano vicendevolmente, rendendo sensibile e
plastico il loro prolungamento. Perciò potremmo, anche, affermare,
che sono forme di movimento o dinamismo diversamente espresse.
IL
MOVIMENTO come sostanza.
Tutto
ciò che noi pensiamo e facciamo si traduce in attività emotiva e
movimento, il quale è sempre l'espressione di una pulsione
interiore. Dunque, il movimento è sostanza: è il primo effetto di
un bisogno, di una esperienza subitanea o già vissuta; di emotività.
E' tutto quanto i sensi trasmettono direttamente alla nostra mente,
che si traduce nell'impulso di produrre un determinato sforzo fisico.
Quindi, movimento fisico e psichico come manifestazione di una stessa
realtà: ed è " il mezzo per trasferire un qualsiasi messaggio
estetico alla coscienza di un individuo osservatore o spettatore".
Il corpo oltre ad avere una propria musicalità interna è lo
specchio del nostro pensiero e conseguentemente della nostra vita.
Sono le necessità del nostro fisico ad imporre i ritmi al nostro
organismo. Perciò gran parte dei movimenti del nostro corpo nascono
da un pensiero cosciente, che può essere astratto o far parte di un
codice condiviso e trasmettere un'idea, un pensiero. Ma,
inopinatamente, può anche manifestarsi il contrario, non essere
forma e rappresentare alcunché. E' impensabile un movimento
totalmente privo di intenzione: i Greci chiamavano questa astrattezza
metacinesi, gli armonici del movimento fisico (cinesi), in una
correlazione tra fisico e psichico. Però, tutto questo sforzo,
diciamo interiore e psicologico, che ci lega alla realtà e ad una
moltitudine di attività umane, nella scultura e in particolare nelle
opere classiche, sembra molto sopita, tal ché sembra poter assumere
quella rigidità e inespressività tipica dei manichini. Ma non è
così!
"Ancor
prima del periodo Arcaico e dell'età classica, lo stile geometrico
esprimeva i primi fondamenti dell'arte Greca. In questa epoca c'è
una volontà costruttiva, la ricerca della perfezione
nell'assolutezza geometrica. Detto stile, oggi rivalutato, è la
riproduzione di forme esatte (perciò non transitorie), la ricerca
dell'assoluto, la perfezione della forma e la proporzionalità: il
rapporto reciproco tra le varie parti in funzione del tutto,
invitando ad una infinità di soluzioni lo schema geometrico
accentuato dalla ripetizione del modulo. Si definiscono così i
principi dell'arte Greca: la ricerca dell'uno, del principio
generatore, l'ordine (còsmos ), in contrapposizione al molteplice,
al relativo, all'apparente. Se i pensatori ricercano le cause di
tutte le cose, gli artisti cercano di rappresentare non ciò che è
transitorio, mutevole, mobile, ma ciò che è perfetto e, come tale,
immobile e immutabile. Cioè la causa di tutte le forme che vediamo,
ossia L'IDEA. Così, dall'uomo eterno e perfezione di tutte le cose,
nella Statuaria, ci si avvia verso altri periodi storici: si va'
verso il mutamento dell'espressione e contro l'immobilità degli
atteggiamenti e movimenti reali, si attuano gli intervalli tra i
gruppi e lo spazio tra gli arti che, liberi, si immergono nel vuoto.
Mentre ritmano e si esercitano, equilibrio, simmetria, mimica,
ricordano, spesso, una diversa e più bilanciata articolazione del
corpo ( similmente alla ponderazione). Non vengono trascurate neppure
le regole e l'ideale di una perfetta proporzionalità, consone alle
tecniche dell'intaglio, e la forza di astrazione stilistica del
chiasmo (l'incrocio e inversa corrispondenza degli arti che esprimono
varietà e coerenza razionale nel rapporto tra le varie parti).
Ricordiamoci
sempre che la maggior parte dei movimenti è dovuto a necessità
psico-emotive, e possono essere stimolati da un pensiero cosciente o
istintivo, più o meno intenzionali. La figura, il nostro corpo, ha
una sua particolare architettura, stabilita da forme geometriche
umane e dalla sua proporzione ( o canone ), costruita in maniera da
assumere atteggiamenti e posizioni sempre più evolute, a seconda
delle civiltà o difficoltà riscontrate nell'ambiente; ma anche
conseguenti alle necessità del comunicare rispetto all'avanzare
delle specializzazioni umane. "Perciò nella rappresentazione
scultorea, l'atteggiamento assume un valore essenziale fissato da
assi ( andamenti verticali,obliqui, orizzontali), da parallelismi e
da angolature: elementi necessari per l'intelaiatura della figura.
Conseguentemente, il rapporto - tra testa, tronco ( articolazione
dello atlante con l'occipitale fino al sacro vertebrale ), con l'anca
e l'insieme degli arti - dovrà essere tracciato con assi, i cui
rapporti varieranno secondo le proporzioni naturali del modello o
canone corrente" . Cosicché ogni corpo mantiene un suo ritmo
interno, ed i movimenti si compongono posizionando le braccia, le
gambe, la testa, secondo l'espressione che desideriamo comunicare e
il tipo di fisico proprio della figura rappresentata. Di più,
secondo le interpretazioni dei volumi, degli spazi e del rapporto tra
i piani, delle rientranze, degli scorci ecc... Ne consegue che il
movimento si può esprimere nei più svariati modi: con le linee, il
colorismo plastico del Bernini o i chiari e scuri; con sequenze di
immagini , il contrasto di masse e vuoti, la composizione modulare,
la profondità e le superfici texturizzate. La linea come il colore è
un potente mezzo espressivo: un protagonista che, privando della sua
consistenza la materia, sostituisce la massa, può creare lievi
ondulazioni o dinamiche scarnificazioni, formare rigidi contorni o
ferme campiture. Secondo le articolazioni e l'andamento la linea può
rappresentare: la retta (rigidità e stabilità), curva (delicata,
morbida, movimento), la spezzata (nervosa scattante dinamica), mista
(cambiamento movimento tensione); mentre l'orizzontale (calma stabile
e fredda), la verticale (slanciata dinamica, spiritualità e
leggerezza), l'obliqua (instabile dinamica, va verso il cambiamento).
A tal guisa si possono avere: un mordente profilo lineare, guizzante
o nervoso; può concorrere al dissolvimento di forme plastiche e
atmosfere luminose (incisiva texture); la statua si chiude in se, con
raccoglimento, seguendo un modulo ovalizzante suggerisce sentimenti
calmi e sereni; drammaticità e movimento espressi in potenza, oppure
attraverso uno scatto repentino, conquista più spazio uno slancio
violento fuori di equilibrio. Il movimento di solito suggerisce la
drammaticità, ma vi possono essere movimenti scomposti che
suggeriscono una calma compositiva. Possiamo avere notevoli
astrazioni stilistiche o magnifiche trasfigurazioni, a seconda dei
canoni interpretativi. Nelle diverse articolazioni tra le varie parti
del corpo si possono ricercare le relazioni più opportune nello
spazio e con altre figure o costruzioni. Importante è trasmettere un
intenzionale (voluto) messaggio estetico.
LO
SPREGIO DI MOLTA ARTE MODERNA E COMMERCIALE.
Certo
oggi la produzione della scultura va di fretta ed a risparmio ( solo
problemi di costi, di mercato e di cattivo gusto ). Perciò occorre
uno sforzo immane per recuperare all'esperienza del banauso
quell'impulso interiore, libero di esprimere la forma estetica data.
Le difficoltà di molti artisti, in gran parte tecniche, di scolpire
direttamente una qualsiasi statua o soggetto decorativo, sia
astratto, sia di altro genere, menomano l'idea o il modello
originale. E' la rottura di un tradizionale rapporto tra l'artista
(modellatore, statuario) e l'artigiano che assume in sé la fatica
dell'intagliatore (scultore): al primo che ha originato "l'idea"
viene a mancare il particolare ritmo, dato dalla tensione e sforzo
muscolare del mestiere, che è tecnica, cioè vita e armonia di
movimenti, espressione di una pulsione interiore, non trasmissione di
un qualsiasi sforzo fisico. E' il sentire dentro di sé tutta la
spinta emotiva di una tradizione secolare, vissuta con uomini, luoghi
e suoni della memoria, portando dentro di sé tutta la pastosità
della materia, e vivere dentro questa sua tridimensionalità,
sfruttando l'espressività dei volumi, per ottenere diversi livelli
di piattezza e variazioni di rilievo. E nella sua forma più pura,
intagliando e ancora intagliando, per catturare e rimandare la luce,
quel gioco o rapporto tra le parti, nel trapasso dei piani, ora
accentuando, ora muovendo finzioni di movimento lineare; oppure
contaminazioni e relazioni con altre parti, innovando le idee
attraverso l'antico linguaggio dei segni per continuare a creare. Per
mantenere questa fedeltà alla forma della scultura, occorre superare
lo scadimento del mestiere e la sua eccessiva industrializzazione. Lo
lo si può fare solo con un contraltare di forte tensione e ricerca
di unità, tra l'artista (modellatore) e lo scultore (artigiano),
portato al livello delle più alte professionalità e/o personalità.
Unione che preferiamo ricomposta in una sola persona. Sempre nel caso
che il lavoro dello scolpire sia assunto da una persona diversa
dall'artista, non sono del tutte estranee le tecniche - neppure l'uso
di particolari "ferri" e procedimenti di esecuzione -
nella buona riuscita di un'opera, rispetto agli effetti voluti.
Le
macchine moderne sono ultra veloci, la nostra mente non ne
padroneggia il ritmo ed il braccio non sente l'impatto ambito. Anche
se, con il loro apporto, l'effetto ed il fine dello spianare,
tagliare, smerigliare, è perfettamente ottenuto. Manca , in tutto
questo il gusto nello scolpire, il sapore dello scolpire, l'amore dei
ferri e della loro manualità, quell'intima soddisfazione creatrice
di forme e di segni, che porta a mirabili effetti. Riporto un esempio
scomodo: vi è la stessa differenza, tra questi ultimi e le prime,
che passa metaforicamente tra il masticare il cibo (con i ferri)
correttamente, e il trangugiare (le macchine) velocemente,
rigettandolo. L'effetto, non solo estetico, è agli antipodi: difatti
di un marmo mal intagliato si dice “chi iè biascicat”
(biascicare, rimasticare, ruminare).
Perciò,
non è sufficiente un frequente sentirsi, con l'ideatore, se il solo
intento è quello di comporre una comunissima copia fedele, poiché
rischia di isterilirsi l'autentico linguaggio della scultura: si
mette in primo piano il risultato definitivo e non le qualità
artistiche. Se il messaggio estetico ed emozionale non passa dalla
coscienza del primo (modellatore) a quella del secondo (scultore),
non si ricompone la frattura fra invenzione ed esecuzione. Entrambi
devono essere portati a compiere una profonda immersione nella forma
concepita, proprio immedesimandosi nella particolare materia della
lavorazione: cioè dentro al crescere di quella particolare empatia
muscolare e meccanica, nelle su mutevoli espressioni, che passa dalle
difficoltà tecniche ai trucchi del mestiere. Comunque, sempre dentro
quel respiro che dall'idea originaria deve poter emanare, nella sua
qualità e stile, fin dai primi colpi dati al blocco di marmo.
Fino
dall'Ottocento lo scopo delle arti figurative è stata l'imitazione
della realtà: e, nella misura in cui veniva raggiunta, lo scopo e la
riuscita dell'opera da parte dell'artista. Una imitazione assai
difficile per il bianco e uniforme candore del marmo. Bernini, sulla
resa della somiglianza in marmo, affermava che: "per imitare
bene il naturale faceva (modificava) ciò che nel naturale non
c'era". (La distorsione come idealizzazione, cioè uno staccarsi
dalla norma naturale). E " lavorando e scavando la pietra, in
modo da catturare e rimandare la luce in gradazioni diverse, Bernini
ha creato l'illusione di un continuo trapasso di superfici
differenti". E affermava che: nell'imitazione è “tutto
diletto dei sensi nostri", poiché per lui " imitare aveva
un senso più largo e più profondo: produrre un singolo essere umano
in un blocco di marmo, non significava solo scolpire un volto che
avesse il maggior numero di tratti in comune con il modello, ma
creare una potente illusione di individualità, di presenza reale e
di vitalità". Sembrano, questi, concetti senza senso: riferiti
oggi nello scadimento più commerciale che industriale, con la
cancellazione quasi totale della cosiddetta "filiera" che
rappresentava le lavorazioni in loco. Allorquando la nostra stessa
scultura - negli impieghi di produzione monumentale, funeraria, la
cosiddetta commerciale, ma spesso anche ritrattistica - è priva di
una qualche naturalezza, vuota di passioni, perciò fredda, e priva
di quei caratteri tipici della sfera umana. Ci siamo dimenticati che
l'arte è conoscenza ed espressione di un sentimento. Da tempo, si
producono solo stereotipi, che, nella migliore dei casi, vengono alla
luce nel vago ricordo di una qualche tradizione artigianale o scuola
che dir si voglia: solo produzione di brutti prototipi, testimoni
scomodi di una inespressiva rigidità. E non è il solo dramma
vissuto dalla scultura carrarese: hanno valore solo gli stracci e
l'impiego di materiali diversi da quello, ahimè! nobile, il marmo.
Infatti in tutto il Comune non è stanziale un solo atelier degno di
questo nome, ma solo botteghini pieni di bigiotteria. Ad onor del
vero, non poche botteghe artigiane mantengono alto il prestigio di
Carrara nel mondo, ed avrebbero mantenuto la loro verginità e
naturalezza se non fossero state sedotte e abbandonate dalla cattiva
politica, tradite anch'esse dal frusciar dei soldi. Così nuovi ed
insipienti soggetti, sempre di passaggio e sempre ben pagati, hanno
insterilito il territorio, lasciando poche ed insignificanti opere,
quanto meno a disonorare la storia della scultura di Carrara. Sono
ciurme di impostori avidi, con modi da vecchi e untuosi "bottegai",
sempre ben protetti e divinizzati.
E'
importante che le idee in campo profumino di soldi, all'uopo, sempre
gli stessi, ammantati solo di una qualche prosopopea da genietto
ambulante o da "corretti politicamente", possono aprire
tutte le porte. Mi sia consentita una sola domanda ai compratori:
tutti questi materiali poveri, assurti ad arte direttamente dalla
raccolta differenziata, ma venduti a costi altissimi, quanto pensate
varrà (avrà valore) un domani non lontanissimo". Auguri ai
vostri eredi.
LA
PIETRA RACCONTA IL LINGUAGGIO DEI SEGNI.
Ognuno
di noi ha percorso un comune cammino insieme ai suoi simili, ha
arricchito le proprie conoscenze e il proprio linguaggio; ha vissuto
in più luoghi e accumulato esperienze, ricevuto impressioni,
nutrendosi di nozioni e sensazioni, spiritualmente, dentro una
infinità di cose e luoghi. Eppure, ognuno è diverso: nell'esaminare
un oggetto, nel selezionare un suono. Alcune voci o suoni ci sono
familiari, alcuni li selezioniamo per la loro musicalità, altri li
ignoriamo o allontaniamo con fastidio perché solo rumorosi. Così è
per i colori, linee, plasticità e spazialità. Siamo distratti da
altro, o non possediamo una sufficiente educazione per ascoltare
buona musica, saper vedere un'opera d'arte, leggere un buon libro?
Qual'è il nostro status, quando siamo abbagliati dalle novità del
diverso, indolentemente diverso, e, in pigrizia, da una infinità di
luoghi comuni? L'ostacolo principale, il culturalismo, è nascosto
dietro la parvenza del fare e del supermercato delle idee, assunto
senza fatica e senza impegno, purché vi sia quella visibilità e
quella possibilità del far comunella: uniti nel fare liste di
proscrizione con gli amici dei miei amici a suggello del sodalizio,
contro l'odiato nemico. E vai con il dazebào che è il miglior
viatico artistico riconosciuto, efficace quanto spensierato, perché
alla ricerca di un facile consenso, in linea con l'opportunismo
corrente, dove tutto è banalmente stereotipato. Suvvia, una bella
firma! Ma una ratifica genuina, che coglie i frutti migliori dalla
pianta dei tuoi sentimenti, non c'è,
qui,
ora, né appare all'orizzonte della dialettica codice-messaggio.
Quand'è l'astio e l'odio a ritmare la socialità, la contemplazione,
l'idealità, l'ammirazione, si cementa il perenne contrasto verso
tutte quelle attitudini che sono parte integrante della nostra
capacità di essere soggetti, liberi, della comunicazione. Perciò,
in quel contesto, “ non possiamo ambire a leggere né proporci la
realtà conosciuta in modo diverso, per rinnovare la nostra visione
del mondo, in modo da avvicinarci a realtà altrimenti inconoscibili.
L'intervento artistico attua questa ricerca e questa trasformazione
operando appunto sui segni, sui mezzi linguistici, dei quali esplora
nuovi assetti e nuove configurazioni, attraverso la modellizzazione
espressiva. ” Eppure una moltitudine di segni, linguaggi (codici)
sono comuni, sono parte di consuetudini consolidate che,
storicizzandosi, ci hanno coinvolto quotidianamente: stupisce il
contrasto con molta della attività sociale e della produzione
artistica, quando si vuole solo stupire o provocare brutalmente,
aprendo ferite dolorose, esclusivamente volte a lacerare e
impressionare; a fissare personalismi liberticidi, a comprimere
attitudini e comportamenti espressivi . Tutto ciò è sconcertante.
Amare
La Pietra.
Questa
amarezza l'ho subita, proprio riflettendo sulla mia, non ricca,
attività di scultore, ispirato anche dalla passione nel ricercare
pietre particolari, che solo nella mia mente assumono strane
configurazioni ( nel sasso Michelangelo vede la forma e nell'opera
incompiuta infinite possibilità di soluzione: dentro ogni blocco di
marmo esistono infinite forme); è la ricerca di un senso che non
riesco a comporre. La nostra sensibilità è in gioco e si beffa di
noi. La burla accompagna la nostra miopia, osserviamo tutto per non
vedere nulla: ad esempio, in molte pietre, ignorate dai più, ognuno
vi può trovare molteplici significati; un segno, che può essere
arricchito con poche o molte modifiche, a seconda dell'estro. E'
possibile dire che la storia si respira in ogni pietra; molto spesso
tra quelle che si trovano nel corso dei fiumi, nei dirupi, interrate,
perfino nelle discariche, soprattutto se i suoi materiali di risulta
provengono da case vecchie. Il linguaggio è fatto di tanti simboli:
la presenza di una scaglia di marmo, ordinario, statuario, grezzo e
ricco di impurità minerarie, venato o spaccato, come tutte le
pietre, costituisce un'immagine concreta del senso; cioè mostra già
il senso in se stesso, e lo dimostra in maniera più o meno ricca a
seconda dell'esperienza di ogni individuo. Si ripropone l'iniziale
dilemma: il contemplare è diverso dal semplice osservare, perciò di
fronte ad una ispirazione, un'intuizione, cosa diciamo (con le idee
chiare); in che modo lo diciamo (quale linguaggio usare), come
innervare intuizione e spontaneità; ben sapendo che la percezione
visiva e l'elaborazione sono legati all'intuizione al pari
dell'esperienza personale: ognuno vede ciò che sa' ed esprime ciò
che gli è più caro negli intimi pensieri. Quando noi osserviamo un
disegno o una qualsiasi forma, lo misuriamo con un nostro modello
personale, poiché tale modello è la forma più semplice da noi
interiorizzata ed a questa facciamo derivare tutte le possibili
varianti. Quindi, non osserviamo passivamente un soggetto, ma
facciamo riferimento a modelli preesistenti in noi, affidando ad
essi, la riconoscibilità delle cose esterne; e se nelle forme vi
sono mancanze o elementi di disturbo tendiamo a riorganizzarle o a
riconfigurarle in un processo di unificazione. In quei modelli stanno
le radici della spontaneità.
Poniamoci
il dilemma riguardo al nostro tema : se le immagini ( le cose come si
presentano ) hanno un'enorme portata comunicativa, quando, l'artista,
le può rendere più esplicite, universali, caricandole di una forte
creatività? Escludiamole da ciò che è sciocca provocazione (
insipide performance ). Lasciamo piena libertà all'artista, che “
reinventa l'esperienza delle cose, e concreta in significati la sua
particolare ricerca”. Solo così è possibile interpretare ogni
immagine e renderla disponibile per una naturale lettura: gustarla,
superando la semplice somiglianza di significati nella sua
descrizione denotativa. Escludiamo le banalità dal momento creativo,
poniamo più attenzione alla forza delle idee: escludiamole dalle
speculazioni, almeno nell'attimo del concepimento e/o dall'intuizione
genuina. Attenzione alle varie tribù dei mercenari, che corrodono
anche i sentimenti più puri.
Impariamo
ad osservare le cose intorno a noi, i sintomi estetici che esse
promanano e costruiamoci dei modelli, semplificando ciò che
abbiamo osservato: spesso, facciamo finta di vedere, ma in realtà
guardiamo tutto senza recepire nulla. Creiamoci un nostro punto di
vista principale: un nostro saper vedere. Penso ad un sasso, che
porta i segni di un suo particolare percorso, dovuti all'usura in una
località o al tempo trascorso e all'utilizzo che ne è stato fatto.
Molte persone vedono solo una comune pietra abbandonata. Mentre altre
notano dei segni particolari che eccitano la loro fantasia. E' pur
vero che ognuno vede ciò che sa ed esprime ciò che meglio sente e
conosce; ma con quanta capacità sappiamo esprimere tanta o poca
spiritualità? Un segno può essere qualsiasi cosa o stimolare
qualsiasi.....idea. Gran parte dell'arte moderna ne è maestra,
spesso cattiva! Invece, quanta spontaneità e semplicità nei segni
di un bambino, e in quelli degli uomini primitivi; fino alle
illustrazioni simboliche delle icone marmoree (Maestà): dovute
all'ostensione dei simboli sacri, in immagini confortanti e
rassicuranti, che propongono linguaggi semplici, di getto, permeati
di un profonda spiritualità. Non lo sono, altrettanto, quelli che
fingono di assumere a modello la nostra realtà, spesso la nuda ma
imbelle quotidianità dei rassegnati. Sono i modelli dei soliti noti,
caricati di populismo e dai quali ci lasciamo imbellettare, nella
garanzia di una aspettativa di indipendenza, e di liberazione dalle
assurdità pubblicistiche. Siamo immersi in questa mondanità, a tal
punto che quasi ignoriamo le naturali bellezze dell'ambiente
circostante; e ci complichiamo la vita, la intristiamo e, nel
comunicare, usiamo codici perversi, oggetti-immagine, “ for sale”
, nelle prostrate prestazioni dei "notori" di oggi, sempre
in fieri, padroni dell'idea onnipotente: compiuta, eterna e
immodificabile, effimera. È l'immortalità che va' oltre l'uomo e la
sua ragione di essere. Lo ribadiamo!, più semplice è il segno
meglio viene colto e visualizzato (memorizzato): la chiarezza della
composizione e dello stile rappresenta il massimo della espressività.
In fondo in fondo, non è così? Ogni forma, in natura e/o nella
nostra mente è riconducibile a forme geometriche elementari,
archetipi.
È
di Michelangelo, sull'arte pregiata sua, la più sconsolata abiura
alla figurazione, né pensava come arte l'architettura, ma essa come
la poesia aveva propri codici: insomma nell'architettura, come nella
poesia vi è la rottura della tradizionale proporzionalità; è un
continuo conflitto tra l'osservanza e la trasgressione.
L'abiura
è esplicita : “ che giova il voler far tanti bambocci, se mi ha
condotto al fin, come colui che passò 'l mar e poi affogò ne' mocci
? ….” Ma si sarebbe redento, se avesse visto le
rappresentazioni dell'oggi, gli stravolgimenti, i tradizionali
rituali, con gli insensati gesti taumaturgici? “ Michelangelo, dopo
la conversione, sente la necessità di nuovi valori espressivi nei
componimenti, e, pur all'interno di forme canoniche, esprime nuovi
elementi lessicali, partoriti da un conflitto vissuto e vero:
l'esasperazione del dramma tra osservanza e trasgressione. La sua
sostanziale unità delle arti mirava ad una profonda, indissolubile
unità di arte, esistenza, salvezza. Unità ma superamento dell'arte
come imitazione, mimesi di una realtà esterna, la natura o l'antico,
dati come modelli; ma la vera difficoltà non erano tanto gli oggetti
dell'imitazione, quanto l'insieme costituiva un atto di servitù e di
possesso, una contraddizione assurda, in quanto obbedienza e rottura
liberatoria rispondevano agli stessi principi con uguale valore”.
Per Michelangelo concetto e immagine erano la stessa cosa, avevano la
stessa concentrazione e la stessa chiusura; e l'identità si
estendeva alla parola che doveva essere definita da una propria
struttura fonetica e sillabica, come l'immagine del proprio contorno.
Così come il contorno lineare delle figure aveva un senso finito,
circoscriveva l'immagine, tal quale la parola definiva il concetto. E
certo anche qui c'era contraddizione di finito e infinito, la stessa
che sboccherà nella contraddizione per cui il non finito era oltre
il finito, quindi il vero finito. Questa rara “coseità” della
parola consisteva nella fermezza del contorno, nella forza timbrica,
nello smalto lucente, come di pietra dura, che acquistavano le
singole parole...” in contraddizione per la loro nessuna
associazione in quel contesto.... “ parole che pure avevano un
senso comune stanno nel contesto poetico come i volti, i corpi, i
panni dei Profeti e delle sibille: nulla più che schermi per
intercettare e comunicare messaggi altrimenti inafferrabili”. In
tutto ciò “Non contava la portata dei concetti, ma la dinamica
della loro contraddizione....” Siamo, qui, di fronte ad una
particolare modellizzazione strutturale, in quanto già mostra il
senso in se stesso, cioè costruisce un'immagine concreta del senso:
il senso perciò è inseparabile dal significante”.
Tutt'altro
i travisamenti dell'oggi, con la perdita espressiva e
l'esasperazione di significati dissociati ormai da un qualsiasi senso
logico e lirico. E tutto questo ci porta a incomprensibili immagini,
alla devianza di simboli importanti, distorsioni linguistiche
insulse nella funzione della comunicazione. Perciò abbiamo imparato
ad usare tecniche approssimative, abborracciate, mentre il buon gusto
consiglierebbe una più appropriata osservazione, seguita da una
comunicazione comprensibile ed una tecnica espressiva più armoniosa.
Certo una buona padronanza tecnica non si trova per la strada, costa
fatica, studio e lavoro, non solo per copiare, ma anche nell'impegno
laborioso che si concretizza nella parola magica della creatività.
Bene il mestiere, ci si può perfezionare nel copiare o tradurre
opere, anche di grande valore, da piccoli modelli o altro. Diverso è
avvertire l'intaglio come un personale sentire segnico, che è dentro
di te, che è il tuo modo di dire le cose stilisticamente ed
espressivamente e ti guida, quasi inconsapevolmente, nella scelta dei
materiali e degli strumenti di lavoro. Le parole in questo caso
chiariscono parzialmente il concetto intagliare, levare il superfluo:
non è solo un corpo a corpo con la materia, è quel qualcosa di più
che fa la differenza, tra la fredda e razionale esecuzione, rispetto
alla espressione di un sentire che cova dentro di te. Osserviamo
attentamente, studiamo, le opere dei grandi maestri (in Michelangelo
anche il non finito è già un linguaggio). Così come in GL Bernini,
le stesse preziosità tecniche e lo stesso virtuosismo consentono un
utilizzo dei ferri come se vi fosse una organica comunione, un filo
diretto, con la materia. La mano che guida sapientemente la subbia
grossa nella trama e nell'ordito di profonde rigature, così come la
subbia piccola scava e modella particolari, già sagomando e
sfumando, anticipando il passaggio al ferro successivo. Cosicché
l'uso delle gradine ad una o più tacche delineano la plasticità di
un corpo o di un tessuto nel migliore dei modi, che di per se' sono
già gustosissimi e ricchi di musicalità.
IL
LAVORO DELLA SCULTURA.
Solitamente,
si inizia il lavoro di una scultura mettendo mano all'abozzatura
(sbozzo) e scandaglio dell'opera, per superare difetti ed impurità.
Nel contempo si verificano misurazioni e si mettono alcuni
capi-punto, affinché dal blocco vi possa uscire quel modello, preso
a campione, nelle proporzioni desiderate e programmate in scala. ( I
capi-punto, ripetiamolo, sono punti CHIAVE: punti strategici per la
buona riuscita di un lavoro ).
Lo
sbozzo ( sgrossare ) si inizia con la subbia e l'accapezzatore
(scapezzatore), per far saltare grosse scaglie. Poi, calcagnoli o
dente di cane (oggi in disuso); a seguire altri ferri detti gradine,
che lavorano sempre più finemente, a seconda del numero delle tacche
e della loro sottigliezza. Questi, se adoperati magistralmente,
gradinando il marmo, possono dare un modellato, una texture, sia
nelle parti anatomiche, sia nei panneggi, che raggiungono effetti di
straordinaria bellezza e pastosità. Sono sufficienti alcuni esempi
per tutti: i virtuosismi dello scalpello di GL Bernini, in
particolare i famosi ritratti; e di Michelangelo, il S. Matteo, i
Prigioni, le ultime Pietà, che andrebbero studiati attentamente. (A
ben osservare, le superfici texturizzate, nella scultura, non sono
molto diverse da un buon disegno: tratteggio e ombreggiature,
dimensionalità e accostamenti. Queste superfici sono composte da
linee ravvicinate, sono segmenti organizzati uguali o simili, a volte
intrecciati anche in maniera casuale; ma nel nostro esempio sono
disposti ritmicamente in modo da formare reticoli omogenei). Quindi i
solchi della gradinatura sono funzionali per catturare la luce o
effetti di vibrazione luminosa per chi guarda da lontano (nel San
Longino); ma sono gustosissimi anche alla distanza giusta
dell'osservatore.
La
gradinatura spesso è tolta più o meno con lo scalpello piatto,
dritto e tagliente, il quale può lasciare rigature e modeste
irregolarità non volute, che vanno eliminate con il doppio
scalpello, detto raschietto e usato con le sole mani, senza mazzuolo.
Abbiamo detto scabrosità non volute, vi sono anche colpi di
scalpello o di gradina volutamente lasciati a correre, dati con
grazia, premiando effetti di rara bellezza, verosimiglianti al
traslucido; nessun tratteggio dei migliori disegni gli sta alla pari
in finezza di trama. Molte sono le opere esemplari, in fatto di
pulimento e morbidezza. E' sufficiente citare alcune opere di
Michelangelo e del GL Bernini: del primo il Bruto del Bargello e il
David; del secondo, San Longino (in Vaticano) e la Costanza Bonarelli
(Bargello) ed Apollo e Dafne. Eliminare la gradina è fattibile e
possibile, se la finezza di grana del marmo lo consente, anche con
l'uso di buone raspe, ottenendo una reale carnosità, ad imitazione
della migliore naturalità, espressività e vitalità di un soggetto.
Successivamente, i passaggi della pulitura a lucido, se voluta e
secondo gli effetti desiderati, possono essere fatti con smeriglio,
carte abrasive, pomice e via via sempre più finemente fino alla
lucidatura a specchio (con acido ossalico); infine, la patinatura con
colori o con la cera vergine. Con il traslucido si gioca sul
contrasto nelle diverse parti della scultura voluta, intenzionalmente
non casualmente. Alcune parti si possono maggiormente lucidare (a
specchio o a pelle d'uovo), altre a contrasto, mantengono passaggi
della precedente lavorazione: a subbia, gradina, altri scarpelli;
infine raschietti, raspe, smerigli, ecc..
La
qualità del marmo.
Prima
di continuare a dialogare sulle tecniche, corre l'obbligo di
conoscere meglio la materia che ci accingiamo a lavorare, IL MARMO.
Da tempo, associamo alla parola marmo il significato di maggiore o
minore lavorabilità: " è la proprietà che ha il marmo di
lasciarsi segare, scolpire e lucidare per mezzo di adatti strumenti,
che lo riducono alle forme richieste. Nel linguaggio comune, in
origine, era considerato marmo qualunque pietra suscettibile di
ricevere un pulimento. Ma coll'andar del tempo, il significato che il
vocabolo aveva nell'antichità, subì una limitazione, cosicché si
esclusero pietre che presentavano una durezza notevolmente maggiore
(graniti, porfidi)". Per le scienze, la parola marmo denota
calcari che si dicono solitamente cristallini: " Il saccaroide
più facilmente si presta allo scalpello, quanto più la sua grana è
fine, cioè consta di individui piccoli di calcite (FINEZZA DI
GRANA). In linguaggio comune i marmi si distinguono in crudi o fieri,
deboli o fragili, a seconda della loro resistenza, ossia della
maggiore o minor coesione della loro grana. Il marmo crudo è molto
resistente alla lavorazione" ( e si mantiene nel tempo, per
secoli, anche all'esterno, soggetto agli agenti atmosferici ). Ma la
troppa durezza non sempre è un pregio ( freschezza ed eleganza
nell'intaglio ): se non è lavorato con la dovuta abilità può
schiantarsi in maniera non voluta, ma il peggio sono i contraccolpi
dei ferri, difficili da eliminare e che si vedono bene quando il
marmo è pulito o ancor meglio lucidato. Nulla toglie, al gradimento
di alcuni scultori, di scegliere un marmo duro e bianco-chiaro di 1^
qualità, per lavori di scultura e ornato, dove l'abilità
dell'artista si gioca tutto nell'uso virtuoso del ferro tagliente,
con approcci d'acchito e freschi ( non cincischiati ), ma che
conservano tutta la loro vivacità e bianchezza. Il marmo rimane
pesto (si chiamano squame) e se le pestature sono diverse l'effetto è
bruttissimo. "Il marmo debole o tenero ha il difetto di non
sopportare né spigoli vivi né rilievi isolati di qualche finezza
che, anche se fatti con maestria, non possono reggere a lungo(
soprattutto se alle intemperie ). Il marmo leggermente debole ma non
cotto, poiché questi si sfarina alla lavorazione, è il più
indicato per l'intaglio". Insomma, il marmista deve tener conto
della destinazione d'uso che sarà attribuita al prodotto finito. Da
qui, " anche della durezza il marmista deve tener ben
conto.....così sceglierà tra i duri quelli che devono sottostare a
sfregamenti continui (scale, pavimenti) e fra i teneri quelli per la
scultura, l'ornato, ecc. I marmi si distinguono in Teneri, Mezzani e
Duri, secondo il loro peso specifico". va' da se' che a maggior
peso specifico, per i Duri e Mezzani, corrisponde un maggior grado di
coesione. Ciò che fa' la differenza, in un'opera finita, è la
sostanziale freschezza del lavoro che deve esprimere di getto
l'originalità dell'idea, evitando troppi ripensamenti.
Tecniche.
Le
precedenti argomentazioni mantengono una loro validità sia che si
adotti una lavorazione con modello, utilizzando i compassi o il
pantografo, sia che si utilizzi un disegno, una stampa o una
fotografia. In tutti questi casi le misurazioni sono importanti e
vanno diversamente prese. Per queste ultime, le immagini su carta, va
predisposto un disegno sul marmo, in pianta (figura supina) e di
fianco nel profilo di tutta la figura. Naturalmente, in tutti i casi
occorre aver presente il concetto di piano: nell'iniziare il lavoro o
partenza, lo stesso scandaglio della figura che deve uscire dal
blocco scelto. Susseguentemente lavoriamo su dei piani, consideriamo
i solidi e i loro innumerevoli piani variamente posizionati, come
sull'esempio della vasca di Michelangelo e della visibilità del
modellino che in essa vi si immerge: adagiandovi detta figura, noi la
contrapponiamo al velo o pelo dell'acqua, a livello del suo
orizzonte, mentre gradualmente sommergono le membra supine; se
facciamo l'operazione contraria, noi osserviamo come pianamente, di
volta in volta, le varie membra o parti del corpo sporgono in fuori,
emergono, ora le ginocchia, poi le mani, la faccia e via via, a
seconda della loro distanza dal piano del dorso. Ognuna ha la sua
particolare sezione o posizionamento ( dipende dalla postura della
figura ). L'insistenza sull'atto tecnico del levare, nulla toglie
all'afflato del plasmare, che è padronanza della materia, piacere
che scorre nelle vene. Il tutto in tre versi famosi di Michelangelo:
Non ha l'ottimo artista alcun concetto c'un marmo solo in sé non
circoscriva col suo superchio. " Cosicché, le rime non di rado
tradiscono, nella mente dell'artista, la gravità del problema
esistenziale e le idee di Michelangelo su qualsiasi evento; ma la
novità consiste nel porre sullo stesso piano scultura e scrittura,
nella normale trasformazione dei costrutti e nella tessitura di un
nuovo intaglio. E con le rime e il disegno che le lega, si riflettono
le stesse idee su l'arte, sul bello, sull'aspra fatica del lavoro
artistico, l'insistenza dell'atto tecnico del levare ha più un
valore spirituale, unico, che va' ben al di la' dello scalpellare via
la pietra; ciò vale anche per la poesia: è indifferente se la penna
sostituisce lo scalpello, è la mano che genera la composizione,
purché non sia mediocre, secondo che 'l sa trar l'ingegno nostro.
Scomporre, trasformare, lo scoprire gradualmente elementi che
sembravano nascosti, il piacere di scovarli con i ferri in mano, per
far nascere dal nulla, nel marmo, quei piani o quelle parti che
compongono un tutto. E' il gusto di sfidare la pietra. Il gusto di
far emergere ciò che sporge o rientra: adiacenti o complementari,
siano figure o costruzioni, nel gioco dei volumi e degli scuri; in
movimento o in stasi. E si ricavano gli uni dagli altri in sequenze
conseguenti. Ricavare, è come ripulire una superficie ingombra di
materiale, denudarla piano piano, per conseguire il piano naturale
suo. Sentite il Vasari: "... Si piglino le misure da quelle del
modello, quanto sportano le gambe fora e così le braccia; e si va
spignendo la figura in dentro con queste misure, riportandole sul
marmo dal modello; di maniera che, misurando il marmo et il modello a
proporzione, viene a levare della pietra con li scarpelli".... e
la figura misurata esce dal sasso. Qui fa' l'esempio della vasca
d'acqua: se è si pigliassi una figura di cera o d'altra materia
dura, e si metessi a diacere in una conca d'acqua, la quale acqua
essendo per sua natura nella sua sommità piana e pari, alzando detta
figura a poco a poco del pari, così vengono a scoprirsi prima le
parti più elevate ed a nascondersi .. le parti più basse... Viene a
uscire: " ché prima verrebbe il corpo e la testa e le
ginocchia, et a poco a poco, scoprendosi.... si vedrebbe poi la
ritondità di quella fin passato il mezzo, e in ultimo la ritondità
dell'altra parte ".
Nel
San Matteo ( Michelangelo Galleria dell'Accademia Firenze ), che
sembra prigioniero del sasso dove è scolpito, visibile con chiarezza
l'opera incompiuta. IL NON FINITO michelangiolesco ha un significato
preciso: inizia il suo pessimismo ed una profonda riflessione sui
grandi valori della vita, della ragione, della fede; sulla
perfezione, irraggiungibile perché divina fra la purezza della
ragione e delle idee e lo squallore della vita. La sua fissa è che
lo sbozzato/smodellato lascia solo intravedere la scultura che sarà,
mentre si libera dalla materia: toglie alla statua la perfezione del
modello e l'immutabilità del significato, che è proprio dell'opera
finita, e l'incompiuto si apre ad infinite soluzioni. Emerge qui con
assoluta certezza un dato tecnico rilevante, l'unicità del punto
centrale: cioè si toglie il marmo parallelamente, per piani,
anteriormente e di fianco, scoprendo, di volta in volta, le parti più
sporgenti, lasciando emergere le parti basse ad esse complementari.
Così, nel San Matteo, il piano del ginocchio, che è quello più
alto, lascia intuire e porta alla luce gli altri piani: a sinistra,
si scopre quello della mano con il libro; mentre il profilo del
volto, reclinato a destra sulla spalla, segue il piano del braccio
disteso fino alla coscia; in mezzo, gli indumenti del torso e del
bacino, leggermente sollevati, sono allineati con la gamba di
appoggio ( ponderazione e chiasmo ). Con pochi colpi di gradina
emerge il particolare del viso, ben delineato e, nell'insieme, la
luce che scorre sulle superfici abbozzate, già traccia e lascia,
solo immaginare, come dovrà essere in futuro l'opera finita.
Nell'osservare
i due rilievi marmorei tondi, rappresentanti la Madonna col Bambino e
San Giovannino, Tondo Taddei (Royal Accademy Londra) e Tondo Pitti (
firenze, Bargello ), si avverte come il gioco dei piani di risulta
della figura principale siano complementari e raccordati. Pur nella
torsione diversamente orientata, i due busti esprimono, l'uno,
dolcezza ed armonia nella composizione, adeguando la propria
linearità dentro lo spazio dato; L'altro, esprime compattezza nelle
due figure principali e forza: la testa della Madonna fuoriesce dalla
costrizione oppressiva del bordo.
Nel
Tondo Taddei la gambe del San Giovannino sono collegate a quella del
Bambino, che a sua volta è disteso sulla Madonna e sull'ampio
movimento del suo braccio sinistro fino alla testa, accentuato dal
cordolo ( il bordo ). Infine, il braccio destro della madre ritorna a
collegarsi con la figura del San Giovannino, nell'alternarsi dei
volumi e degli scuri all'originale movimento rotatorio. Come faremo
noi, se volessimo scolpire lo stesso "Tondo" ? Inizieremo a
disegnare l'insieme dell'opera sulla faccia della formella in marmo,
e, con lo scalpello piccolo e tondo, vi tracceremo i primi contorni;
proseguiremo gradualmente con gli sbassi per ordine di rilevanza.
Continuiamo la seconda parte dell'abbozzo, con la ricerca dei volumi
e delle linee definitive, cominciando a fissare sempre più finemente
i particolari, solitamente nelle parti più alte; e si ritorna a
tracciare, in maniera definitiva i contorni delle figure e l'assetto
generale, fino a trovare il piano ultimo della formella (fondo).
Michelangelo è un virtuoso dello scalpello: è stupefacente come
arriva in maniera diretta a ridosso della figura, alla prima (non
gradualmente), togliendo la pietra soverchia: più questa scema più
la figura cresce e si realizza. E' sufficiente notare come con
ordinati colpi di subbietta, nel Tondo Pitti, in uno spessore
bassissimo, riesce a far emergere il San Giovannino che sembra
annegato nello sfondo marmoreo, dietro le spalle della Madonna: lo
scalpello disegna le figure, mentre gli sbassi a subbia e/o gradina
danno una plasticità mirabile al bassorilievo, dove all'interno del
bordo marmoreo si stagliano, elevandosi e rivelandosi alla luce,
buona parte dei corpi. E nella perfetta geometria della composizione,
ora sfumano ora emergono, panneggi e volti relativi a particolari
nascosti, che escono dall'ombra o rimangono appena accennati,
attendendo infinite possibilità di risoluzione. Sono gli effetti di
come l'artista approccia e definisce la composizione racchiusa in una
sua logica (idea), dove nulla è lasciato al caso. E' sufficiente
notare come riesce a stanare il braccio di Gesù dal fondo, ribadendo
la grande intuizione dell'abbozzato e su tutto ciò che è suggerito,
ma tutt'altro che definito.
STRUMENTI
DELLA LAVORAZIONE A MANO
Il
mazzuolo di ferro, con cui si battono, sulla testa i diversi
scarpelli; il mazzuolo di legno, più grosso di quello di ferro, ma
assai più leggero, che non da' perciò colpi tanto secchi sugli
strumenti, e quindi meno facili a produrre le squame che stanno tanto
male e diventano anche più appariscenti quando il lavoro deve essere
impomiciato, o tirato a lucido.
La
subbia, scalpello terminante a punta acciaiata, con cui si abbozzano
i marmi, e che a seconda della maggiore o minore acutezza della punta
prende il nome di fina, mezzana e grossa.
Il
dente di cane o calcagnolo, scalpello col taglio spartito in due (con
una tacca nel mezzo), che serve a togliere i tramezzi (tra le
rigature) lasciati dalla subbia. La gradina, col taglio a denti
acciaiati, che serve a gradinare o rendere fine le superfici del
marmo; la martellina che opera come la gradina e, con il lavoro di
martellatura, si hanno uguali superfici.
Lo
scalpello tagliente acciaiato diritto, con cui si tolgono le
scabrosità della gradina e si rende il marmo liscio; ma anche tondo
di diverse misure che serve per impastare, delineare, rifinire.
La
gorbia o sgorbia con tagliente semicircolare, simile allo scalpello
tondo, per incavare e scanalare.
L'ugnetto
scalpello lungo dal taglio spesso e stretto, quasi a punta, per
lavorare nelle parti profonde, il suo uguale è adoperato con il
martello pneumatico, non sostituisce pienamente la subbia nello
sgrossare, anche se, nel levare, aiuta molto. Moltissimi scultori lo
adoperano per disegnare parti della figura, segnandone il contorno,
fare incisioni profonde, eppure delicati ritocchi.
Il
raschietto, doppio scalpello con taglienti smussati e acciaiati, che
si usa senza mazzuolo, ma premendo fortemente con le mani, per
togliere dalla superficie le più piccole irregolarità rimastevi.
Le
lime e raspe, dritte o torte, piane o rotonde, che servono a pulire
la superficie.
TUTTI
QUESTI UTENSILI, tranne i mazzuoli e martelline, raschietti e raspe,
possono essere usati con il martello pneumatico.
I
PUNTONI NELLA SCULTURA.
I
"PUNTONI" in edilizia sono un elemento architettonico delle
capriate (le due travi inclinate ). Nella smodellatura il termine è
riferito a listelli più o meno alti, proporzionati, rispetto alla
grandezza del lavoro, sia nel marmo sia nel modello. Questa tecnica è
usata di solito per alti-bassi rilievi, o “stiacciàto”.
All'apice di ogni puntone è contenuto un capo-punto, da
trasportarsi, dal modello alla statua in marmo. I listelli si
innalzano, sopra il modellato di entrambi, nel rispetto delle
proporzioni, in scala, prefissate. In dialetto sono detti anche
"piri" . La parte in basso, opposta al capo-punto, è
attaccata al marmo e/o al modello ( più precisamente, alla
superficie dei loro modellati o sullo sfondo, a delineare piani di
riferimento che si ergono sopra entrambi ).
Dobbiamo
considerare anche la quantità di puntoni da installare: saranno
numerosi tanto quanto l'estensione del lavoro e dei campi utili alle
proiezioni; quindi non molti, ma sufficientemente adeguati ad un
sistema modulare per tempestare di punti la riproduzione, e più
questi saranno fedeli ed in sintonia tra loro, più la riproduzione
sarà soddisfatta e perfetta.
Il
listello, elemento rettilineo in marmo o in legno, può raffigurarsi,
dalla capocchia al piano, come una retta perpendicolare che lo
interseca: è il piede della piramide sulla quale è fissata la
bulletta, con il capo punto in posizione ottimale per proiettare, su
una porzione di piano, le misure necessarie. [Dobbiamo
avere l'accortezza
di collocare i puntoni, sia del modello, sia del marmo, in modo tale
che ciascun ordine si possa conformare ad una loro altezza data e
livellata. Nei fatti i due insiemi sono uniformati a costituire piani
paralleli superiori a piani sottostanti: questi materialmente
tagliano gli spessori del modellato; gli altri virtuali, aerei, sono
il livello dei puntoni (piano delle altezze), dove è agevole poter
sovrapporre un righello sui predisposti capi punto, e, da sotto, un
invito a concepire le cale, usando il compasso a punte rovesciate,
aperto in alto, sotto la riga e, in basso, sul modellato: diverso è
l'uso del compasso dai puntoni al piano (compasso con una sola punta
rovesciata)].
Disponendo le punte del compasso, una ferma sul suo punto di testa,
l'altra, secondo un'apertura prescelta, con la possibilità di
ruotare di 360° intorno al detto puntone, si può cogliere e
riportare, dal modello alla statua da eseguirsi, tutti quei punti
necessari e uniformemente proporzionali, soprattutto le "cale",
per una buona e fedele esecuzione. Le proiezioni dei puntoni si
possono raffigurare come una rotazione che ha forme piramidali:
immaginiamo di appoggiare una squadra al puntone (angolo possibile a
90°), avremo un cateto verticale, e l'altro a contatto con il piano
di lavoro ( del marmo o del modello ).
Se
pratichiamo virtualmente, con la squadra, le stesse rotazioni intorno
al puntone sperimentate con i compassi, avremo chiaro che le misure
da prendersi sono riferite a segmenti di obliqua, e cioè alle
distanze del capo punto dal modellato; migliori quelle rilevate nella
massima pendenza, date dall'ipotenusa (lato opposto all'angolo
retto). Perciò si dovrà contenere, la gittata del raggio entro
collocazioni non troppo distanti dal piede della piramide. Anche se
raramente sarà prefigurata una piramide regolare, con le proiettanti
più disparate imposte dalla distanza dei capi punto. Per cui nella
distribuzione dei puntoni, sul piano, si dovrà tener conto di una
regia che individua campi di azione praticabili. Queste intersezioni
indicheranno quel particolare intaglio da farsi che, mano a mano,
plasmerà tutte le espressività dei vari soggetti : nel geometrismo
della buona smodellatura abbiamo già i prodromi di una plasticità o
profondità spaziale; e, sommariamente, il manifestarsi di ogni
effetto plastico/pittorico che si intenda realizzare, coi volumi o
con le perforazioni. Trattandosi dell'intaglio di rilevi, il marmo,
more solito, deve poter contenere agevolmente il modello: “ lo
spessore” dalla lastra al massello ( da cm 2 a cm 8 ), ma anche di
maggior o minor spessore a seconda del lavoro da farsi: alto rilevo,
basso rilevo, schiacciato. ( Quando indichiamo le misure del marmo
dobbiamo aver presente questa rappresentazione: la dimensione
maggiore viene denominata lunghezza, quella intermedia larghezza; la
dimensione minore viene denominata spessore). Il punto di partenza è
sempre un piano perfetto, sia del modello sia della statua, piani che
formano lo stesso angolo con “l'orizzontale”.
1^
ipotesi:
Iniziamo
il lavoro prospettando di incidere, sulle coste dello spessore del
marmo – nel verso della larghezza e della lunghezza - le stesse
linee, a livello e in proporzione, rilevate dalla cornice del modello
(nel gesso o sul piano lastra). Tali segmenti sono i lati che
costituiscono il perimetro, ed è su di esso che concentriamo la
massima attenzione. IL problema è come costruire angoli uguali a
quelli del modello; oppure, viceversa, da quelli del marmo al
modello, se non è tagliato perfettamente e debbasi troppo penare a
rifilarlo. Procediamo: tra i lati che hanno gli angoli in comune si
mettono due punti equidistanti dal vertice di questi (ad es. una
misura intermedia che, fissata la partenza dal punto “1”, sul
lato AB, apre il compasso fino a lambire l'angolo). Da qui, con
l'identica apertura, operiamo il suo riporto nel lato consecutivo BC
il “2”). Di seguito, apriamo il compasso sui punti estremi “1 e
2” per registrare l'ampiezza dell'angolo del gesso. La medesima
operazione va eseguita nel marmo. La congruità di entrambi è legata
a poligoni equiangoli.
Le intersezioni vanno fatte su tutti e quattro gli angoli ad
iniziare, segnando sulla cornice del gesso e sulle coste del marmo, i
primi punti rilevati all'interno dei lati ABC (in AB il punto “1”,
il<3> nell'angolo, al vertice; ed il “2” BC nel lato
adiacente), al fine di praticare il pieno utilizzo dello spazio
perimetrale. Stiamo
conformando un piano che taglia, da sotto, i rilievi del modello, in
tutta la sua larghezza e lunghezza. Mentre sopra il perimetro del
marmo, nel suo spessore reale, ha sufficiente materia atta a
contenere la riproduzione stabilita (alto/basso rilievo o altro).
Apriamo i compassi dai capi punto intermedi “1e 2” ed il <3>
nell'angolo - passaggio nel triangolo di proporzione - per installare
il primo puntone all'interno dello spazio operativo (AC). La
collocazione del puntone è nel mezzo dell'ampiezza dell'angolo ,
ed il suo capo punto è trasportato dalla intersezione degli omologhi
“1” “2” e <3> cala. Fissato il primo, va studiato
l'inserimento degli altri puntoni: quanti e dove. Subito una prima
affermazione: definito il poligono equiangolo, sui lati del medesimo
è possibile riportare sui relativi perimetri, dal modello al marmo,
i punti che consideriamo utili. Una prima opportunità è data dai
capi punto intermedi, ad es.: il “2” e il suo opposto, per tutta
la larghezza, nell'altro lato del perimetro, il “2”bis. Questi
possono fungere anche da cale, perciò l'utilità di installare due
capi punto, con dei puntali di media altezza e minori dei “piri”
- che superino le varie parti emergenti del modello-, è una
possibile operazione da sfruttare. Li fissiamo sul piano
prospiciente, che è volto verso i capi punto dianzi detti, affinché
possano esercitare un controllo di conformità degli sbassi,
“nell'arte del levare”. Al meglio, vengono utilizzati per
facilitare i compassi a prendere le misure lunghe, lasciando ai
puntoni quasi tutto l'onere delle cale. Il loro ruolo fondamentale è
favorire le intersezioni dai e sui puntoni; così come i vari punti
segnati sul piano, e tutti quelli che possiamo disporre, liberamente,
sul perimetro, hanno funzioni polivalenti. I puntoni, i puntali e
tutte le bullette vanno forati in testa, incuneandoli e cementandoli,
con il mastice o con il gesso, negli insediamenti predisposti nel
modello e nel marmo.
PUNTONI
ALTRE TECNICHE ipotesi secondaria, per lavori di media grandezza.
Illustriamo,
per maggior praticità, altre due tecniche. Diciamo che un rilievo è
ciò che si stacca dallo sfondo, che è la parte prospettica più
lontana dalle figure di primo piano. Abbiamo già accennato alla
diversificazione dei vari spessori ( alto/basso rilievi ), perciò se
teniamo conto delle loro grandezze e forma, possiamo sperimentare
anche altre tecniche, e relative partenze. La seguente è molto
simile a quella dianzi descritta, sfrutta lo spazio del piano libero,
quello tra il modellato e, intorno, nella cornice, per potervi
inserire alcuni capi punto, in modo da governare tutta la superficie.
La tecnica che illustreremo differisce, dalla precedente, solo nella
scelta del piano di partenza, simulando la proiezione di un piano su
tre punti sul MODELLO. Piano che deve superare l'altezza dei
rilievi, cioè si staglia sopra la composizione come se fosse un
tetto immaginario. Per formarlo sono utili i canonici tre capi punto,
1-2-3, per la formazione di un piano, sia nel modello che nel blocco.
Nel modello si predispongono come solitamente avviene nelle figure
adagiate: in basso i due capi punto (1-2), in alto il “3”.
Questi, si fissano con chiodi o “bodete”, in modo da sovrastare,
coi capi punto, lo spessore del modellato. Nel marmo tagliato o
spianato adeguatamente, riportandoli dal modello, in scala, i capi
punto sono ospitati nei fori fatti col “punteruolo”. I piani sia
del modello sia del marmo dovranno essere livellati e traguardati
per avere la stessa angolazione con la linea di terra. Il volume del
marmo conterrà sia la tavola del gesso che le parti in rilievo.
Perciò sotto questo piano, nonostante l'espressione di esiguità, vi
è pur sempre una tridimensionalità da rispettare: comprendente sia
lo sfondo che il modellato e lo spessore della tavola. Ne va
trascurata la cornice, i cui angoli vanno riprodotti fedelmente nella
loro ampiezza; mentre i relativi perimetri avranno i lati
uniformemente proporzionali. Su questi verranno segnati, tutti i capi
punto di servizio necessari e fondamentali per il riporto delle cale,
e delle lunghe. Iniziamo dal piano che ospita i capi punto 1 e 2, del
modello: traslati nello spessore sottostante, con la stessa aperture
del compasso - al limite, a risicare lo spigolo di base-, vanno a
segnare l'ultimo segmento utile, praticabile, nella cornice del
gesso. La stessa operazione va fatta nella costa del marmo, con
maggior facilità. Il massello, ha una migliore agibilità nel
contenere tutto il gesso. I segmenti dei punti “1 e 2” saranno
traquardati con la livella, e prolungati fino agli spigoli dei
vertici del particolare poliedro, come nel piano soprastante. IL
punto “3” è soggetto allo stesso prolungamento, e il suo
segmento sarà predisposto secondo “l'orizzontale” stabilito
dalla livella. Tutti i lati, (adiacenti, opposti e consecutivi,
assumono la stessa direzione datagli dalla comune ampiezza, obbligati
ad incontrarsi. [Nota:
i punti “1 e 2” , oltre alla loro proiezione ortogonale,
confermano la loro posizione, anche incrociando le distanze dei punti
- “1 e 2” - dagli angoli].
Dopodiché
dal piano i capi punto 1-2-3 si possono incrociare le misure in tutte
le direzioni, in alto e lateralmente. È tempo di insediare i puntoni
e programmare le campate utili al lavoro preparatorio della
smodellatura. Dai capi punto nel piano, dal perimetro e dagli
spigoli, si incrociano le lunghe e le cale per mettere i primi
puntoni e, da questi, i primi capi punto nei rilievi.
IL
PLINTO ANGOLI CARTESIANI.
Il
plinto nell'architettura è un basamento a pianta quadrata,
figuriamolo anche come un poligono rettangolo; è il nostro massello.
Ne rammento l'immagine, per proporre una particolare idea, quella che
raffigura lo schema degli assi assonometrici, con le intersezioni dei
tre piani di riferimento, che servono a definire le tre dimensioni
spaziali: larghezza, profondità, altezza. Applichiamo, anzi
ricopiamo, questo sistema di misurazione sugli assi utilizzando gli
angoli e gli spigoli del nostro massello ( quelli di base e quelli
laterali ). Sui tre spigoli uscenti da uno stesso vertice
identifichiamo gli assi, quello laterale, perpendicolare ai due
della base ( larghezza e altezza ). Sono le dimensioni del
parallelepipedo rettangolo, aventi origine in un angolo della base,
dove si intersecano. È il nostro blocco, un poliedro che ha lati ed
angoli comuni, perciò al vertice di questi possono essere
determinati tre assi coordinati ( intersezione di tre piani di
riferimento) utili alle nostre particolari misurazioni. Lo schema è
assunto come pretesto e solo per la comprensione della tecnica che si
intende adottare. Per questo dobbiamo prospettare le dimensioni del
particolare poliedro: le sue facce sono i poligoni; mentre i lati ed
i vertici sono, rispettivamente, gli spigoli ed i vertici del
poliedro; dai quali le tre dimensioni assonometriche: per valutare
una parte della larghezza, una maggiore data dalla lunghezza ed
infine mettere un punto ( misura ) nell'altezza reale dello spessore,
che è lo spigolo laterale (perpendicolare), al confine tra il
modellato ed il piano che lo contiene. Questo confine, parallelo ai
lati di base (spigoli ), sarà tracciato sugli assi cartesiani, per
inserire più facilmente i capi punto, su un perimetro che è a
delimitare le facce laterali; sempreché modello e marmo siano dianzi
predisposti. Si procede riportando dal modello un misura sulla
larghezza ed una sulla lunghezza, convenientemente calcolate come
capi punto di servizio. Si riparte dall'altezza, riportando un'altra
misura dal modello: è l'altezza del rilievo - lo spigolo che
delimita, in contiguità con altri, il fondo del modello e la tavola
del gesso. Sullo spigolo va conficcata una bulletta ( chiodo a testa
larga ) al limite con l'elaborato. Abbiamo insediato un'ottima cala,
che ci consente di costruire, sul modello, il primo dei puntoni
indispensabili alla smodellatura. La cui altezza corrisponde
all'estensione dei campi di proiezione. Uguale altezza avranno gli
altri puntoni, in modo da coprire il piano di lavoro. A seconda di
come emergono le composizioni, possono essere inserite, in campi
strategici, asticelle metalliche (chiodi), per meglio punteggiare e
controllare il modellato. Abbiamo dato per scontata la perfezione,
massima, del modello che di solito è in gesso. Se lo è come i tagli
del nostro spessore predisposto, tanto di guadagnato. Altrimenti,
nell'impossibilità di aggiustamenti si cambia tecnica.
Comunque,
tutte le composizioni in rilievo hanno un fondo dal quale emergono. È
sui bordi della lastra in gesso, al vertice degli angoli, che è
possibile inserire i capi punto. Se non lo hanno, un piano lastra ben
perimetrato e spessorato, lo possiamo sempre predisporre.
Sperimentato
questo sistema non è detto che non si possa applicare ad un blocco
per delle statue. Il piedistallo a base rettangolare o quadrangolare
si presta moltissimo a questa operazione, se abbiamo l'avvertenza di
utilizzare il piano lastra del gesso per disegnarvi la dimensione
della lunghezza e della larghezza della figura, poiché per
l'altezza, lo spessore, è pensabile che si possa utilizzare la base
del modello, che normalmente contiene la figura. Non cambia nulla se
alcune sue parti svettano più in alto del piano del piedistallo. Il
marmo, naturalmente, dovrà essere segato corettamente ed assumere la
forma di un parallelepipedo rettangolo.
CONTEMPLARE
IL LAVORO, GUARDARE NON è SUFFICIENTE
Ogni
lavoro da farsi manifesta una propria originalità, non presenta, in
tutto e per tutto, le stesse identiche soluzioni. Stiamo esaminando
un qualsiasi rilievo, in gesso, e la sua possibile riproduzione con i
puntoni. Può presentarsi come una “crosta” (lastra in marmo poco
e male segata), e non perfettamente perimetrata e squadrata. Oppure
un perfetto modello, i più, riprodotto a regola d'arte, con un fondo
perfettamente stampato e incorniciato regolarmente. Nel primo caso se
le sue dimensioni sono modeste lo si dovrebbe fissarlo su un piano
lastra come si usa con molti altri modelli.
Il
secondo caso è disponibile, per la sua regolare geometria ad essere
usato con più risorse tecniche in maniera polivalente.
Iniziamo
con il modello imperfetto: se è sovrapponibile su un piano lastra,
è agevole porlo all'interno di un perimetro regolare (rettangolo).
Altrimenti occorre sfruttare gli angoli, insediando abilmente al loro
vertice dei capi punto, con bullette, in modo da formare un poligono
regolare e poterlo riportare , debitamente proporzionato, sul marmo;
o in scala 1:1 se è dal “vero”.
Nel
caso di una produzione maggiore o minore del modello, si usa il
triangolo di proporzione, cominciando a disegnare, fissandoli,
perimetri simili. Abbiamo descritto alcune tecniche, altre
precisazioni seguiranno.
Precisazioni
sui PUNTONI.
Le
triangolazioni debbono essere strategiche funzionali alle zone
dominate dai puntoni, per aumentarne l'efficacia delle misure, sia
delle lunghe sia delle cale e la loro precisione ( è giusto
sfruttare le coste del marmo e del modello, ed anche le sporgenze del
modellato ). Poi è consigliabile insediare dei capi-punto, sempre
sul piano, alcuni prossimi ai lati del lavoro, per effettuare
agevoli triangolazioni, e semplificare il riporto delle misure
lunghe, lasciando ai puntoni solo il compito delle cale. Soprattutto
se il lavoro è di notevoli dimensioni, insediare capi-punto di
servizio, che interfacciano con quelli dei puntoni, è una logistica
che semplifica il lavoro. L'altezza del puntone, dall'intersezione
con il piano ad angolo retto, può avere una distanza variabile, per
cui le misure proiettive dal capo-punto al piano possono essere più
lontane o più vicine. L'operazione effettuata con il compasso misura
l'ipotenusa, di un virtuale triangolo rettangolo, del quale un cateto
giace sul piano e l'altro si identifica con la verticalità del
listello/puntone. E' facile prevedere ( v. Teorema di Pitagora ) che,
aumentando le misure dei cateti, si aumenta contemporaneamente anche
l'ipotenusa. Nella sua semplicità questa considerazione ci porta ad
indicare il seguente accorgimento: le altezze dei puntoni vanno
previste già sul modello, scandagliando bene le zone di dominio e il
loro limite ( orizzonte proiettivo ), per adottare misure più
esatte. Va' da se che quando queste sono più vicine al piede del
listello la loro misura è più garantita. Ne consegue che la gittata
del compasso privilegia la linea più breve che unisce fra loro due
punti dati. Per questo motivo, trattasi di individuare il ragionevole
limite di campi o zone di ogni puntone per operare in sicurezza.
E'
opportuno chiarire cosa si intende per LEGAME DELLE TRIANGOLAZIONI
NELLA SMODELLATURA, adottiamo una logica riadattata alla nostra
tecnica: " operazione topografica (mappare: figurare un luogo
nelle tre dimensioni prospettiche). Abbiamo preso in prestito questa
definizione, con lo scopo di chiarire il nostro intento: individuare,
sul piano diverse posizioni date nel modellato, legandole a quelle di
numerosi punti ben collegati tra loro. Questo sul piano, ma noi siamo
interessati a trovare un punto nello spazio, cioè un piano, come se
dovessimo individuare, tutte le volte, il vertice di una piramide, a
base triangolare. Per questo motivo il lavoro preparatorio dei
capi-punto va fatto a regola d'arte, partendo sempre da un piano di
riferimento.
Nello
smodellare con i puntoni, indicare il vertice di una piramide può
trarre in inganno, poiché le cale sono a spingere ( e qualche volta
anche le lunghe ); dobbiamo considerare, come in questo caso trattasi
di trovare una piramide in posizione rovesciata ( misure a spingere,
dall'alto in basso come nell'operare su un oggetto concavo ). Mentre
negli altri casi, i più comuni, sono a stringere verso il basso: il
termine è sempre riferito al togliere roba cioè marmo per arrivare
alla misura del punto da riportare.
PRECISAZIONI
L'esempio
sopra citato, riferito ad una immaginaria rotazione delle squadre
intorno al puntone, è stato fatto anche per mettere in risalto
un'altra configurazione: " per trovare ogni nuovo punto sul
marmo bisogna riferirsi almeno a tre altri punti analoghi già
preventivamente stabiliti sul modello non disposti su una stessa
linea: insomma, precisamente come si farebbe per determinare p. es.:
il vertice di una piramide solida da costruirsi, mettiamo a base
triangolare, e che dovesse risultar simile ad un'altra piramide data
ed egualmente disposta", quella del modello. Ritorniamo su
questa non sintetica regola, in maniera ortodossa, per sottolineare
come, con le misure prese dai e sui puntoni, si può dare l'idea di
un interazione che, con i movimenti dei compassi, consente di
ottenere una percezione immediata delle intersezioni medesime, e come
ogni punto corrisponde ad un piano trovato nello spazio. Qui, è il
capo-punto al vertice del puntone. Difatti, la stessa postura dei
puntoni, installati inizialmente dai tre capi-punto di partenza
(1-2-3), spesso con l'ausilio di ( 4-5 ), rendono bene l'immagine di
una piramide a base triangolare, e come le misure identificate negli
spigoli laterali della stessa (linee di obliqua), possono ben
rappresentare le misure che partono ed arrivano ai capi-punto dei
puntoni. Impariamo dal mestiere e dal ragionamento nostro, come e fin
dove, nel riporto dei punti, ci è consentito spingere l'apertura dei
compassi e l'incrocio degli archi: tracciamo le intersezioni angolari
vicino a 90°. Evitare che i tre capi punto siano troppo allineati,
poiché non “tirano”, non sono più precisi. Abbiamo così
definito il concetto di campo ragionevolmente utile, la cui
estensione è più provata dall'esperienza che da un imposto limite
teorico.
Diversa
e complementare funzione è quella che assume il concetto di
modulare: “ formato da elementi uguali o standardizzati, aventi
dimensione multiple o in proporzione tra loro”. Impropriamente e
spesso, ci riferiamo ad un altro semplice concetto: " non esiste
una forma complessa che non possa essere ridotta a un'altra più
semplice ". Un gruppo di persone può assumere una forma
trapezoidale, oppure come La Pietà del Michelangelo quella
piramidale; un mazzo di fiori la conica, e così via. Cosicché nei
nostri campi o zone di lavoro si propone l'intaglio con quella
schematizzazione delle forme e semplificazione che, nella scultura,
prende il nome di sbozzatura, ed è una prima assestata al marmo con
il riporto dei punti principali. Poi, lo smodellatore scopre e
definisce sempre di più, nel prosieguo, le forme nei dettagli.
CHIARIMENTI
Alcune
osservazioni utili.
Recenti
pubblicazioni sostituiscono arbitrariamente, scambiandole, il
trasporto delle misure effettuate per mezzo dei compassi, con quelle
del pantografo o come esclusiva del triangolo di proporzione; e,
riferite a quest'ultimo, dichiarano: “ che permette di considerare
di volta in volta tre angoli o tre punti come i termini necessari per
individuare il vertice di una piramide”. Ma non è così ! Il
triangolo di proporzione “ permette “, esclusivamente, di
riprodurre nella scala voluta il modello, operando poi, con il
sistema delle triangolazioni e delle intersezioni. Il pantografo
invece è utilizzato dallo smodellatore, per il trasporto dei punti
dal modello al marmo e quando debba effettuarsi una statua di uguali
dimensioni al modello, “ a ritratto “ o in scala da 1:1.
Diversamente, come già osservato, è il metodo dei compassi, sia
negli ingrandimenti sia nelle riduzioni, che prefigura per il
trasporto di ogni punto, la piramide. La tecnica è completamente
diversa dal pantografo. Pur lavorando sulle stesse figure geometriche
solide, solo con i compassi, lo smodellatore, osserva la regola delle
tre misure ( lunga, profondità e cala ) per individuare un piano (
un punto ) nello spazio, anche nel caso di un medesimo lavoro a
ritratto. Nell'opera di smodellatura sono migliaia i punti necessari
ad una buona riproduzione; è qui che, per ogni punto, si determina,
prefigurandola, il vertice di una piramide a base triangolare. Lo
scolpire è un concepire, individuandoli e metabolizzandoli, piani
nello spazio.
Diversa
è la copiatura di un disegno sul foglio, rappresentando, per mezzo
delle intersezioni, delle figure geometriche piane, le cui linee e
punti sono contenuti sullo stesso piano. Rammentiamo alcuni
presupposti: a) per due punti passa una sola retta e da essa infiniti
piani ; e per tre punti, non allineati, un solo piano. Proviamo ad
immaginare una porta o sportello girevole i cui cardini coincidono
con i due punti di una retta: il loro movimento è di 360°, in
qualsiasi piano di proiezione verticale/orizzontale e obliqua, come
individuiamo una loro posizione ( grado di apertura ) presente in una
stanza, se non abbiamo una terza misura di riferimento? Lo
smodellatore, con l'ausilio dello sbozzatore, scandaglia il blocco,
mettendo i primi punti guida ( capi-punto ), riportandoli dal
modello, in maniera che possa realizzarsi la statua nelle volute
dimensioni. Vi è sempre, nella partenza, un piano di riferimento,
ottenuto con tre punti non allineati: due alla base, uno in cima alla
testa della statua (argomento ampiamente trattato nelle tecniche di
lavorazione ). Vediamo come si opera con il pantografo. Immaginiamo
il blocco come se fosse un contenitore: una stanza è un esempio
maggiorato del nostro parallelepipedo, c'è il piano del pavimento ed
il soffitto, oltre le pareti; così, in maniera più appropriata e
ridotta , una vasca da bagno lo è, se pensiamo ad un corpo che vi si
immerge totalmente e sopra di esso si chiude il velo o il piano
dell'acqua, come se fosse un tetto. Poiché nella riproduzione, il
marmo deve poter contenere completamente la figura, si inizia
individuando i piani del modello e del marmo, che sono il detto velo
dell'acqua, in modo che i tre punti di ciascuno lo rappresentino e
formino, con la linea o piano dell'orizzonte, lo stesso angolo
visuale ( a livello ). Si comprende facilmente che la nostra partenza
utilizza il piano in alto del blocco per contenere tutte le forme
della figura sottostante. I tre capi-punto non allineati, che
indicano il piano, sono posti alla superficie, due alla base ed uno
in cima alla testa della statua e del modello. Sopra di essi,
adeguatamente combacianti, sono i tre puntali posti all'estremità
della croce, che sono la base portante, e piano virtuale, di tutto
l'apparecchio ( detto pantografo o macchinetta). Le misure si
prendono trasportandole dal modello al marmo, muovendo in blocco
tutto lo strumento: dopo aver fissato - tramite un morsetto, al
regolo verticale della croce, sempre all'altezza voluta - un altro
regolo, alla cui estremità è innestata un'asta di ottone, che può
muoversi sia in senso verticale che in senso orizzontale e sorreggere
un braccio di ottone manovrabile in tutte le direzioni. Il braccio
comprende una punta di acciaio scorrevole, che viene fermata quando
tocca un preciso punto del modello, così si ricavano tutte le misure
desiderate.
Inizia
così lo scandaglio col fissare i punti principali, ricavando le
larghezze, le altezze e le parti basse; poi lo smodellatore, lo
scultore e tutte le altre figure proseguono l'opera. Talvolta è
necessario abbassare i tre capi-punto del marmo, se quelli del
modello – cioè il piano da loro prefigurato – lasciano sporgere
fuori ( al di sopra ) gambe, braccia o altre parti della statua.
L'intaglio e l'arte del levare è possibile quando c'è materiale, in
dialetto “ roba”, per scolpire le parti esistenti nel modello.
Ricordiamoci della vasca d'acqua, se un parte anatomica sporge fuori,
è anche fuori dal blocco. Significa che ci siamo “mangiati” il
lavoro.
SBIANCARE
IL MARMO:
(1)
Per renderlo nuovamente bianco creare un composto di 1 bicchiere
d’acqua – 1 bicchiere di succo di limone – 1 cucchiaio di
bicarbonato. Applicare sul marmo e con una spazzola a setole rigide
(non di ferro), strofinare con cura, sciacquare con cura ogni
gradino, prima di passare allo scalino successivo.
(2)Una
volta finito, mettere del bicarbonato sui gradini di Marmo e bagnare
(non in modo abbondante), così da fare una sorta di poltiglia,
spalmarlo con uno straccio sui gradini e lascia agire per circa 15-20
minuti (il bicarbonato pulirà la porosità del marmo)
successivamente sciacquare con cura e asciugare con uno straccio,
possibilmente di lana.
Essendo
un Marmo esterno, è consigliato ripetere la procedura del
Bicarbonato (punto 2) almeno due volte al mese, così da tenere
pulite le porosità del marmo, che sono le più difficili da pulire
con una sola passata di straccio imbevuto in acqua e sapone di
Marsiglia (utilizzare questa pulizia nelle settimane alterne a quella
del Bicarbonato).Altri rimedi da provare per la Pulizia del Marmo:
Rimedio1:
Pulizia generale marmo - l’acqua migliore per pulire il marmo è
l’acqua distillata, con dell’aggiunta di sapone di Marsiglia. E’
consigliato non usare né l’aceto, né dei detergenti, considerando
il loro contenuto “acido” che potrebbero rovinare i marmi, se non
fossero puliti immediatamente.
Rimedi
2: Il marmo bianco - Preparare una soluzione di 1/2 tazza di
perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e tre cucchiai di succo di
un limone. Applicate su tutta la superficie del marmo con una spugna
umida. Lasciate agire per qualche ora e successivamente lavate il
marmo con acqua e asciugate con un panno di cotone. Infine, applicate
un velo di cera. Rimedio 3:Macchie sul marmo - Per rimuovere le
macchie, imbevete uno straccio con del perossido di idrogeno (acqua
ossigenata al 3 per cento) strofinate con cura le macchie e lasciate
riposare per un paio d’ore e poi risciacquate con un panno umido.
SCULTURA
1.
Precisazioni
Una
illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico
e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, è
l'uso rigido del robot, l'apparecchio automatico programmabile che
con il suo cincischiare lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla
meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato,
artisticamente non utile, perché mortificante, accettabile solo per
taluni lavori standard e al cospetto di uno scarso valore aggiunto,
che, in seguito, la manualità dovrà ripristinare. Questo è il
debito sovrano, sia nei confronti della bellezza artistica di
un'opera, sia nei confronti di una perfetta esecuzione di tutto ciò
che si vuol rappresentare. E ci fermiamo qui, non andiamo oltre:
nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un
sentimento. Con il robot, siamo dentro o abbiamo superato l'antico
conflitto tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e
l'intellettuale che creava? Ci riferiamo ad un servizio
meccanico, dato a coloro le cui idee, spesso, taluno rappresenta, in
modo sbrigativo e superficialmente, in creta o con altri materiali.
Oggi gli sarebbe sufficiente un disegno o una compagine di vario
genere, per aumentarne lo spaccio. Dietro questa tendenza si
nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a
snaturarne le qualità del comunicare della cosa o qualcosa. Si è
lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della
materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la
sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando
il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si
miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il
mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in
questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere
artefice e realizzare le proprie opere. La tecnica non è mai
ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire;
non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente
quella cosa e non, occasionalmente, altro. È come la percezione
anch'essa legata all'esperienza, e fissata nella nostra mente
mediante alcuni percorsi psicologici che li unisce e li mutua, mano a
mano, mediante il gioco di umori, e del sentire che cancellano o
richiamano alla memoria immagini ed oggetti completandoli, secondo il
sapere di ognuno. Tutto ciò è influente nei confronti del contesto
e del linguaggio usato, e non è indifferente sull'utilizzo della
materia e dei ferri ( utensili ) adoperati. Non sono la stessa cosa
una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un
altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la
bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi
particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici
ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed
irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere
mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare
l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva
un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in
pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore.
E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di
linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste
ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di
valenti artisti. Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i
procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i
segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria
valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e
senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai
di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie
differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire
ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia,
gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro,
c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure
anonime tal quali a dei manichini.
2.
Precisazioni
ANGOLO
E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.
Nell'utilizzo
del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto
fedele, può lasciare diversi margini di imprecisione, soprattutto
se non si opera, come si deve, nell'inizio del lavoro e nei passaggi
dal modello alla statua da eseguirsi, oppure quando vi è una
scarsa manualità. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente
con la pratica e la padronanza del mestiere.
Con
più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure
contenute sullo stesso piano, utilizziamo meglio l'angolo riduttore (
o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando
le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al
contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con
infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e
confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita
le misure date.
Va
da sé che nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e
impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da
trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una
costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per
rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre
intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una
piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di
riferimento. Alla fin fine, per i praticanti consigliamo,
nell'utilizzo del triangolo di proporzioni, l'operazione che prevede
una diversa soluzione del problema geometrico: e cioè l'utilizzo del
triangolo isoscele in sostituzione di quello rettangolo. Sostituiamo
questa riproduzione, che prevede il riporto delle misure con l'arco
di cerchio tangente, ricorrendo al più facile doppio passo previsto
nel primo. Come già illustrato nel primo dei precedenti esempi
esecutivi.
Ritorniamo
a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e
modello, verificando alcune ipotesi.
CONGRUITA'
TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO: RAPPORTI DI SIMILITUDINE.
Trattandosi
di triangoli simili, non avendo la stessa estensione, le restanti
corrispondenze sono totali: proporzione tra tutti i lati e congruità
per gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una
statua di cm 615 e di un modello di cm 120:
1°).
E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e
circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con
misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il
superfluo. [tipico
dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per
lui il valore di un atto spirituale; è la sublimazione dell'idea che
lo precede].
Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire
i capi-punto maestri, il voler restar fedeli all'idea ed al senso
della sua ispirazione. Risolviamo una prima difficoltà: una statua
di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari
grandezza? No. I compassi e il “maranghino” sono più
maneggevoli e precisi su misure ridotte; pure convenienti anche sul
triangolo di proporzione. Vediamo, di seguito, al punto 2°). La
congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da
trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale
a quello iniziale tra le altezze di statua e modello, e cioè tra i
rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo
questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del
triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120,
avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa
operazione sembra essere il limite di cm 40, che corrisponde alla
riduzione del modello reale di cm 120. Come operiamo con l'arco
tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori
70, 80 cm, rispetto a quella ridotta? La soluzione è nel
prolungamento delle semirette AB e AC oltre il triangolo, nella quale
permane basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati, che
nel rapporto – 205: 40 – mantengono lo stesso quoziente di cm
5,125. Come si vede prolungando il lati ( semirette ), cambia solo il
disegno, infatti se 205 : 40, nel rapporto mantiene lo stesso
quoziente di cm 5,125, la misura extra scelta aumenterà in
proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e
corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB = 80 X
5,125). Quindi è verificata - a mo' di esempio - anche la
possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il
principio della similitudine: i lati corrispondenti sono in
proporzione e gli angoli corrispondenti sono congruenti. ( Se
disegniamo, nel Teorema di Talete, il prolungamento delle due
trasversali, che tagliano il fascio di rette parallele, la figura
diventa un triangolo, formato da due semirette che hanno un punto in
comune: cosicché tutti i segmenti ottenuti sono in relazione di
proporzionalità diretta, formano dei triangoli e mantengono la
loro congruità all'infinito ). La riduzione di un terzo del
triangolo, dianzi posta, può essere utile in prosieguo: quando –
sempre nel nostro esempio - le zone della produzione scultoria
saranno divise in porzione di spazi (almeno tre ) e si potrà
lavorare più agevolmente con piccoli compassi ed un triangolo
ridotto, poiché riprodurre statue colossali, da modelli modesti, è
un'impresa rischiosa, ove ogni minuscola differenza potrebbe produrre
enormi guasti al lavoro. In questo caso si ricorre all'impiego di
altre tecniche, se non si ha la possibilita di ingrandire il
modellino a dimensioni ragionevoli.
Più
semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella
precedentemente esposta si è voluto ribadire il teorema
fondamentale. Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta
di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo,
lasciamo invariata quella del modello, di cm 120, che nella sua
integrità consente la totalità dei riporti. Ne consegue una
parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è
ripristinabile all'intero: a) semplicemente moltiplicando ogni misura
ottenuta con quoziente delle altezze, statua cm 615 : 120 = 5,125
valore proporzionale. Cosicché ogni misura presa sul modello dovrà
essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es.
una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm.
415,125 ); b) prendiamo la stessa misura dal modello, cm 81, che,
trasportata, con l'arco tangente, sul triangolo dato, sarà uguale a
cm.138,375; questa dovrà poi essere moltiplicata per 3, se
correttamente completiamo l'operazione, ripristinando la riduzione
precedente effettuata. Quindi 138,375X3 ci darà, esattamente, cm
415,125, che è la misura da riportarsi sulla statua. Nella fase
iniziale dello sbozzo, la riduzione su esposta su una sola delle
altezze, conviene alla praticità e maneggevolezza nel riporto delle
misure con i compassi, dovuta alla loro minor apertura. In seguito,
le campiture saranno notevolmente ridotte.
DAL
RETTANGOLO AL TRIANGOLO ISOSCELE.
Un
metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco
tangente, continuando ad operare col compasso, è quello del
procedimento sul triangolo ISOSCELE:
3°.
Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché, non sia,
maggiore o uguale al doppio del modello ( ≥
) : con
apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo, facendo centro
in A e B – la grandezza della statua - si descrivono due archi che,
intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui
lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura
del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo
sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso
si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza
NA sarà quella da portarsi sul marmo.
Abbiamo
ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni
lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore
da seguire. E questa dianzi indicata è una tecnica facile e precisa.
Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le
dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di
ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo
isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica
che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala,
maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo
isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o
di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello
si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della
statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su
AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per
sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.
Un
altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima
alla scala Ticonica ( scala metrica attribuita a Tycho Brahe ). Si
prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza
della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello,
dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali, a partire
dall'origine 0 verso destra, ognuna delle quali corrisponde all'unità
grafica nel rapporto voluto. Poniamo che il loro divisore sia 30,
avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da
riportarsi sul blocco; mentre su un prolungamento, a sinistra,
suddividendo una di questa unità ancora per 10 otterremo dei
sottomultipli, che sono misure infinitesimali: 4 millimetri
rappresentano cm. 2,5.
Il
rapporto grafico è costante – cm 615: 120 = 5,125; cm 20,5 : 4 =
5,125; così per tutte le altre misure. Praticamente abbiamo diviso
le altezze del modello ( cm. 120 : 30 ) e della statua ( cm. 615: 30
), in tante unità grafiche nel rapporto voluto, poi abbiamo
suddiviso i loro segmenti estremi (delle due righe) in sottomultipli
( di regola 10 parti ). Le suddivisioni riportate, Trenta per i
multipli, sono i segmenti del rapporto suddetto; mentre le
suddivisioni per dieci rappresentano i sottomultipli dei rispettivi
segmenti ( nell'ordine di 30 e poi 10 = 300 ). Insomma è consentito
dividere entrambe le altezze in parti uguali, segnandole su due righe
diverse, mentre per praticità è consigliabile evitare aste
gigantesche, non sempre utili, almeno nel prosieguo, una volta
esperite le misure maggiori. È possibile ridurle mantenendo le
corrispondenti unità di misura ed il loro rapporto. Riepiloghiamo:
Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del
compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola
eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410
( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello
corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può
essere di 4, 5, o più millimetri, non ci resta che rapportarli alla
proporzione stabilita ( es. mm. 4 = 2,05 cm.). Questa suddivisione
dei segmenti (sottomultipli del modello e della statua) in dieci
parti uguali, precisano e determinano le unità di misura
corrispondenti. Normalmente queste operazioni, oggi superate,
facilitavano il lavoro iniziale; poi si procedeva con compassi più
piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della
scultura e con capi-punto posti strategicamente. Aggiornandoci, per
le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di
operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche
nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria. I
capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a
termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da
essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto
che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le
squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le
possiamo riportare, e senza l'ausilio delle squadre (desideriamo
strafare). Il procedimento è semplice, come condurre una
perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di
cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del
modello. Operiamo come segue: Su A B portare l'altezza della statua;
centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e
descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in
B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura,
che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una
intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa
apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo
punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C.
Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data
una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C
desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati del triangolo.
MORTAIO
UNA PRODUZIONE SCULTORIA
DELLE
ALPI APUANE
ESTETICA
E LINGUAGGIO VISUALE
Mortificante
considerarla produzione umile ed utilitaria.
La
lavorazione dei mortai, spesso considerata di scarsa professionalità
comportava, al contrario, particolari doti tecniche ed una buona
specializzazione. Almeno nei suoi impieghi artigianale/industriale, -
al di là dei singoli spartani che incrementavano la loro busta paga
con un “gobet”, - vedevano Carrara al centro delle maggiori
produzioni e spedizioni, comprendendo tra i lavori speciali di marmo
anche le tinozze da bagno. Certamente, il suo utilizzo si collocava,
nell'ambito della cucina e della farmaceutica, ma ciò non poteva
giustificare una produzione così massiccia, con misure e regole
particolarissime. Dalla seconda metà dell'Ottocento, via via
scemando fino alla scarsa produzione odierna, si assiste ad un suo
utilizzo in architettura, nel designer, in particolari decorazioni di
facciate, pavimenti e rivestimenti. A parte la particolare bellezza
in sé, dovuta alla sua originale fattura, il mortaio, offre notevoli
possibilità decorative: in una facciata ponendoli uno vicino
all'altro, si possono comporre, ad incastro, varie figure
geometriche, linee e forme che si alternano, in un gioco di pieni e
vuoti ( composizioni modulari) ; ma anche contrasto di colori, se si
riempiono i mortai con un impasto di materiali pigmentati o disposti
a mosaico. Altresì, si possono delinearsi processi di
configurazione, osservando alternativamente ora una immagine, ora
un'altra nello sfondo, adattandoli alla nostra esperienza ( ognuno
vede ciò che sa'). Così, la percezione visiva del nostro mortaio in
una composizione modulare su un piano, tende a completare la forma e
a darle un significato, prediligendo alcune configurazioni su altre
personalizzandole. Le cosiddette figure ambigue esemplificano questo
aspetto: poiché la nostra attenzione può concentrarsi solo su una
figura alla volta, selezionando quelle più semplici e definite;
oppure quelle per noi più significanti. Come percepiamo le immagini,
ad esempio di fronte alla composizione di una balaustra? IL nostro
cervello seleziona, immediatamente, la plasticità e linearità delle
colonnette, oppure il disegno nello spazio vuoto tra esse.
Desideriamo,
qui, dimostrare che il mortaio è un manufatto nobile e non
artigianato minore come si suol dire. Insomma, non stiamo parlando
del mortaio di discutibile fattura, riempito di acqua o di mangime e
buttato nel pollaio dai nostri avi. Nossignori, stiamo parlando di
un Re, che ha antenati illustri (archetipi). Le misure commerciali,
con le quali viene nominato, sono estremamente precise, siano esse
riferite al palmo di Genova, che al piede inglese: nella prassi
mediamente di cm. 25 il primo e 30 il secondo. Entrambi appartenenti
al sistema dodicesimale, divisibili per 12 e quindi cm. 2 per l'oncia
genovese, di cm. 2,5 il pollice inglese. Così quando si dice del 10
del 12 del 16 e 22, si nomina un mortaio riferito a precise tabelle,
esposte alla futura domanda della clientela. Un Re mortaio, che
rispetto alle misure ed alla qualità del marmo, che sia duro e
fresco, ha il suo peso ed il relativo prezzo. Le misure sono prese
nel loro maggior diametro superiore, ma su l'orlo esterno, escluse le
orecchie. Il mortaio, come la scultura, ha un proprio canone, che
stabilisce le proporzioni tra le varie parti.
UN
CANONE LA PERFEZIONE DEL BELLO IDEALE
Solitamente,
i mortai si ricavano da piccoli blocchetti tagliati e squadrati e
nella misura desiderata. Se vogliamo agevolarci nel lavoro, il
parallelepipedo ottimale ha un quadrato alla superficie, dove è
possibile ricavare le dieci parti ( se comprendiamo anche le
diagonali, con le orecchie; ma otto parti il lato del quadrato ). Lo
stesso quadrato è alla base, anche se qui avremo una percentuale di
sfrido, perché le parti, da ricavare, sono quattro; le altre facce
hanno una altezza uguale a sei parti. Le misure canoniche sono le
seguenti ( vedi disegno n° ).
La
parte superiore è composta di 10 parti ( 1: 10 , come detto ) :
di cui n ° 6 l'invaso, n° 1 + 1 il bordo esterno/interno delle
circonferenze del mortaio; n° 1 + 1 sono due delle quattro
orecchie. La profondità dell'invaso è di 4 parti più un mezzo ( 4
+ 1/2 ), mentre lo spessore della sua base ( il fondo ), è di parti
1 più un mezzo ( 1 + 1/2 ). Il diametro della circonferenza della
base è di 4 parti, e la sua distanza dall'altra, diametralmente
opposta, è di 6 parti, che corrisponde all'altezza del mortaio. Il
sistema di calcolo è molto semplice: abbiamo detto che, usualmente,
i mortai si fanno sulla misura richiesta ; per calcolare l'unità di
misura è sufficiente dividere per otto, il maggior diametro
superiore, preso sull'orlo esterno all'invaso, che corrisponde alla
misura del lato del quadrato. Se poniamo il lato del quadrato è di
cm. 12, l'unità di misura è di , 12: 8 = cm. 1,5 . Meno
difficoltoso è partire da una unità di misura standard a piacere;
ad esempio di cm. 2, di 2,5 o 3, e moltiplicarla con le parti
indicate o adeguandole alla grandezza del marmo a disposizione.
Tecniche
di lavorazione.
Si
procede annerendo, con carboncino ed erba grassa, la parte superiore
del mortaio. Abbiamo di fronte la prima faccia quadrata , tracciamo
con il punteruolo le diagonali, poi, passando dal centro, nella sua
esatta metà, il diametro. Su questo, dal centro, con la stessa
apertura del compasso si indicano i punti 1 e 2, a piacere; indi, con
centro in questi, con altre intersezioni ( 3 e 4 ), si alza l'altro
diametro perpendicolare. Dal centro, con apertura del raggio pari a 3
parti ( diametro sei ), si disegna il cerchio dell'invaso.
Dall'incrocio di questa circonferenza, con le perpendicolari ai lati
( diametri ortogonali ), si ricavano i punti 5 – 6 – 7 – 8 .
Da questi, altre intersezioni uguali al raggio, si rettificano,
meglio precisandole, le diagonali. Sempre dal centro, con raggio 4
parti, si traccia la circonferenza dell'orlo esterno. Le
intersezioni 5 – 6 – 7 – 8 sono necessarie per
puntare il compasso alla unità di misura indicata e disegnare le
orecchie.
Sui
lati del nostro quadrato rimangono i punti di incontro delle
diagonali e dei diametri, da tutti questi, manovrando con il
compasso, si cerca il centro del quadrato alla base, speculare
all'altro in alto. Da qui, con apertura di raggio 2 parti, si segna
il cerchio di fondo. Il nostro mortaio è disegnato e visto come se
fosse in pianta : con la gradina e con lo scalpello, contorniamolo,
ricavando dall'inciso, un intaglio di almeno due centimetri, dopo di
che si comincia a scolpire il tutto. Un primo accorgimento è quello
di mettere il mortaio in una morsa, appoggiato su uno dei lati, in
costa. Il secondo, è quello di eseguire delle tracce, a mo' di linee
guida, che iniziano dall'attacco delle orecchie sulla circonferenza
esterna e proseguono, le tracce, fino ad incontrare la circonferenza
alla base. Si tenga conto della rastremazione voluta, quando si
inizia ad unire le due basi, per dare forma ad un solido molto
simile ad un tronco di cono. Se non si è già provveduto prima, a
svuotare il catino, intagliato nel bordo interno, lo si può fare in
corso d'opera, dopo aver abbozzato il lavoro e prima della definitiva
rifinitura.
DALL'ESTETICA
AL LINGUAGGIO VISUALE
DI
SEGUITO IL PROGETTO PER LA PERFETTA ESECUZIONE DI UN MORTAIO
CLASSICO, CON LA POSSIBILITA' DI VARIARE LE MISURE A SECONDA DELLE
DESIDERATE RICHIESTE.
DALL'ESTETICA
AL LINGUAGGIO VISUALE. Nella scultura, il segno, che è una diretta
emanazione dell'uomo, non è la parola, lo scritto, il gesto
convenzionale : è una sfida con la materia, una lotta. Il togliere,
l'incidere, il trattare in un certo modo le superfici, esposte al
gioco della luce e dello spazio, sono l'affermarsi di una tensione
tra l'uomo e la materia, sperimentando nuovi ed avveniristici
linguaggi. La texture, anche nel mortaio è importante: certe
incisioni, porosità, grumi incerti, fatti con la subbia, la gradina,
l'ugnetto o lo scalpello, sono passaggi dove la luce esprime tanti
modi diversi di essere e di comunicare della materia, non solo
estetici. Perciò spesso viene impreziosito con piccole figure in
bassorilievo, motivi ornamentali, anche in una certa fattura delle
orecchie. Perché così lo viviamo e sentiamo, a dispetto di molti
che lo considerano solo in termini utilitaristici : “ ma in fondo
in fondo, non è altro che un'utensile da cucina”. No è molto di
più.
Un
oggetto piace per se' stesso, per le sensazioni gradevoli che suscita
in noi, alla vista e al tatto. Sicché, la sua armonia anima in noi
ricordi piacevoli: le emozioni vissute, la memoria di abitudini a noi
care, familiari, un sentimento composto di usi e tradizioni. Insomma
nell'oggetto noi amiamo tutto ciò che vi abbiamo messo di noi:
archetipi che corrispondono alla nostra esperienza, a processi di
sviluppo e di adattamento all'ambiente, alle motivazioni percepite ed
a ciò che avviene intorno a noi e nel mondo. Il mortaio, con il suo
pestello, più o meno rudimentale, è una delle forme più antiche
usate dall'uomo.
"
Perciò la fascinazione artigianale deriva dal fatto che è passato
dall'intelligenza delle mani di qualcuno, che vi ha lasciato il suo
particolare segno con il suo lavoro e la sua sensibile passionalità,
e lo ha stigmatizzato con un oggetto originale e irripetibile. E' la
fascinazione di ciò che si è creato, di quel pezzo unico in un
momento unico".
Apprendiamo
da queste eccellenze, l'unitarietà dei pregi che il marmo accoglie
nel suo grembo, giacché la sua materia contiene in se e per sé quel
germe sublime che ogni buon artista sa' trovare con l'opera sua.
A
volte mi sorprendo ad osservare vecchie lavorazioni, vestigia del
passato, e comincio a fantasticare. E... mi piace, quella pattina
giallognola che il marmo assume con il tempo, nei luoghi chiusi. Mi
estranea dal momento reale. A tal punto che, mentre più mi fisso a
osservare, altri sensi sono presi da particolari suoni materici: da
quei particolari passaggi dei ferri sulla materia che ognuno di essi
produce: ecco! Ora la gradina scorre velocemente, a momenti incontra
piccole impuntature, modesti lasciti di materia in piccolissime gobbe
(le tocco con la mano). Sono modeste vibrazioni, quasi a
rappresentare lo stato d'animo dell'artista: tal volta leggero e
franco talaltra stanco. Avverto che la mano deve essere rilassata e
ferma quasi ad incontrare la dolcezza del verso, per un ottimo
impasto; altrimenti l'impeto e l'ostinazione incontrano durezza nello
eccessivo prender le cose di petto, avventatamente. Così si snoda un
percorso della lavorazione che dev'essere unitario e ritmato nei
modi, molto più a scorrere che a zappare (impuntature del ferro), se
desideriamo la materia più arrendevole e morbida nella musicalità
dei toni. Così lo scalpello dal taglio dritto ed affilato traccia
già i primi percorsi, parallelamente allineati, lungo il piano;
dianzi pregustando lo sfrigolio del raschietto sulle gobbe o rigature
tra una corsa e l'altra.
TECNICHE
DEL TELAIO E AFFINI
Nel
vocabolario la parola telaio ha definizioni varie, la più utile ci è
sembrata questa: incastellatura di regoli i cui assi formano una
linea chiusa. E' molto simile alla struttura che sostiene la porta,
sulla quale sono ordinatamente fissati i due cardini. Anche quella di
un campo di calcio ne rende bene l'idea, con le sue porte al limitare
dell'area. Queste sono le immagini più prossime al metodo e alla
struttura che indicheremo nel lavoro di smodellatura. Taluno
identifica questo sistema del telaio con quello detto delle squadre.
In effetti tra il termine telaio e squadre vi è una possibile
verosimiglianza. Ma per queste ultime il termine più affine è
quello di cornici, poiché soprastanti a coronamento di una figura o
altro motivo architettonico.
Nel
telaio abbiamo un piano di appoggio a terra, costituito da un banco
di lavoro idoneo : il tutto è formato da supporti di travicelli o
casse in legno ( tipico nei laboratori ). Su uno di essi è adagiato
il blocco; mentre il modello, solitamente, viene fissato ad una
lastra di appoggio, posta su un altro banco da lavoro adeguato. I due
soggetti, marmo e modello, collocati ordinatamente sul piano di
posa, sono sottoposti ad una propria livellatura e traguardati;
mentre si dispongono allineati e contrapposti frontalmente i due
telai sia del modello, sia, separatamente, quelli della statua da
farsi; nel bel mezzo stanno i piani di lavoro. I telai, sono tra
loro opposti e configurano perimetri di campi, quelli da loro
proiettati e singolarmente definiti, che hanno lunghezza, larghezza e
altezza, maggiori delle dimensioni di entrambi i piani di posa
menzionati.
Per
dare un'idea del lavoro preparatorio, immaginiamo due letti, ad una
piazza come i nostri di casa: l'uno, normalmente più piccolo,
contenente il modello, l'altro, la statua. Ognuna di queste figure
giacenti sul proprio letto, sul suo piano, distesi sulle coperte,
come se fossero delle persone. Ogni letto che si rispetti ha anche,
da capo a piedi, le sue due sponde, poste frontalmente. Queste, per
ogni soggetto menzionato ( i telai ), dobbiamo prefigurarle
predisposte in scala di proporzione; e, sempre sul filo
dell'immaginazione, pensarle livellate entrambe da un proprio piano
virtuale, passante per i bordi estremi delle sponde, che le collega e
si predispone parallelamente al piano geometrale ( o di terra ).
Così
raffiguriamo nella nostra mente dei parallelepipedi, posti l'uno
accanto all'altro ed ognuno con le proprie dimensioni atte a
contenere sia quelle del modello sia quelle del marmo. Abbiamo
descritto, con ciò, anche lo stesso posizionamento dei telai,
prefigurando nell'insieme il perimetro circostante al modello ed al
blocco. Proseguiamo nella posa in opera, segnando sulle traverse (
secondo la larghezza dei telai ) tante suddivisioni uguali - ad
imitazione delle tacche, a tal guisa, presenti nell'asta di ogni
stadera - purché ognuna delle quali corrisponda all'unità grafica
del rapporto designato, cioè conforme alle grandezze in scala della
statua e del modello. Si auspica sempre l'impiego, nella traversa
dianzi menzionata, di una riga in legno spessa e con un profilo
perfetto e non alterabile ( è il lato, in alto, dell'intelaiatura ).
Siccome ciò che è desiderabile non sempre è dato, si consiglia di
fare molta attenzione nel dividere e posizionare le tacche, previste.
Queste si segnano di traverso in tutto lo spessore del legno,
poiché su di esse, frontalmente, da un telaio all'altro, in
lunghezza, corre e si posiziona la cordicella del filo che
all'estremità cade a piombo. Facoltativamente, sempre sugli stessi,
è possibile tracciare, se il lavoro lo richiede, e per tutta la
larghezza occupata dalle tacche, una linea orizzontale che le
incrocia a 90 gradi, sulla stessa faccia alta di ogni traversa dei
due telai. Le linee e gli incroci dovranno essere perfettamente
paralleli e biunivoci. L'utilizzo di queste intersezioni avviene
raramente, solitamente si utilizzano pochi incroci (due alle
estremità, uno al centro, utili per controllare l'iniziale assetto
del lavoro sulla statua). Preminenti sono i profili emergenti delle
traverse, affinché siano a squadra, e possano dettare precise linee
perimetrali nei relativi campi di lavoro. Un tempo si incidevano le
tacche anche sui laterali dei telai per individuare meglio i piani ed
i livelli della scultura, semplicemente posando la cordicella sui
fermi, indispensabili, delle aste verticali; ricordiamoci dei livelli
della nota " vasca d'acqua " di Michelangelo. Ognuno di
entrambi i posizionamenti sono importanti, poiché assumono il
metodo della doppia proiezione ortogonale, e ciò non esclude anche
un aggiunta ai due piani principali (terzo quadro laterale).
A
naso rammentiamo il Vasari sul metodo in cui si toglie la pietra
superflua con gli scalpelli, pigliando le misure dal modello di
quanto sporgono fuori le gambe e le braccia e via scalpellando nel
procedimento dello sbozzo. Il raffronto dei livelli è con una vasca
ricolma d'acqua, nella quale viene immersa una figura di cera supina;
e così, a poco a poco, come la scultura nell'intaglio, verrebbe ad
uscire dal sasso, regredendo, allo stesso modo, facendo defluire
gradualmente l'acqua, si avrebbe la stesso effetto scultoreo sul
modellino, scoprendo man, mano, la figura: “ nella maniera cui si
caverebbe d'una pila d'acqua, pari e dritta, una figura di cera: ché
prima verrebbe il corpo e la testa e le ginocchia, et a poco a poco,
scoprendosi et in su tirandola, si vedrebbe poi la rotondità di
quella fin passato il mezzo, e in ultimo le rotondità dell'altra
parte “.
Grossomodo
l'intuizione sull'angolo visuale, pianta e fianco è una visione che
somiglia moltissimo al nostro telaio, poc'anzi descritto, sia per le
cale in pianta che i piani individuabili sul fianco della vasca.
Sennonché, la descrizione delle squadre “su le Vite” ci sembra
incomprensibile ed incomparabile.
Come
Si Opera.
Terminato
il lavoro di preparazione, si prende una cordicella lunga quanto
basta, con all'estremità due pesi adeguati e la si appoggia sulle
tacche, quasi a rappresentarne il loro prolungamento - prima su un
lato della traversa, poi sull'altro - a coprire tutta la distanza dei
telai: non è complicato, le parti incise sulla costa ben traguardate
e numerate sono in sincronia, mentre i telai sono uno di fronte
all'altro: si tratta di porre la corda sulle stesse tacche
prospicienti collegandole. Con esse operiamo un ultimo controllo:
poiché portano lo stesso numero in entrambi i lati dei telai, si
segna la corda, con un pennarello, laddove incrocia con le linee
orizzontali e/o gli spigoli. Va da sé che a misure uguali, prese
nelle stesse speculari estremità dei due lati, corrisponda una
perfetta posizione parallela dei telai e delle linee d'orizzonte
contenute. Predisposto ciò si murano definitivamente i telai,
cementandone i piedi. LA PARTENZA è IMPORTANTISSIMA; lo smodellatore
scandaglia il blocco, per vedere se vi può uscire la statua nelle
volute proporzioni; assesta l'insieme del lavoro riportandone i punti
principali dal modello. Soprattutto si prendono, dalla cordicella, le
cale, in modo che le distanze dei piani del modello e del marmo siano
uniformemente proporzionali alla proporzione generale fra modello e
statua da eseguirsi. Si possono adottare due modi di iniziare il
lavoro. Partire in autonomia sul modello e sul blocco come tante
delle classiche tecniche, mai escludendo le cale della cordicella dei
telai. Riporto dei “tre o dei due capi punto della mezzeria”, con
intersezioni su piani simili, in larghezza e lunghezza, proporzionati
tra modello e marmo. Sia chiaro che le cale guideranno tali riporti
di posizionamento. IL secondo modo è dato quello dell'ausilio delle
tacche; la partenza è dal piano dei telai: si fissano, alle
estremità della riga - nella nostra ipotesi (0-20) - su una delle
due linee orizzontali, i noti capi punto 1 e 2 ; sull'altra opposta,
nella sua metà si mette il capo punto 3. Lo si segna al n° 10 se le
tacche sono 20. Uniformati i due piani (per tre punti non allineati
passa un solo piano), ora apriamo i compassi sulle tacche estreme, si
riporteranno, a destra ed a sinistra, sul piano del blocco le misure
dei capi punto presi dal modello tracciando su esso due archi che con
l'intersezione del “3”, sul piano, si segneranno i relativi 3 e
4, scelti tra i capi punto più emergenti. Sfruttiamo anche la
posizione della cordicella, visto che, da sopra il lavoro, si possono
proiettare linee ortogonali che, non solo misurano la profondità, ma
indicano anche la posizione esatta del punto, che è confermata
anche dalla sua distanza misurata dalle tacche. Iniziamo il lavoro
con il primo dei due esempi, già mettendo mano al trasporto dei
punti principali predisposti sul modello: il riporto inizia da
quelli collocati circa alla metà di esso; l'uno sul fianco destro,
l'altro sul fianco sinistro. Da qui, dalle sponde, partono le prime
delle tre intersezioni . Con apertura di compasso uguale alla
distanza del primo punto, laterale destro, dalle due tacche di mezzo,
dei telai, si effettuano le prime intersezioni ( due più la cala
dalla cordicella sovrastante, che sarà perpendicolare al punto );
poi si provvede a riportare l'altro, a sinistra, con identica
operazione. I due punti rappresentano gli estremi laterali, che
utilizzeremo per trasportare i capi-punto situati uno alla testa e
l'altro ai piedi del modello, per facilitarci le intersezioni delle
misure lunghe sul piano. In questo modo si è anche cominciato ad
individuare i vari campi di lavoro. Altri capi-punto strategici
possono essere individuati per migliorare la geometria dei campi
necessari ad un fedele trasporto dei punti. Fatte queste prime
operazioni, si possono escludere le misure dei compassi dalle tacche,
passando la direzione della manovra ai capi-punto del modello e della
statua da eseguirsi, ad eccezione delle cale. Come già accennato le
cale son state CALIBRATE; spieghiamolo meglio : dalla cordicella,
secondo la postura del modello, si sono prese le misure a quelle
parti della figura che spiccano più in alto, e alcuni punti
sottostanti, per verificare la proporzione diretta dei due volumi.
(Praticamente iniziamo dalla parte di maggior svettamento del gesso,
e con questa misura (la sua distanza dalla corda) proporzioniamo le
cale del modello e del marmo.). Poiché tutti i piani del modello,
nel loro regredire o avanzare debbono corrispondere,
proporzionalmente, a quegli stessi da eseguirsi nella figura, che
sono quelli del riporto dei punti necessari a riprodurre la statua
che il blocco deve poter contenere).
RIEPILOGHIAMO:
Tutti
possono valutare le tante difficoltà di comprensione: un conto è
l'esperienza pratica, un conto la teoria. Proviamo con un altro
tentativo di semplificazione. Sarà puerile dirlo, ma abbiamo
delineato un recinto delimitato dalle proiezioni congiunte e frontali
dei telai, come se fossero le due porte di un campo di calcetto,
collegate a confini ben delineati (con perimetro rettangolare). Lo
pensiamo a correre in alto : sopra di noi a livello delle traverse,
come una rete di fili a tramare, similmente ai vecchi telai nelle
tessiture. Così lo abbiamo immaginato, però spostiamo un solo filo,
a tutto campo e sulle tacche, che è la cordicella, ogni qual volta
desideriamo prendere una misura. E' proprio da questi fili che si
ottengono le “ cale” , misure importanti per individuare,
perpendicolarmente, un punto nella figura di un solido. Abbiamo
simboleggiato, ancora una volta in maniera esageratamente grande, un
poliedro. Un campo sportivo non somiglierà mai ad un blocco;
ma uscendo dall'immaginario, la sostanza è una sola: il marmo deve
poter contenere congruamente il modello. Ritorniamo alla realtà,
quella all'interno dello spazio sopra i banchi di lavoro, dove
giacciono il modello e la sua riproduzione, ognuno con il proprio
telaio nel rapporto voluto.
[Resta
l'idea di un sistema operativo che ci ricorda l'uso delle squadre o
delle cornici, poste in alto ortogonali alle mura dell'edificio,
aventi divisioni nei tre lati del perimetro aggettante i
corrispondenti fili a piombo. Ricordiamolo, solo per rilevare la loro
apparente diversità, e il loro impiego misto con il telaio a terra,
per ragioni di spazio, come si vede in una fotografia storica. Mentre
le squadre sono fissate alla parete, ad angolo di 90°, e poste sopra
la testa delle figure erette, sia del modello sia della statua per
ricavarne le profondità. Qui, le misure si prendono dal filo di una
cordicella tesa a piombo e mobile nel perimetro delle squadre].
Nel
sistema che descriviamo e che più correttamente chiamiamo del
telaio, l'esecuzione è più precisa. Intanto perché il telaio ha
proiezioni simili a quelle ortogonali al piano ( cale ). Non
dimentichiamoci che la cordicella percorre tutte le tacche
linearmente dal 0-0' o dal 2-2' in crescendo; ma può farlo anche di
sbieco, da 0 al 10', mettendosi in relazione compositiva,
diagonalmente, con parti da riprodurre. Rispetto alle cornici, il
telaio domina più stabilmente tutta l'area, come se si
sovrapponesse, ad un elaborato riprodotto in pianta; eppoi se la
distanza dei telai tra loro non è molta, si può anche alternare la
corda a piombo, con robusto ed inflessibile righello. E', inoltre,
facilitato il riporto per la posizione più stabile della corda, che
consente meglio l'apertura dei compassi tra essa ed il manufatto in
questione, per la possibilità di cadere ortogonalmente ( a piombo )
sul lavoro; di più, nel poter valutare, anche con i laterali del
telaio, il livello dei piani, le sporgenze, i rientri della figura,
riportando una corda tesa su alcune tacche predisposte nei fianchi
dello stesso. Si è da più parti, indicato l'esperimento di
Michelangelo, con l'immersione di un modellino in una vasca d'acqua,
lo rapportiamo all'esempio dianzi fatto, quello dell'estensione del
filo laterale, poiché questi si pone sulla medesima traccia del
livello dell'acqua: che è un livello sugli scorci dei piani che la
figura, vista di profilo, staglia, quando il fantomatico pelo
dell'acqua si alza o si abbassa.
TELAIO
: ALTRE TECNICHE
Bassorilievi
e Altorilievi
Questa
applicazione del telaio può essere fatta prefigurando un impianto
più modesto per i bassorilievi e altorilievi, mantenendo inalterate
tutte le applicazioni e regole che riguardano l'uso del triangolo di
proporzione. In tal caso i supporti, con funzioni simili ai telai,
sono su spessori nel piano lastra del modello; alzati sopra lo stesso
a copertura delle parti che più si ergono: sono lastre di varia
altezza a seconda del volume del lavoro, che vanno “inmasticiate”
sia nel modello che nel blocco secondo le proporzioni date
all'ingrandimento o alla riduzione. La loro altezza, rispetto al
maggior picco verticale del marmo e del modello, sempre in
proporzione, deve poterli superare in maniera tale da consentirne
l'agibilità dei compassi dalla cordicella ai piani, per praticare la
misura delle cale (profondità).
I piani
di partenza debbono essere posti a livello e, il tutto, compresi i
supporti delle corde, ha da essere traguardato. Su questi, si
procede incidendo sulle loro coste o spessori delle tacche, che
saranno incrociate ( a 90°) da due linee, dette di orizzonte, che
limitano il campo dei due opposti estremi. Su queste linee, si
faranno delle divisioni rapportate alla loro lunghezza (tacche) e,
sul lato omologo, del modello e del blocco, su lati omologhi, si
segneranno, alle estremità, due capi punto. A metà delle tacche si
indicherà la linea di mezzo, da entrambi le parti, e sul lato
opposto ai due capi punto, si segnerà un capo punto nella mezzeria
delle tacche. IL tutto, nel mantenimento del rapporto proporzionale
generale. Nel fissare i primi capi-punto, si seguono le stesse
indicazioni della tecnica del telaio: con il riporto dei primi capi
punto laterali sul piano, presi dalle proiezioni delle tacche, di
mezzo e poi via via tutti gli altri, a cominciare da quelli di
mezzeria opposti ed ortogonali ai primi. Una volta che si è avviata
l'opera con i capi-punto della mezzeria, il telaio si utilizza solo
per le cale, osservando un modulo unico: può trarre in inganno, un
sistema misto di misure: lunghe e profondità prese, un po' dalle
tacche, un po' dai punti sul piano.
UNA
DIVERSA IMPOSTAZIONE DEL TELAIO.
I
TELAI sul piano terra, se lo spazio nel laboratorio è scarso,
possono essere posizionati in un altro modo da quello tradizionale,
facendo ricorso ad un sistema misto: mentre il telaio sovrastante il
blocco rimane fisso a terra, quello del modello, può essere, in
tutta la sua altezza, posizionato dritto ed aderente alla parete più
prossima. A questa, e sopra la testa della statua, è fissata, alla
parete, una squadra o cornice, che pur mantenendo la stessa
proporzione, rispetto al rapporto di grandezza stabilita con il
telaio, è parte di un sistema detto delle gabbie.
Con
ciò necessitiamo di ulteriori delucidazioni, mai troppe ed
inopportune.
COME
SI PUO' INDIVIDUARE UN PIANO NELLO SPAZIO.
A)
Ricordiamoci che ci stiamo occupando delle figure solide, i cui punti
non giacciono tutti sullo stesso piano ( ogni piano divide lo spazio
in semispazi, ognuno dei quali contiene infiniti punti ). B) Concetto
di piano si intuisce ma non si definisce; sono facilmente intuibili i
seguenti postulati: 1) un solo piano nello spazio può essere
determinato, tra gli altri, per tre punti non allineati. 2) Per due
punti A e B di una retta passano infiniti piani, ma uno solo di
questi passa per un punto P, assegnato, non appartenente alla retta.
E' lo stesso principio " della piramide a base triangolare",
per trovare il suo vertice occorre riferirsi almeno ad altri tre
punti non allineati.
C)
INTERSEZIONE: L'intersezione di due figure è la parte che hanno in
comune: perciò una retta che non appartiene in alcun modo ad un
piano, ma lo interseca, ha solo un punto in comune con esso.
Il
principio di B. Cavalieri.
Il
principio di Cavalieri pensa che un solido si possa considerare
formato da tante lamine sottilissime sovrapposte: due solidi uguali o
diversi, ma formati dallo stesso numero di lamine, dello stesso
spessore, con superfici equivalente, essi avranno la stessa
estensione. L'enunciato: " dati due solidi, se è possibile
disporli, rispetto ad un piano, in modo che ogni piano parallelo a
questo li tagli secondo sezioni equivalenti, i due solidi sono
equivalenti ".
Questa
teoria la valutiamo estensivamente, nella stessa visione che tutti i
corpi hanno una loro dimensione solida (occupano una parte di spazio
) e sono racchiusi da poligoni o figure piane di diversa dimensione.
Più che al risultato della equivalenza ( prismi aventi altezze
uguale e basi equivalenti avranno la stessa estensione ), il nostro
obiettivo, solitamente, è quello di riscontrare la similitudine:
esclusivamente di uguale forma. La consideriamo diversamente perché
il nostro modello, indipendentemente dalla postura e dal suo rapporto
in scala, lo immaginiamo imprigionato in un parallelepipedo, che è
la sua riproduzione nel blocco di marmo. Noi siamo interessati alla
manualità del levare il superfluo, per copiare il modello, partendo
dall'unicità del punto di vista frontale e dal succedersi dei piani.
Si inizia predisponendo l'intaglio dal piano alto, e mano mano,
scoprendo le parti più sporgenti, si scende fino alle rotondità
posteriori del piano di base. Il lavoro viene affrontato
frontalmente, ma contemporaneamente, si opera anche sul profilo della
statua per mantenerne i contorni e la giusta postura, secondo le
proporzioni stabilite e mantenendo l'organicità della composizione.
1.RIPRODUZIONE
DI SCULTURE PER MEZZO DEL TRASPORTO DEI PUNTI. 2. - INTAGLIO DIRETTO
( "COSIDDETTO AD OCCHIO" ).
Di
solito con il bozzetto si fissano le prime intuizioni, precedute da
uno studio comprendente diversi disegni di approccio. Dai disegni,
l'idea si concretizza con un primo modellino in creta, al quale segue
la formatura con la colata in gesso, seguendo il metodo della forma
persa ( raramente si utilizzano gessi di grandi dimensione ). Sembra
si sia perduta la tradizione del CANOVA – salvo rare eccezioni –
per l'uso di modelli di pari grandezza al vero (monumentali), che
offrivano il vantaggio di valutare tutte le incidenze: proporzioni,
luce, linguaggio della postura; concorrenza dei volumi e vuoti,
linearità. Il ricorso a piccoli modelli è la norma, poi si affida
l'opera a maestranze esperte. E' possibile che l'artista intervenga,
con l'ultima mano. La presenza del modello, da tradurre nelle
proporzioni stabilite, oltre ad una visione generale e particolare,
offre anche l'ingegno di trasferire dal modello al marmo tutte le
misure necessarie per la buona riuscita dell'opera, con il pantografo
(macchinetta) o con l'ausilio dei compassi.
Anche
L'INTAGLIO DIRETTO prevede un qualche studio più o meno
approfondito, predisponendo qualche bozzetto di riferimento; tranne
che per il lavoro cosiddetto commerciale che ha una tradizione
artigianale e/o industriale. Qui, l'utilizzo di un disegno, stampe
e/o fotografie è, da tempo, prassi consolidata. Le copie dei
rilievi, sul marmo, si possono riportare con la tecnica dello
spolvero tamponando i contorni forati di un disegno - o semplicemente
ricalcandolo. Soprattutto nell'arte cosiddetta sacra e funeraria,
l'intervento è diretto, d'acchito, utilizzando molteplici sistemi
per " impastare" l'opera e la sua pulitura, che avvengono
con frese e moderni macchinari.
Ma
l'ottimo artigiano va oltre il modello, il disegno e ciò che deve
essere rappresentato: “tutto è già nella sua mente”, magari è
parte del suo gran praticantato, di un lavoro di routine. Non inventa
e non scopre cose nuove, perché è più propenso a continuare il
verso di una tradizione e di un manierismo locale. Ha solo una grande
padronanza del mestiere e della particolare specializzazione, che lo
porta ad interpretare, nel migliore dei casi, pregevoli idee. Dal
punto di vista tecnico la praticità lo porta a considerare il
regredire dei piani e quindi toglie via via, quella quantità di
materia che gli consente di scoprire la geometria della figura assai
prima dei particolari e di eventuali sotto squadra. E sa' bene, che
se la figura deve essere cavata, ciò può avvenire curando le
proiezioni da tutti i lati; ma uno solo, quello frontale, che è il
punto di vista principale, è il più disposto, e marcato, con
migliori riferimenti, di stacco e di ripresa. Il procedere va'
valutato da più punti di vista: lo è il riporto di alcune misure
certe, tracciate nel marmo; oppure il passaggio di diverse figure
professionali che intervengono dalla sbozzatura alla rifinitura. Nei
rilievi, permane il penoso dilemma di come mantene i punti di
riferimento del disegno, nei suoi contorni e nei suoi stacchi.
L'antico
sistema di trapanatura in profondità è rischioso e poco produttivo.
LA
CITTA' DI CARRARA E LA CRISI DEL MARMO. LABORATORI A RISCHIO. IL
BIANCO DI CARRARA MATERIA PRIMA PER UNO SPEZZATTINO MADE IN CINA.
LAVORAZIONI IN LOCO?
È
il momento di ritornare alle nostre migliori tradizioni, a quel
periodo AUREO, classicheggiante, che fece di Carrara una città unica
al mondo: " il mestiere ", meglio i mestieri, non sono solo
l'esercizio di una attività pratica: sono un sentire, con e verso la
materia, sono una cultura, a tutto tondo, che ha fatto di Carrara una
città unica al mondo. La bramosia del guadagno, del tutto e subito,
ci ha portato alla crisi del prodotto finito, ben fatto. Si è
perduto una cultura del segno, si è cancellato l'universo dei
linguaggi, che si svilupparono nella dimensione temporale; siccome
nella pittura, anche nella scultura e nella architettura, si sono
manifestate imponenti configurazioni, fin dai primordi, nell'ampio
mondo della comunicazione.
PRIME
IPOTESI PER UNO STUDIO
UN
buon disegno è il preludio ad un'opera ben fatta ( a regola d'arte
). Questo concetto, spesso, non è debitamente considerato ( c'è un
rigetto su tutto ciò ciò che è troppo accademico e scolastico ). I
nostri vecchi artigiani conoscevano bene le tecniche del disegno, sia
quello della figura umana e dell'ornato; sia del metodo delle
proiezioni ortogonali, che consente di indicare forma e dimensioni
reali ( pianta, prospetto e fianco ). Il nostro ragionamento si
soffermerà, generalmente, sulle riproduzioni delle statue di marmo
da piccoli modelli. Quindi esempi di riproduzione e copie di disegno
sulla figura umana; non escludendo esercizi concomitanti sulle figure
a geometria piana. Ciò è inizialmente soddisfatto dalle copie di
disegni con l'utilizzo dell'angolo e del triangolo di proporzione.
Così, schemi di riproduzioni, ingrandimenti e riduzioni, nello
smodellare e nella copiatura di disegni, esplicano e sperimentano un
pratica ad ampio raggio. In entrambi i casi, occorre definire alcune
linee generali all'interno di schemi geometrali. Partire da forme
elementari, semplificando anche le forme più complesse : " non
esiste una forma complessa che non possa essere ridotta ad una più
semplice ( triangolare, trapezoidale, sferico, ovale, ecc.. )".
Nello specifico, il blocco di marmo è considerato, grossomodo, un
parallelepipedo: è composto di sei parallelogrammi, consentendo di
utilizzare il migliore dei suoi piani per impostare il modellato. Ciò
dopo aver predisposto anche il modello, adeguando il suo
posizionamento al metodo del lavoro da farsi; poi, si inizia
l'opera con i compassi. Dato un piano, stabilito similmente al
modello, si comincia a trasportare, nel blocco, le misure necessarie,
con tutti quei punti a distanza uniformemente proporzionali. E'
possibile anche escludere l'utilizzo dei compassi e del modello,
togliendo di acchito la materia, smodellando "ad occhio"
direttamente. In questo caso il disegno ed il saper disegnare sono
essenziali. Lo schema, simile alle proiezioni ortogonali, consente,
anche nella scultura, di descrivere la figura in pianta, prospetto e
fianco; segnando direttamente sul marmo, con il carboncino, e
iniziando così la fase della sbozzatura. Ci sia consentito di
segnalare alcuni esercizi utili, prima di affrontare la complessa
materia della riproduzione delle statue di marmo, e l'utilizzo
conseguente dei compassi e del triangolo di proporzione.
ESEMPI
DI RIPRODUZIONI:
PER
MEZZO DELLE INTERSEZIONI.
Scelti
i punti A e B di una retta r tracciata fuori del modello, si
congiungono i suoi vertici con A e B ; poi, in un altro foglio, è
tracciata una retta r' per la riproduzione, e si riporta in A' e B'
il segmento A B. Facendo uso del compasso e centrando in A' e B' si
riportano le medesime intersezioni del modello. Questo uso dei
compassi, trasportando tutte quelle misure e distanze, nelle
proporzioni uniformemente scelte, sarà comune a tutti gli esempi.
PER
MEZZO DELLE COORDINATE.
Tracciata
nel mezzo del modello un retta r orizzontale, si proiettano, su
questa, conducendovi le perpendicolari, i vertici della figura.
Conseguentemente, si traccia sul foglio, destinato alla riproduzione
, la corrispondente retta r', segnando con il compasso le misure
prefissate.
RIPRODUZIONI
PER MEZZO DELLE DIAGONALI DA UN ANGOLO.
Da
un' angolo qualsiasi di un modello irregolare, si congiungono i
vertici al miglior angolo di riferimento, che rimane suddiviso in
altri angoli di minore ampiezza, dando vita ad un serie di triangoli.
Come negli altri casi precedenti, si opera con i compassi nella
riproduzione, riportando le misure nelle diagonali qui tracciate.
CON
L'IMPIEGO DELL'ASSE DI SIMMETRIA.
Per
riprodurre, ridurre , ingrandire disegni è ottimale rilevare l'asse
di simmetria del modello e le sue distanze orizzontali e verticali
conseguenti. Tutte queste misure, possono essere riportate, come nei
casi precedenti, uguali, ridotte od ingrandite, a seconda delle scale
di proporzione scelte. Il sistema è dei più semplici: si riportano
sia nel modello, sia nella copia, le perpendicolari all'asse
centrale: su di esse si riportano, simmetricamente, col compasso, le
distanze rapportate alle scale scelte.
ANGOLO
DI PROPORZIONE.
{RIDUZIONE}
Si
costruisce, a piacere, un angolo acuto A - R- S. Sul lato R si porta
la prima lunghezza A - B ( la misura maggiore tra quelle del modello
); mentre sul lato S si segna, con la riduzione, in SCALA, voluta, la
distanza A - C, che si unisce ad A - B tracciando la retta da B a C .
Dopodiché, si riportano su R le altre misure ( 1, 2, 3, 4..., quante
ne occorrono), le quali si riconducono al lato S, tracciando tante
parallele alla prima retta B - C ( avremo così le misure 1, 2', 3',
4', ecc.., che saranno CONGRUENTI).
INGRANDIMENTO.
Il
procedimento è simile a quello precedentemente impiegato per la
riduzione: ugualmente, la lunghezza maggiore del modello sul lato R (
A - B ); mentre la maggiorazione voluta si segna sul lato S ( A - C
), i quali si uniscono con una retta ( da B a C ). Tutte le altre
misure del modello, riportate sul lato R, si ricongiungono al lato S
mantenendosi parallele alla
retta
B - C .
RILIEVI
MARMOREI.
Nei
lavori di ornato e nei rilievi marmorei le INTERSEZIONI, come nella
riproduzione di un buon disegno, sono dirette e facili da eseguire: i
punti trovati, uniti fra loro, formano le figure richieste uguali al
modello ( o simili ). Nella lavorazione del marmo, oltre che, nel
riporto degli incroci per lo sviluppo del disegno, dobbiamo tener
conto dei piani e del loro degradare fin sullo sfondo. Consideriamo
il piano di un rilievo ( di vario spessore), sul quale abbiamo
tracciato il nostro disegno, con uno scalpello tondo ( tagliente
semicircolare ), iniziamo ad incidere il disegno fissato ( profondità
di almeno 1 centimetro ).
Eseguiti,
in tal modo i contorni della figura considerata, si procede con gli
sbassi, ricercando i piani strategici che possono, nel prosieguo,
indicarci e conservarci sia gli assetti, sia i migliori contorni e
valori plastici. Poiché, man mano che procediamo nell'intaglio, per
la gradazione e scendere dei piani, i segni scompaiono, occorre
lasciare, alle estremità del rilievo o sulle coste del suo spessore,
le tracce originarie, per recuperare i riferimenti delle primarie
intersezioni ( disegno ). Per tracce intendiamo i primi segni
divisori della griglia disegnata, posti alle estremità e ai lati del
bassorilievo; seguono le tacche, incisioni indelebili fatte con il
punteruolo, sui più importanti indici di riferimento. Un altro
metodo, quello più antico, consiste nel contornare, il disegno, con
piccoli forellini, assecondando la profondità dei piani. Mantenere
l'orientamento del disegno è estremamente utile anche per
traguardare le altezze e per scoprire la gradazione differenziata dei
piani. Si procede ad occhio, considerando, se vi è un modello, il
punto di vista frontale (superficiale ), cavando quel tanto di marmo
che gli è sufficiente per far arretrare e scoprire, parallelamente
da un lato all'altro, prima le parti più sporgenti e in rilievo,
poi, gradualmente tutte le altre.
Diversamente,
un disegno o una foto possono solo essere interpretati, con l'aiuto
dell'esperienza e del mestiere, non avendo, essi, riferimenti
plastici concreti.
TECNICHE
PARTICOLARI NELL'INIZIO
DEL
LAVORO DI SMODELLATURA
Sul
triangolo rettangolo.
Abbiamo
già indicato – sulla sbozzatura/smodellatura – diverse tecniche
in merito all'inizio lavoro, citandone l'impiego, anche sul triangolo
isoscele e descrivendo le specifiche valenze di ognuno, con i
relativi tempi di applicazione; e, nell'insieme, riguardanti statue
di medie e piccole dimensioni. Le osservazioni che seguiranno, le
dedicheremo a misure più grandi, colossali, di cinque o più metri.
Consideriamo l'ipotesi di lavorare ad una statua di m 5 ed un modello
di m 1, equivalenti a cm 500 e cm 100. I compassi, quando si
confrontano con queste misure possono essere imprecisi e poco
maneggevoli e presentare un quadro ottico fuorviante. Mentre
un'ottica diversa e migliore l'abbiamo se sappiamo valutare i piani
di rilievo delle figure, che sono paralleli e omotetici, con il loro
rapporto costante, perciò possono essere pensati come soggetti e
guida di una trasformazione proiettiva o proiettività. In tal caso
la figura modello è trasformata nella figura simile della statua da
farsi. Identica è la posizione dei piani nella loro gradazione
differenziata, nelle parti più sporgenti, conseguenti l'unicità del
punto di vista frontale. Perciò alla superficie ed alla base vanno
individuati i relativi poligoni: equiangolo, equilatero o regolare
purché corrispondano alle misurazioni di rito ed alle tecniche più
volte menzionate. Così si risolvono i problemi costituiti dalle
dimensioni del lavoro e del triangolo. Quando ingrandiamo o
rimpiccioliamo una figura, operiamo in modo tale da mantenere
inalterati tutti gli angoli del modello e della copia, mentre tutti
i suoi segmenti vengono aumentati o diminuiti in proporzione: in
definitiva non facciamo altro che costruire una figura simile a
quella data.
Nel
nostro caso, il termine figura, è riferito propriamente al complesso
delle sembianze umane, oppure alla forma o aspetto esterno di qualche
cosa: da fingere “plasmare” e nel significato tridimensionale di
studio delle figure solide. Così nello scolpire il tutto è
riconducibile ad una schematica immagine di forme geometriche:
composizioni e fattezze particolarmente utili nella fase di
sbozzatura. Operiamo trasformazioni di figure geometriche aventi la
stessa forma, perciò più affiniamo la scultura, nel prosieguo del
lavoro, sempre più la rendiamo simile alla copia.
Utilizziamo
la similitudine dei triangoli, che hanno la stessa forma e gli angoli
ordinatamente uguali, mentre i lati corrispondenti sono in
proporzione. La loro definizione riassume la regola nelle
riproduzioni in scala: ogni parallela ad uno dei lati di un
triangolo, o angolo di proporzione, che intersechi gli altri due,
determina con questi ultimi un triangolo simile a quello dato e
divide gli altri due lati in segmenti direttamente proporzionali;
anche la stessa parallela mantiene lo stesso rapporto con il suo
corrispondente. Infatti dato un triangolo ABC, in qualsiasi punto del
suo lato AB, se conduciamo la parallela DE al lato BC, avremo i lati
corrispondenti in proporzione: AB: AD = AC: AE = BC: DE. Cioè siamo
interessati ad un problema geometrico: dividere una retta data nella
stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; così come
lo è la divisione di due o più segmenti, riferiti alla stessa unità
di misura, in parti tra loro congruenti. Ad esempio dividiamo le
altezze del modello e della statua per uno stesso divisore: ( cm 500:
2 = cm 250 ) e ( cm 100: 2 = cm 50 ), avremo da gestire due misure
ridotte, fra loro sempre direttamente proporzionali, che ci
consentono di lavorare, sia segnando il triangolo in un lastra; sia,
come precedentemente descritto, segnando la mezzerie delle figure e
mettendo ai loro fianchi il terzo e quarto capo-punto, fatti salvi
gli spessori esistenti. Abbiamo indicato questa impostazione del
piano, come quella del “punto falso “ , ciò però non esclude
altri approcci, già esplorati; ma è nostra convinzione che questa
preparazione, del terzo punto di servizio, sia la più facile: poiché
abbiamo una linea longitudinale di mezzeria ed il controllo delle
fiancate, con un piano funzionale che ci consente di controllare e
calcolare con più esattezza il lavoro. Una ulteriore
considerazione, dopo aver fissato il capo-punto 3: il lavoro procede
con relativa facilità, perché le misure e l'apertura dei compassi
si riducono ulteriormente, fissando, da subito, il capo-punto 4
nell'altra faccia del marmo. Possiamo ridurre ancora, eccovi altri
esempi, le misure del triangolo di proporzione e, considerate quelle
del marmo in cm 501 e quella del modello di cm 102, le dividiamo per
tre. Troveremo due soluzioni corrispondenti. La prima, identica
procedura dell’esempio precedente, dividiamo per tre marmo e
modello : l'uno cm 501:3 = cm 167, l'altro cm 102:3 = cm 34 . In
questo caso per misure maggiori, prese dal modello, superiori a cm.
34, possiamo usufruire del prolungamento delle semirette. La seconda,
può verificarsi come un'eccezione utile alla regola, lasciando
inalterata la misura del modello, che rimane com'è, segnando sul
triangolo cm 102. Possiamo farlo con qualsiasi grandezza, dividendo
solamente quella della statua (cm 501) : cioè dividiamo per 3 il
lato più lungo, che assume il ruolo guida, l’ipotenusa, di cm
501:3= cm 167, adottando un particolare accorgimento; dopo aver
rilevato una misura dal modello e sviluppata proporzionalmente con
l'arco tangente, se, ad esempio, il risultato è di cm 75, dobbiamo
- così come abbiamo diviso il triangolo - moltiplicarla per tre (
cm 75x3 = cm 225 ), che sarà la lunghezza reale da trasportarsi sul
blocco, ristabilendo la congruità o valore sottratto dalla divisione
iniziale. Occorre far molta attenzione nel caso di statue colossali,
soprattutto se riprodotte da modelli molto piccoli: le riduzioni del
triangolo, dianzi dette, mantengono una loro validità se
utilizziamo, rispondendo alle difficoltà di un lavoro, sia la scala
numerica, sia il sistema delle scale grafiche o ticoniche. Comunque,
entrambe sono utili nel determinare più esattamente, anche con due
letture, le proporzioni poste. Un sistema pratico è quello di
dividere, in un egual numero di parti uguali, le altezze della statua
e del modello, con la certezza di una proporzionalità evidente e
corrispondente; ma vi è un altra importante congruità, che vedremo
in altra specifica tesi, nella stessa divisione delle altezze tra
statua e modello. Per ora, prendiamo le misure dianzi considerate: cm
501 e 102, dividiamole per 10 (o altro denominatore): avremo cm 50,1
e cm 10,2 che sono proporzionali o congrui tra di loro. Poiché ad
ogni cm 10,2 del modello corrispondono, in scala, cm 50,1 della
statua. E' possibile dividere ancora una parte di quel 10% ( 1/10 ),
fino a misure infinitesimali. Ma è consigliabile, una volta esperite
le prime suddivisioni uguali ed unitarie, costruire e servirsi del
triangolo di proporzione. [
Nella considerazione di gestire, sempre un rapporto costante e
immutabile, se dobbiamo lavorare su un modello piccolo ed una copia
colossale, dovendo riportare le prime distanze, è consigliabile
moltiplicare le misure del modello per detto rapporto, fintantoché
gli spazi non siano ridotti ad una gittata media e l'apertura dei
compassi più agevole. È preferibile, in sostituzione del triangolo,
utilizzare un buon metro lineare; e su esso confrontare le prime
misura da, moltiplicando, al.. Dopo disegnare e utilizzare il
triangolo ridotto. La stessa adozione per le misure da grandi a
piccole].
IL
RAPPORTO PREFERENZIALE
SCALE
NUMERICHE E GRAFICHE
LE
SCALE di proporzione possono, essere NUMERICHE O GRAFICHE.
LA
SCALA DI PROPORZIONE è il rapporto tra le misure lineari del disegno
e le corrispondenti dell'oggetto reale che si deve rappresentare
graficamente. Nel nostro lavoro l'oggetto è il modello/statua,
qualche volta espressi da un disegno. La scala numerica è indicata
con una frazione (1:10, 1:50, 1:100 ecc.).Il primo termine
(numeratore) indica l'unità di misura nel disegno; Il secondo
(denominatore) quante volte l'unità di misura corrisponde alla
realtà. La scala grafica semplice si costruisce tracciando una
retta, sulla quale si riportano tante suddivisioni uguali come
abbiamo già indicato.
Si
è richiamato queste elementari nozioni per introdurre una novità
nel lavoro di smodellatura e nell'utilizzo dell'angolo o triangolo di
proporzione. Cioè affronteremo, in seguito, un particolare rapporto
di similitudine, che ci faciliti l'ingrandimento o la riduzione, in
scala, di una scultura, con un valore costantemente evidenziato, tra
lati corrispondenti, che si definisce “rapporto di similitudine”.
In una statua di grandi dimensioni, per fissare alcuni iniziali
capi-punto, è utile ridurre le misure a grandezze ragionevoli, per
far si che l'apertura dei compassi sia alla portata di ogni
lavorante: I maranghini lascino ai compassi, più piccoli, il compito
di confrontarsi con misure dimezzate e campi di smodellatura sempre
più brevi ( minori di un 1 metro ), nei quali i puntatore possa
operare con sicurezza e maestria con compassi sempre più piccoli e
maneggevoli. In statue dai 5 o 6 metri, è ancora possibile fissare
un capo-punto intermedio, considerando che un maranghino può attuare
misure precise intorno ai 3 metri e mezzo. Nella pratica comune si
traccia nel modello e nel blocco la linea di mezzeria e fissati
all'estremità di essa i due capi punto iniziali, uno alla testa e
l'altro ai piedi della statua, si riportano prima su un fianco, poi
sull'altro (di fronte), il 3° e 4° capo-punto. Di seguito si
riportano tutti gi altri che sono molteplici ( una costellazione),
come ampiamente spiegato nelle "Tesi".
IL
QUOZIENTE DI DIVISIONE: FUNZIONE rappresentativa della
proporzionalità diretta.
Due
grandezze se sono direttamente proporzionali il rapporto fra un
qualunque valore della prima ed il corrispondente valore della
seconda è costante, Y : X = a, ossia Y = ax. Evidentemente se 1 cm
cubo di marmo pesa g. 3, evidentemente 2 cm cubi peseranno 6 g, 3
uguale 9, e così via. In questa tesi siamo interessati ad un
particolare rapporto preferenziale, quello di due lati corrispondenti
di poligoni simili che hanno sempre lo stesso valore: tale rapporto
si dice rapporto di similitudine. Le due altezze, nel triangolo di
proporzione, quella della statua e del modello, mantengono un valore
costante. Come utilizzarlo? Sarebbe gradito un quoto intero, con
minor numeri infinitesimali, che si può ottenere con modesti
accorgimenti centesimali ( ad es: 500: 3 – sarà 501: 3 = 167 )
quando è possibile. È altrimenti sufficiente anche il quoziente a
meno di un millesimo, meglio se ottenibile con una buona
calcolatrice. Principiamo dal rapporto di due lati corrispondenti
AB:BC, che sono, ad esempio, l'altezza della statua m. 6 e quella del
modello m. 1,20. Osserviamo che tutte le parallele a BC mantengono un
valore costante nel rapporto con il corrispondente in AB: ciò
significa che tutte le misure prese dal modello mantengono,in
proporzione, lo stesso costante rapporto di similitudine. Infatti m.
6: 1,20 = 5, che è il quoto costante di ogni rapporto di
similitudine: per cui una misura dal modello es. di cm 70 sarà cm.
70x 5 = cm 350 che dovrà essere riportata sul blocco. Ma in che
modo? Negli esempi precedenti, abbiamo ridotto il triangolo di
proporzione di 1/3 o di 1/2; e possiamo dividerlo ancora a seconda
delle esigenze lavorative. La soluzione che si propone, di fronte a
misure sovra dimensionate, riduce il trasporto delle lunghezze,
applicando una tecnica semplice e diretta. Data una statua di m. 6 e
di un modello di m. 1.20, si prendono dei compassi grandi( maranghino
) ed un metro a nastro di acciaio, flessometro, che una volta
srotolato gli consente di mantenere una certa rigidità, e può
essere utilizzato come se fosse una riga flessibile. Così si
comincia così il lavoro: - si svolge e si fissa il metro , per tutta
la lunghezza necessaria a riportare i primi capi-punto: nell'esempio
dianzi citato, poco oltre m. 6, per agevolare le misure, 1-2-3-4,
iniziali, da prendersi con il maranghino; - si è detto che il valore
del quoziente è 5; perciò ogni misura presa dal modello va
moltiplicata per 5. Poniamo sia cm. 73, avremo una misura di cm. 73 x
5 = cm 367,5, che con l'apertura del maranghino la prenderemo sul
metro. Si è già accennato al trasporto, a rovescio, di un punto dal
marmo al modello, utilizzando la larghezza esistente ( partendo quasi
fatti, se il materiale da togliere non è eccessivo ). Con questa
tecnica, tutto è molto più facile: supponiamo, a mo'
di
esempio, che la distanza tra il 3° e 4° punto, la larghezza, sia,
nel blocco, di cm 275; fatte le dovute intersezioni, se riportiamo il
4° capo-punto sul modello, non abbiamo che da dividere per 5 ( cm
275 : 5 = cm 55 ). Il capo-punto 4 può essere fissato direttamente
sul " gesso", oppure su un frammento di "marmetta",
allineato sul rettangolo perimetrale, che è segnato intorno al
modello come una cornice, nel contesto delle linee e dei supporti
(capi-punto ). Il rettangolo prefigura, in proporzione, lo stesso
parallelepipedo ( la sua base ) delineato dal marmo. Quindi,
compatibile con le distanze del perimetro già definite intorno al
modello. Se non vi sono queste condizioni, troppa "roba ",
si toglie il marmo necessario.
L'utilizzo
della calcolatrice
Si
è accennato ai numeri interi ed infinitesimali come quoto, è raro
che non si possa aggiungere o togliere qualche centimetro per
calcolare un numero intero ( es. cm 605 : 121 = 5; oppure cm 601 :
120,2 = 5 ); ma quando ciò non è possibile, non cambia nulla,
poiché sono due grandezze omogenee ( uniformi ). In questo esempio,
cm 601 : 120 = 5.008333333: il quoto divide e moltiplica, nella
stessa maniera, come indicato in quelli precedenti. Se vi sono dubbi
o difficoltà si può sempre effettuare un semplice controllo, con il
supporto grafico dei triangoli sotto dimensionati, ridotti ad un 1/3
o 1/2, già menzionati nel capitolo precedente.
LE
SQUADRE DEL VASARI
“
Volendo
ringrandirlo”, il modello, bisogna che ai piedi del blocco (la
statua) sia applicata, orizzontalmente, un braccio della squadra,
della quale, l'altro vada in alto, e prosegua fino alla testa della
figura. La condizione è quella che “ si tenga sempre il fermo del
piano” (rispetto a quello del modello e della sua riproduzione).
Queste sono le indicazioni che consentono di effettuare, anche
secondo il Vasari, una corretta smodellatura priva di rattoppi. E'
difficile immaginare, con certezza, la fattura e posizione delle
squadre descritte nelle “Vite” dal Vasari, a quale tecnica o
proporzione si riferisse, “volendo ringrandirlo – il modello –
a proporzione nel marmo”....
Questa
tecnica non è certamente rappresentata da una incisione del
Carradori, come in alcuni casi è stato erroneamente pubblicato, dove
si espone una tecnica simile a quella, da noi oggi, detta del telaio
(non in maniera certa delle squadre). Osserviamo che, in moltissime
incisioni e foto, sono raffigurate le “gabbie”, dette appunto
squadre, molto simili a delle cornici dove si incastrano quadri, che
sono fissate ortogonalmente alla parete con un lato, e mostrano
aggettanti i tre restanti, parallelamente al piano terra, per
consentire che, dal filo a piombo, si possano misurare le distanze
delle cale. Queste tecniche, in disuso e migliorate con innovazioni
che sfruttano gli stessi principi della similitudine tra i piani,
sono già superate con il concorso di moderni macchinari : si è già
detto dei tagli funzionali, con l'utilizzo di varie tagliatrici o del
filo diamantato; tagli a ridosso del lavoro da farsi, sempre secondo
proporzione. E non è detto che per lavori di pregio e raffinati
ricami, in particolare su invasi, di varie forme e ricchi di ornato
non ci si possa avvalere di tecniche identiche nella sostanza, come
quella detta del telaio in un capitolo già ampiamente descritta.
Fondamentale resta il piano di partenza stabilito e, come dianzi
detto, il disgrossamènto del blocco.
Di
seguito proponiamo alcuni modesti disegni, al seguito delle
descrizioni dianzi accennate, per soddisfare la vostra e nostra
curiosità. La novità che dette squadre potrebbero essere
utilizzate, al meglio, per una produzione seriale, considerati i
tempi di preparazione che richiedono: quelli di falegnameria e
l'incisione dei rapporti, fissi, in scala. E' chiaro che anche in
queste squadre si privilegia il punto di vista frontale, considerando
che la loro impostazione e funzione è uguale alla crocetta di
appoggio del pantografo. La partenza è sempre predisposta con i
compassi, iniziando sempre da piani di riferimento, con l'immediato
vantaggio della disponibilità di un telaio, i cui incroci
riferiscono immediate intersezioni, e disponibilità di cale prese
dalla corda o da un listello. I compassi lavorano, inizialmente,
partendo dal primo spigolo delle traverse, o dalla mezzeria, dove
incrociano le tacche. Nella prassi, al di là della produzione
seriale dianzi riferita, ci sembra migliore l'approccio diretto con i
compassi, evitando siffatti marchingegni, salvo complesse e minuziose
lavorazioni.
LARDO
DI COLONNATA
UN
TRONO PER RE MORTAIO
COMUNE
DI CARRARA
Il
progetto riguarda un mobile in legno pregiato ( la cui tessitura
dovrà giocare in armonia con il marmo di Carrara ; quello detto dei
"Canaloni"). Nella forma cilindrica del " legno "
, leggermente svasata in alto ed in basso, avrà sede , nell'affusto,
IL MORTAIO. Questi, nella sua realizzazione, risulterà più pesante
e sovradimensionato di quello tradizionale ( con una variazione nelle
orecchie, che non saranno stondate, ma a coda di rondine). Detto
mobile è facilmente spostabile, mediante l'applicazione, alla base,
di piccole e robuste ruote, che sono il supporto convenzionale di
oggetti similari. Il mortaio, come " la conca del lardo ",
è utilizzabile, oltre che per la produzione di pesto, salse e aromi
naturali, in funzione di capiente contenitore. Infatti, il piano del
mobile, sotto la campana di vetro, delimita lo spazio di un vassoio
per bolliti, pesce, più varietà di insalate, ecc. Il tutto da
spalmare con pesto, oli e condimenti vari. Nella "ciambella che
corona il fusto sono ritagliate delle nicchie dove alloggeranno
vasetti ( possibilmente di marmo o ceramica) ed eleganti
bottigliette. Mentre la tavola in legno, che chiude ermeticamente la
bocca del mortaio, ha la funzione di un comune tagliere ( per tutti i
cibi ); anche per un tritato di prezzemolo ed altri odori, richiesto,
seduta stante, nel servizio ai tavoli.
IL
RE MORTAIO, come la conca per il lardo, fa parte, a pieno titolo,
della tradizione Carrarese e si è sempre presentato nudo nella sua
forma originale. Oggi, lo riteniamo meritevole di posizionarsi su un
trono di legno pregiato. Insomma, è degno di indossare un vestito
adeguato, considerato che ha ospitato, un tempo, il cibo più povero
e di largo consumo ( il lardo in sostituzione del più costoso olio).
Il riferimento è alla preparazione di soffritti vari, in particolare
all'insaporimento unico ed indispensabile dei popolari taglierini nei
fagioli; oppure per rafforzare il nutrimento di chi era costretto ad
una dieta misera: si riduceva il lardo in una poltiglia quasi
liquida, da ingerire come ricostituente. I mortai, nella loro
infinita varietà, si nominano dalla misura del loro maggior diametro
( preso sull'orlo esterno dell'invaso ). Considerati fra le più
umili lavorazioni del marmo, oggi , non sono più la cenerentola
degli elaborati. Uno studio più attento li ha rivalutati,
considerando le loro proporzioni: le misure delle varie parti
costituiscono un vero e proprio canone. Anche le varie fasi delle
loro elaborazione ne rappresentano, nei vari passaggi, metodi ed
approcci di pari dignità con l'ornato e la scultura.
ANONIMO.
PROVA
STRUTTURALE DI DISCIPLINE PLASTICHE
LA
SCULTURA - L'INTAGLIO.
D'acchito,
se ci domandano cos'è l'intaglio, ognuno di noi pensa,
nell'immediato, ad un lavoro decorativo, o ad un'arte minore,
finanche ad un'iscrizione nel marmo. Subentra dopo, la convinzione
che sia arte o lavoro antichissimo dello scolpire, in alto o
bassorilievo; non solo in legni pregiati, ma pietre dure e marmo.
Così si apre la mia prima riflessione, che parla di un'antichissima
civiltà, l'Egitto, dove con un linguaggio ed uno stile singolare, i
rilevi campeggiano sia nei templi sia nelle stele sepolcrali: sono
incisioni profonde disegnate su un piano non modificato. Certo, in
questo periodo, non mancano lavori d'intaglio su materiali pregiati (
legno, avorio ), precursori di quell'arte che caratterizzerà altri
contesti storico- -culturali, fino ai giorni nostri.
I
Rilievi (differenze ).
L'alto
rilievo, molto sollevato dal piano, annulla, quasi del tutto, la
gradazione prospettica dei volumi: Il bassorilievo è il suo opposto:
infatti le figure, seguendo il degradare dei piani, sono scolpite
con grande diminuzione dello spessore stesso, fino ad affiorare, più
o meno, dal piano dello sfondo, delineando un singolare campo
prospettico. Il modellato segue, quindi, un suo plasticismo ed un
suo stile o tecnica, cosicché il movimento e la profondità dei
piani, come le zone di luce e di ombra, possono esprimersi in diversi
spessori, basso o medio. Una considerazione a parte merita lo
schiacciato: è una tecnica che deforma le figure in larghezza, dando
loro potenza ( es. La Madonna della scala di Michelangelo ).
Il
Tutto Tondo ( sculture ornamentali e decorative ).
Ma
qual'è, in effetti, la differenza tra sculture ornamentali e
decorative, perché le ho distinte nella domanda? Fin'ora, il
concetto mi è sempre stato chiaro: ornare e decorare significa
abbellire. Che senso ha distinguerli? Provo ad approfondire, mi
immergo in alcune riflessioni che, subito, mi sembrano forzate. Non
mi convincono i due concetti “ ornamentali e decorative “,
indipendenti tra loro, che possono essere riferiti a qualsiasi arte o
tecnica. Si insinua forse una subordinazione della scultura
all'architettura? O al contrario, vi può essere, alla pari,
autonomia e complementarietà? Non sono entrambe forme e invenzioni
dell'artista? In altri termini, nella visione michelangiolesca
l'architettura è costituita da parti “soprammesse” ( per via di
porre ): all'opposto, le sculture, liberano le forme “per forza di
togliere“. Per Michelangelo non solo scultura e architettura sono
sullo stesso piano, ma egli, anche in architettura è essenzialmente
scultore. Entrambe sono un insieme plastico: cosicché, le sculture
che rappresentano una storia, fatti, persone, e l'architettura delle
funzioni, non sono altro che un rapporto, calcolato, di pieni e
vuoti. Per Michelangelo “la scultura non è subordinata
all'architettura, come nel medioevo; né, come nel primo
rinascimento, vive autonomamente (Verrocchio, Pollaiolo). In
Michelangelo l' una e l'altra hanno una sola matrice: sono forme (e
quindi idee) individuate dall'artista, o, meglio, «inventate»
(nel senso del latino, da invenio, «trovo» ) scoperte, messe alla
luce”. È il nocciolo della poetica Michelangiolesca: è la lotta
dell'uomo per la sua liberazione. È il motivo costante dell'opera
sua legata al non finito: dove tutto è possibile, avveniristico,
nella quale già il segno, quello dei ferri, tracciato dalla
estemporanea maestria della mano, mostra volutamente reinventandoli i
contenuti. È l'idea che si forma, mano a mano, con un'espressione
strutturata che partorisce, e mentre nasce, costruisce e trasforma in
un modo diverso l'universalità delle cose. Questa è l'estetica di
Michelangelo la bellezza di un'opera che esprime, in ogni momento,
tutto il senso in se stessa: poiché tutto è in pregiudicato, nulla
è certo; come lo è la perenne lotta dell'uomo nel dare un senso
alla propria esistenza.
Spulciamo
un'altra sottile differenza. Se voglio rendere piacevole ed
esteticamente prezioso la parte di una chiesa o palazzo, posso
limitarmi ad uno o più particolari. Ma se mi pongo un'idea
ornamentale, che è essa stessa stile e linguaggio, coerente con
l'insieme delle funzioni e significati, ho concepito qualcosa che è
parte essenziale di un contesto, senza la quale, questi, perderebbe
forza espressiva ( Sacrestia nuova, Basilica di San Lorenzo ).
Riaffermando anzitutto che, l'architettura, la sua storia, altro non
è che la storia delle concezioni spaziali: “ il giudizio
architettonico è fondamentalmente un giudizio sullo spazio interno
degli edifici. E se il giudizio non si può dare per mancanza di
spazio interno, questo rientra nella storia della scultura”, che è
essenzialmente porzioni di spazio o prolungamento di volumi. E non è
detto che il valore di una qualsiasi opera architettonica si
esaurisca nel solo valore spaziale. A mo' di esempio: “ ogni
edificio è caratterizzato da una pluralità di valori: economici,
sociali, tecnici, funzionali, artistici spaziali e decorativi, e
ognuno è padronissimo di scrivere storie economiche
dell'architettura, storie sociali, storie tecniche e volumetriche”.
La realtà di un edificio è conseguenza di tutti questi fattori, ed
una sua storia valida non può dimenticarne nessuno. “ E' anche
vero che uno spazio soddisfacente, se non è sostenuto da una
adeguata trattazione delle pareti che lo racchiudono (bella
decorazione ), non crea un ambiente artistico”. Un'altra
considerazione ai margini, è che, comunque, ornamenti e decorazioni,
richiamano e alludono ad una supremazia. La Chiesa li ha sempre
inculcati per imporre significati, verità divine, per ammonire o
impaurire il popolo, il quale mentre riceveva prediche e sermoni si
trovava contornato da moltitudini di simboli e rappresentazioni.
Ciò
sembra sottendere una funzione didattica, al fine di educare ed
influenzare. Ciò riguarda le immagini simbolo, astrazione
simboliche, decodificate in ogni forma di linguaggio, per renderlo
funzionale ai valori che si intendono trasmettere, con immagini
emozionali e costanti riferimenti al soprannaturale. E' il programma
della Controriforma, rivolta al popolo ignorante, insistendo sul
valore didascalico e propagandistico delle arti figurative. La Chiesa
diffonde il proprio messaggio sul cattolicesimo. Esemplare l'arte
Barocca, arte teatrale volta a stupire e impressionare le masse. Non
dimentichiamoci dell'immenso patrimonio artistico, culturale e anche
religioso, che queste vicende storiche hanno lasciato all'umanità.
SCULTURE
MONUMENTALI ARCHITETTONICHE
Quelle
monumentali assolvono una funzione specifica, indicando una
appartenenza , possono rappresentare un evento, un episodio storico,
un personaggio insigne ( a Manzoni, Leopardi, Foscolo ).
Quelle
architettoniche sono, spesso, grandi complessi: ponti, templi, gran
parte della architettura moderna: ammirevole Le Corbusier e la sua
famosa definizione: “L'architettura è un gioco sapiente e
meraviglioso di volumi composti sotto la luce”. Qui si ricorda una
grande “scultura” astratta: La Cappella di Notre Dame-du-Hult in
Francia; un'altra è La Filarmonica di Berlino di Hans Sharoun.
Quindi, penso sempre riferiti all'architettura/scultura – si dice
-, “moltissimi possono essere gli esempi, di cattedrali e templi,
bellissimi quelli indiani a forma piramidale. Vi sono persino interni
e tanta parte dell'arredamento moderno che hanno forme scultoree”.
Sarebbe ardito obiettare che in detti complessi architettonici non vi
siano spazi, nel rarissimo caso esorbitano dalla storia
dell'architettura, come l'Arco di Tito, la Colonna Traiana, una
Fontana del Bernini, appartenendo per specificità e competenza,
molto di più alla scultura, e come valore intrinseco, ad un
conclamato valore urbanistico.
Ha
ragione Bruno Zevi: “ la verità è che gli edifici sono giudicati
come fossero delle sculture e delle pitture, cioè esternamente e
superficialmente, come puri fenomeni plastici, riducendo tutto a
valori pittorici. E' un errore, anche la scultura solo raramente è
riconducibile a questi (molte delle sculture di G. L. Bernini ).
L'architettura è diversa dalla scultura e dalla pittura, nonostante
che, forzatamente modernamente, la si sia assimilata a tutte le
altre arti figurative. Lo è per diversità tecnica e di linguaggio,
ma si è voluto interpretare, il suo volume edilizio, come la
configurazione di un'opera scultorea: nella pittura moderna,
l'artista stilizza l'umano, lo sintetizza e semplifica fino a
renderlo, nella rappresentazione, simile ad una realtà
architettonica. Perdiamo di vista una gerarchia di valori: lo spazio,
il vuoto, è il vero protagonista della nostra storia: perché
l'architettura non è solo arte, ma è il vissuto di tutti noi una
concezione estetica, è l'ambiente del nostro eterno presente,
all'interno del quale si svolge la nostra vita. Ogni volume edilizio
rappresenta la creazione di due spazi: quelli interni,
architettonicamente ben definiti; gli altri, esterni, in continuità
con il gioco delle opere urbanistiche attigue e loro prolungamenti”.
Diverso, invece, è il godimento nell'intaglio; diversa è
l'emozione, subitanea, nello scoprire volumi ( letterale: portarli,
gradualmente, alla luce ), e nel realizzo delle forme volute
(fortemente e passionalmente). Qui, manualità e spiritualità si
fondono in un unico sentire, poiché sono in composizione con la
materia stessa ( e nel vedere già dentro di essa la futura creazione
).
OPERE
REALIZZATE E DI SEGUITO DESCRITTE
(
tutte facenti parte di collezioni private ).
ARA
GAUDIUM
Concordiamo,
ma amiamo anche un'altra virtù, elevandola al di sopra della
volgarità dei nomi. Sognare e stupirsi sempre, con l'entusiasmo e la
capacità tipica dei bambini: semplicemente; come fosse la prima
volta, davanti a tutte le cose del mondo, nell'integrità di tutte le
sue suggestioni e visioni, per liberarci dalla contaminazione di
schemi razionali. Occorre riscoprire il fanciullino che è in noi
nell'unità del corpo e dello spirito, nelle novità delle
esperienze, nelle sue forme di dolcezza e bramosia; così come
vengono dal profondo delle viscere. La realizzazione dell'Ara Gaudium
in pietre lavorate è composta di piccoli oggetti da toeletta, per
rimestare, spalmare e sfarinare, sia le creme per la cura del corpo
che i pigmenti per l'arte del trucco. Il presente elaborato ( Ara
Gaudium), segnala una consuetudine che ha accompagnato la vita
pubblica di antiche civiltà: dagli Egiziani ai Persiani, dai Greci
ai Romani ; e come unguenti, profumi e trucchi scandivano le mode ed
i lussi del tempo: usi estetici, estatici e di godimento che i
costumi riproponevano ciclicamente. (Le stesse pietre mantengono il
valore simbolico dei popoli antichi : " si riteneva che esse
segnassero la casa degli Dei ". Sono consistenti Archetipi -
rappresentazioni dello inconscio di esperienze primordiali comuni a
tutti gli uomini - che esercitano una enorme influenza su di noi ).
Perciò detto, dichiariamo la nostra devozione a Dioniso, non il
Bacco ubriacone, interessati di più all'ebbrezza mentale. L'oggetto
della nostra filosofia è il "desiderio", il liberarsi di
colpo dalle preoccupazioni quotidiane, regalandoci momenti di
raccoglimento e riflessione, dedicando molta attenzione alla cura del
nostro corpo: per ritrovarsi nell'ebbrezza fisica ed intellettuale,
confacente al bisogno estatico e del godimento. " E' quasi un
rituale doveroso, in tutte le comunità civilizzate rapidamente,
conservare l'amore per il primitivo, il desiderio di condurre un
genere di vita più istintivo e passionale; diverso da quello
sanzionato dalla morale corrente". Dobbiamo essere capaci di
osservare meglio e di più le cose che ci circondano, i loro colori,
la quantità di luce riflessa, lo spazio che occupano; oppure come da
questi si lasciano invadere. Infine, le sensazioni al tatto delle
loro forme, secondo la consistenza materica o la qualità dei
rilievi; poi la lucidità, il messaggio lascivo, per la piacevolezza
nel maneggiarne la loro forma e textura. Ognuno vede e sente ciò che
sa : percepiamo la forma secondo la nostra esperienza personale.
Passionalmente immaginiamo ciò che non è raffigurato; e
raffiguriamo ciò che non è descritto. È
un esperimento che amiamo proporre simbolicamente nella scultura e
nell'architettura come oggetti del, e, per il desiderio . Percepiamo
l'uomo su un piano diverso, nel sentire e nella condotta. Questa
reazione del pensiero e dei sentimenti ci porta a recepire questi
semplici versi:
SEI
ANCORA QUELLO DELLA PIETRA
E
DELLA FIONDA, UOMO DEL MIO TEMPO...
S.
QUASIMODO.
IL
TALLONE DI ACHILLE
Il
presente è l'unico piede che può segnare una rete a " Gigi
Buffon ", di tacco però, esclusivamente! Il soggetto, facezie a
parte, è quasi sempre un pretesto per esprimere diverse sensibilità.
Volutamente, il lavoro non è tratto da un unico blocco di marmo,
ricco di tutte le sue qualità. Ho assemblato materiali poveri: un
composto di oggetti che possiamo aver maneggiato e/o incontrato nel
tempo, e per tanto presenti nella nostra memoria, familiarmente. Il
piede in marmo fu, quasi certamente, una scaglia o uno scarto di
un'opera più grande. Raccolto a valle del 'Carrione', aveva preso,
grossolanamente, quella forma, dopo aver ruzzolato lungamente durante
le fiumane: sono stati sufficienti pochi ritocchi per raffinarlo.
Così pure la suola del sandalo o la base stessa, sono stati presi da
un vecchio rifugio diroccato sull'Alpe, poi rielaborati. L'uno, la
piastra, costituiva parte del tetto; l'altro un vecchio scalino
penzolante. Sono tutti oggetti che esprimono un vissuto ed una
memoria popolare della nostra città. È
questo il " Presente " , genuino, che mi permetto di
porgerti, nell'intento di ricordare il compiacimento di tutta la
città, dopo i recenti mondiali di calcio; ma anche e,
contemporaneamente, a tutta la tua meravigliosa famiglia, verso la
quale i Carraresi, quelli veri, nutrono grande stima e simpatia.
AFFETTUOSAMENTE:
L'APUANO
( IL GIOVANE )
IPSIA
MARMO
Programma.
La
scuola del marmo, dalla sua antica atipicità ( di arti e mestieri )
ad oggi, dovrebbe aver smarrito qualcosa della sua ricchezza
originaria, se le iscrizioni scolastiche registrano preoccupanti
abbandoni. Ricordiamo un consiglio datato ma attuale: “Quando
personalità, società od istituzioni, soffrono un periodo di crisi,
occorre che ritornino ai loro sani principi, a quel periodo aureo e
di manifesta affermazione e radicamento. Ovviamente, nella loro
realtà territoriale come nel sentire della gente”. Si è detto e
ripetuto, più volte, “ sull'unicità “ di questo Istituto (
unico al mondo ); vediamo meglio di cosa si tratta: - di una
formazione didattica e/o professionale qualificata?; - di uno
sviluppo, alto, inerente le capacità interpretative nella
riproduzione di opere o copie artistiche? Oppure l'abbandono di tutto
questo, nella esclusiva affermazione del solo “mestiere”,
meccanicamente inteso; o, ancora, semplicemente aspettativa
funzionale ad un impiego qualsiasi, con un'istruzione fine a se
stessa e genericamente intesa, acquisendo un diploma? Ripensare alla
nostra storia, alla dedizione di intere generazioni di famiglie
carraresi vissuta nel patrimonio di laboratori e botteghe ; ripensare
alla loro abilità e sensibilità artistica ed artigianale ci
inorgoglisce: soprattutto se ne consideriamo la capacità
interpretativa. Capacità che contiene in sé un indubbio valore
segnico, manifestato con un notevole apporto creativo ed un concorso
di idee. ( Ed è in questo contesto di collaborazione, quello “tra
ideatore ed esecutore”, la prova provata sia delle soventi
correzioni sui modelli originali, sia del contributo di alta maestria
raggiunto dagli scultori carraresi nella veicolazione delle opere
d'arte). Quindi non necessitiamo di un contributo, e di un diploma,
fine a se stesso; ma di alcune iniziative e pulsioni che individuano,
nell'antica filiera, i suoi punti di forza. Istruzione e mestieri
possono compenetrarsi: l'unicità di tutto questo, è portare la
fabbrica nella scuola, consapevoli di operare nel contesto di un
territorio ricco di imprese e con una pesante storia sulle spalle. Ma
di tutto questo nessuno si rende conto, così come non esiste una
regia, un collegamento efficace tra le varie realtà; eppure il
termine “ far sistema “ , vacuo quanto mai, continua, di bocca in
bocca, il suo giro trionfale tra simposi, seminari ed altro ancora.
Indichiamo un programma minimo, per attualizzare e pubblicizzare il
ruolo dell' IPSIA nel contesto della realtà sociale ed economica
della città. Se si va al cuore del problema , non si può non
rilevare la endemica scarsità di adesioni da parte dei giovani. E'
il sintomo di legittime aspettativa non soddisfatte? siano esse
occupazionali o deludenti nelle molteplici aspirazioni individuali ed
artistiche.
2
-
Detto
programma può riprendere l'iniziale filiera del mestiere della
scultura, partendo da alcune iniziative elementari : Fuori programma,
ma degno di futura considerazione, il disegno di figura ed anche di
progettazione, con corsi adeguati: il disegno di figura utilissimo
allo scolpire; il progetto, per impostare e preventivare un lavoro.
Iniziare con le vecchie tecniche: dallo scandagliare alla sbozzatura,
all'utilizzo del pantografo e dei compassi e loro tecniche ( angolo
di proporzione, telaio e squadre, puntoni ). Prevedendo di utilizzare
il contributo di figure esterne, artigiani e mestieranti, per
mutuarne le esperienze migliori.
organizzare
un minimo di attrezzatura da officina, necessaria alla fase
preparatoria di ogni lavoro; installare una “ forgia “, per
ottenere una tempera migliore dei ferri adeguandola al lavoro da
farsi ed all'uso personale; inoltre consentirci una conoscenza
migliore dell'intaglio, soprattutto nella fase di rifinitura.
Tecniche
di rifinitura
1.Importantissima
per una perfetta esecuzione dell'opera, la rifinitura è un tantino
in ombra rispetto alle precedenti fasi di lavorazione. Gli studenti
riescono, anche i meno bravi, a portare a termine la fase di
smodellatura; e se non sempre terminano questa fase in maniera
soddisfacente, ancor meno lo è il lavoro di impasto e rifinitura
dell'opera. Viene così mortificata una specificità del marmo:
quella di essere levigato/lucidato in stadi diversi ( a seconda che
si voglia maggior opacità o lucentezza ); o quella di esaltare ora i
chiari ora gli scuri; ora le linee od una maggiore plasticità, a
seconda della lavorazione. Così come nel disegno, pittura e
architettura, anche nella scultura è importante la pelle o la
texture voluta, effettuata dai passaggi con subbia, gradine,
scalpello, smerigli ecc.. Il non finito può esservi compreso
dall'esecutore, secondo i suoi intendimenti artistici. Prevediamo,
che le tecniche adottate ed il lavoro svolto, possano essere oggetto
della pubblicazione di un libro di testo e di un CD, per documentare
tutti i vari passaggi di studio e di lavoro del “mestiere”,
facilitandone così la comprensione. Con questa modesta iniziativa
auspichiamo maggiore attenzione da parte della città e delle sue
istituzioni; è il nostro messaggio che non demorde, sulla
prestigiosità ed originalità della scuola del marmo. Non secondario
è l'intento di stimolare adesioni e contributi.
OCELOT
( OCELOTTO ) : Il dono, in pietra, e' l'interpretazione di una copia
dell'originale.
Simbolo
di una divinità, rappresenta una casta di guerrieri aztechi.
Raggomitolato su se stesso in una tensione aggressiva, l'ocelot, il
selvaggio felino è comunque il simbolo perfetto di un ordine
militare. Nel mio sentire , al di là della simbologia, è
nell'originale, spero anche nella copia, una rappresentazione di
carattere e di forte e libera personalità. Per questi motivi lo
considero di buon auspicio, meritevole di esempio nell'avvenire di
ognuno : l' ocelot sa lottare pericolosamente, in armonia con
l'ambiente in cui vive.
LO
CONSIDERO UN PORTAFORTUNA, UN AMULETO, INSOMMA!
Questo
enorme gattone mi ha ispirato perché lo trovo speculare ad una
massima di Pericle:
"
il segreto della felicità è la libertà. E il segreto della libertà
è il coraggio ". Augurandoci un felice futuro, almeno per un
altro secolo e rotti, spero che sia di tuo gradimento questo soggetto
delle civiltà Precolombiane.
Infinitamente
LA
VENERE DELLE APUANE
Venere,
dea della bellezza è assimilata alla greca Afrodite, concepita come
l'intima potenza animatrice e propiziatrice dell'attività creatrice
dell'uomo, sia nel mondo fisico sia in quello del pensiero e
dell'azione. E' anche garante del successo degli uomini politici.
Afrodite ( Venere ), particolarmente venerata a designare l'amore
celeste e l'amore terreno, cioè quello sacro e profano; dunque, Dea
della bellezza e dell'amore, nasce dalla spuma del mare: così com'è
dipinta dal Botticelli, mentre approda sulla valva di una grande
conchiglia, spinta da Zefiro, vento primaverile. In ogni Venere, la
bellezza e purezza del corpo, pur nella sua integralità e sacralità,
peserà quella voluttà e quella femminilità, che manifesterà
perennemente il segno del dominio: conquista, desiderio, profanità.
E' sufficiente richiamare un altro dipinto, contemporaneo alla “
Nascita di Venere “ del Botticelli, quello de “La fuga di
Nastagio”, per coinvolgere l'amara realtà sopra accennata: qui,
nel quadro, “il Cavaliere rincorre e sviscera la fanciulla che gli
si era rifiutata. Il tema coinvolge, da sempre, il tragitto
dell'umanità, rapportandola alla vita mondana, ben oltre la
felicità, i piaceri, la condizione naturale, i diritti della
persona. Rispetto alla pittura, è più difficile affidare, al freddo
marmo, tante palpitazioni ed un meglio connotato realismo. ( Una
materia, il marmo, anche essa carica di fatica e sudore, causa di
profonde ferite nel corpo sociale ). Ed ecco! per via del levare,
liberando progressivamente il masso, affinando il concetto, l'idea,
di questa Venere delle Apuane, legandola ai contenuti e forma dei “
Prigioni “di Michelangelo. Intrigare questa Venere, cogliendone il
momento dell'impaccio, nel togliere l'indumento bagnato e
strettamente fasciato al torace, è cogliere l'attimo di una
difficoltà temporanea con il proprio essere. Vieppiù, l'impedimento
si manifesta annodando le braccia a fiocco, appesantendo il movimento
con quel anfratto di conchiglia, sulle spalle.
Spogliarsi
del fastidioso ostacolo suggerisce una dipendenza invisa da qualcuno
o da qualcosa: suggerisce l'ansia di una liberazione comunque ed
ovunque, sulla pelle del proprio corpo, spiritualmente e
materialmente.
Apuania,
28.12.2009.
L'APUANO
( il giovane )
ESTASI
DELLA LIBERTA'
L'ESTASI
DELLA LIBERTA'
Rivisitando
Brancusi, lo scultore, nella presente opera, studia e ripropone una
diversa versione della sua Mademoiselle Pogany. Riconsiderandone,
di questa, la purezza nella sua forma perfetta, simile ad altre
opere del Maestro, nelle quali, servendosi di un modulo
ovaleggiante, ricerca e trova, astraendoli, gli effetti più puri ed
assoluti della materia , come i volumi, le linee, i ritmi.
Cosìcché , la testa di donna, titolata Estasi della Libertà,
ispirandosi a Mademoiselle Pogany reinventa, immodestamente, il
soggetto ed il linguaggio, proponendo contenuti diversi e
fantasiosi: - una mano aperta, nell'atto di creare un volto, una
testa di donna. Una mano simbolica: laboriosa, amica, calda,
avvincente e sincera; gestante, nell'attimo di librare, nell'aria,
quei volumi, quelle linee, quel volto classicheggiante; - una mano
custode, nel segno dell'adattamento e della continuità. Il progresso
e l'appagamento sono nelle nostre mani.
Lo
scultore : L'Apuano (il giovane)
Apuania,
2000.
Materiale:
marmo statuario.
LA
MÙSA ADDORMENTATA .
Le
mùse - nella mitologia greco-romana - sono le nove dee che
proteggono le arti e le scienze.
IL
soggetto del sonno, come pretesto per aprirsi ai sogni, alle
allucinazioni, al mistero, non è nuovo, per visualizzare
l'inconscio attraverso immagini e sensazioni ( Goya e Redon,
assommano in sé la tendenza Romantica e l'estetica Simbolista );
ciò può anche rappresentare un'interfaccia carica di significati
simbolici ed espressivi ( Espressionismo ). Così come l'arte di
Brancusi astrae dalla realtà: infatti le sue opere sono
caratterizzate da una forte purezza espressiva, con
un'intenzionalità volutamente istintiva (lo scolpire direttamente,
ignorando qualsiasi modello ).
DESCRIZIONE
DELL'OPERA.
La
testa reclinata della mùsa addormentata sembra, più che un
coricarsi per un sereno riposo, l'espressione di un linguaggio, di
uno stile, ridotto all'essenziale, nella sua estrema sintesi, con
quelle sue forme pulite e allungate. L'opera, ispirandosi alla
purezza delle opere di Brancusi, tenta di riproporre un nuovo e
diverso primitivismo, connotato da un intenso richiamo all'oggi e
da una coerente libertà creativa. L'idea è quella di racchiudere
nell'iconica spiritualità di una singolare postura, il naturale
senso di estraneazione, quell'etereo sentimento di distacco dalla
realtà, così dolce in un momento di intimo abbandono . Questo
sognante formalismo emozionale, ha acceso la mia fantasia: quelle
braccia , diversamente posizionate, ricordano altre civiltà? altre
testimonianze? le rovine di Stonehenge? Forse.
Nulla
e può sminuire l'immensa capacità del sogno e dell'immaginazione,
nessun'altra realtà gli è pari, quantunque fosse rappresentato
l'universo stesso.
Perciò
quella testa adagiata sul piano delle mani, con la coppia
irregolare delle braccia, ripropone un pesante componimento
d'insieme, nell'incombenza di quell'abbandono, condizionato da una
profonda forza di gravità, nella similitudine metaforica delle
magiche ed enormi pietre di Stonehenge: enormi e sovrumane colonne
che sembrano offrire, con quell'architrave, un sofferto sacrificio
ad una qualche divinità delle galassie.
Lo
Scultore
L'Apuano
( Il Giovane )