LA COMPOSIZIONE
FORME CHIUSE FORME APERTE
A Carrara hanno lavorato e si sono formati in prestigiose botteghe e in un'eccellente Accademia, gran parte dei maggiori scultori di ogni epoca, educati all'affettività di un materiale vivente e di notevole personalità, il marmo! Un materiale che ha avuto la prima culla sulle falde del Monte Sacro ed è stato nutrito da una musa di nome Euritmia: “ la nascita di Euritmia avviene in Grecia, per indicare il bello soggettivamente condizionato, che non consiste nella armonica composizione delle parti di un oggetto, bensì nell'impressione di armoniosità che esso procura” . Non è chiaro cosa questo parto significhi, ma diamo per scontato che il verbo degli Dei è sempre enigmatico. Invece siamo certi che il bianco statuario di Carrara per sua natura si predispone, per le sue eccelse qualità, a rappresentare il bello ideale, comunque ad esprimere ogni cosa sublime. Sulle statue e sui monumenti scolpiti, nelle Apuane, desideriamo scrivere alcune pagine affinché si aprano al linguaggio dei sentimenti nelle arti figurative. Iniziamo con due termini a confronto, EURITMIA contrapposto a SIMMETRIA. E' evidente che la loro distinzione è molto sottile: la simmetria nasce dalla proporzione (accordo sulla totalità delle misure e giusta distribuzione dei moduli ); “l'euritmia è il bello e grato aspetto cagionato dalla disposizione delle membra”. Sembrerebbe che la prima sia riferita alla quantità e quest'ultima alla qualità. A parte che anche nel mondo antico i due termini tendevano ad assimilarsi; nel senso comune oggi per simmetria intendiamo una cosa diversa, siamo portati a concludere che due o più parti simmetriche sono uguali : spesso facciamo riferimento, tenendo conto della simmetria bilaterale del corpo umano, al piano sagittale mediano o piano di simmetria, utilissimo nell'avvio del lavoro di scultura. L'euritmia sarebbe un rinnovamento delle proporzioni del canone di Policleto. E' Lisippo che mette mano a correttivi parziali per migliorare il punto di vista dello spettatore e conquistare la profondità dello spazio (tridimensionalità). Nella veduta frontale dell'Apoxyòmenos, nonostante che dalla testa, più piccola, alle membra e a tutto il corpo, l'insieme sia più snello e sottile, rimane quel brutto scorcio del braccio destro. E' vero Lisippo tende al movimento e all'equilibrio instabile rispetto alla stabilità policletea: tutto il peso del corpo si sposta, bilanciandosi alternativamente sulle gambe (e quella destra si allarga un po' troppo), seguendo il movimento avanti/indietro dello strigìle, ma la visione che riassume tutte le altre, e rimane unica, è laterale anziché frontale. “ Una composizione sbilanciata, non da' un senso di sicurezza, di affermazione, trasmette casualità e precarietà ”. Siamo ancora lontani dal movimento di quelle linee forza dette serpentinate, che coinvolgono lo spettatore a girarci intorno e che si presenteranno come forme aperte: da “ Il Ratto delle Sabine a Il Mercurio del Giambologna ”. L'Apoxyòmenos non è una forma chiusa, rompe il parallelismo dei piani anteriore e posteriore, ma la vitalità delle masse muscolari è presente solo sulla schiena; infine, quelle braccia protese in avanti non sono esteticamente gradevoli. La dimostrazione più evidente l'abbiamo nei cosiddetti “Bronzi di Riace”, che precedono di molto l'epoca dell'Atleta di Lisippo. Essi sono bilanciati e ponderati come il Doriforo, ma ben più alti e più saldi al suolo , con una maggiore accentuazione delle masse muscolari ( qui è evidente la grande differenza, a livello artistico, tra i bronzi originali e tutte le copie pervenuteci dalle statue in marmo in epoca romana ). I Bronzi di Riace con la loro bellezza e assoluta vivacità, già enucleano che l'intimo ritmo può portare alla nascita della poesia nel processo creativo. E tutto questo è merito della sintesi di Policleto nello studio sui Kùroi e di averli razionalizzati e tradotti in un trattato. “ Il ritmo ha un ruolo fondamentale nella creazione dell'opera espressiva. Al pari della proporzione ne è un elemento imprescindibile, fino ad assumere esso stesso un valore creativo autonomo”. E' specifico il riferimento al Doriforo, “ che rappresenta l'ideale greco di coerenza razionale ...”ossia l'ideale di perfetta proporzionalità”. Per il medico Galeno ( II secolo d.C.), la bellezza consiste nell'armonica proporzione delle parti, di un dito rispetto all'altro, di tutte le dita rispetto alla mano, del resto della mano rispetto all'intero braccio, infine di tutte le parti a tutte le a altre...”, cioè un gradimento estetico dato dalla ripetizione armoniosa e continua di uno stesso modulo che diviene ritmo modulare . Mentre il chiasmo lo riteniamo un ritmo alternato, alla pari di spazi pieni e vuoti di un edificio. “ Questa corrispondenza da' ordine e varietà. “ Perciò i retori greci la paragonavano alla struttura di un periodo armonicamente costruito con quattro frasi giustapposte, perché quattro sono gli elementi fondamentali messi in relazione fra loro”. ( Un piacere, come leggere A. Manzoni ! ). Se il ritmo è alla base di molte forme espressive dell'uomo, e ne scandisce la stessa organizzazione della vita quotidiana, l'equilibrio stabile di Policleto, detto “ponderazione”, è una postura che, mantenendo la figura ben salda sulle gambe e il baricentro dentro la sua base di appoggio, non può che esprimere un atteggiamento di coerenza nel mantenere ferme le proprie prerogative. Se l'Apoxyòmenos rappresenta con la tridimensionalità l'esistenza concreta dell'uomo sulla terra, il Doriforo ben saldo sui piedi da l'idea di difendersi bene dalla precarietà della vita, esponendo la sua verità: “ perché la realtà molteplice che noi vediamo quotidianamente è solo un'apparenza transitoria è solo una copia dell'idea”. Quindi, è “ l'idea unica “ dell'arte greca che elevatasi dalla realtà perviene alla verità. In questo senso il ritmo è movimento, poiché è percepito, come una successione di eventi: quando questi si alternano con una certa regolarità; in quanto un sentire primigenio può precedere le forme espressive anticipando la nascita dell'idea e l'immagine.
Il Doriforo nella sua bellezza statica si riallaccia all'arcaismo e all'idealizzazione greca, osserva la realtà ma è contro l'apparenza, e tutto relaziona all'uomo eterno, immutabile, perfetto: "l'uomo è misura di tutte le cose." Resta un interrogativo di fondo sulla corrispondenza implicita del Chiasmo o Chiasma (incrocio a forma di X), perchè i greci la paragonavano a quattro frasi giustapposte?, mentre i latini parlano di "quadratio" , per indicare che quattro sono gli elementi messi in relazione tra loro. Si esaurisce tutto in questo contesto "l'ideale greco di coerenza razionale"
o va oltre? Secondo la tradizione medico greca la salute è data dall'equilibrio di quattro umori o sostanze fluide: SANGUE, FLEMMA, BILE GIALLA, BILE NERA, collegati secondo caratteristiche fisiologiche e predisposizioni intellettuali.
Per gli scrittori Arabi, collegamento con i quattro umori i quattro temperamenti: SANGUIGNO, FLEMMATICO, COLLERICO, MELANCONICO, e i quattro pianeti principali: GIOVE, SATURNO, MERCURIO, VENERE.
Nell'antichità, il numero QUATTRO ricorre insistentemente, sarà utopia rilevarne una qualche assonanza, ma alcuni dubbi ci sono tutti.
I SEGNI
Sulle tante opere dedotte dai testi d'arte, desideriamo fare alcune riflessioni sul linguaggio visuale. Anzitutto premettiamo una scheda didattica: “la figura umana ha una sua architettura espressa da forme standardizzate, organizzate da elementi geometrici e secondo le leggi della proporzione, in varie epoche stabilite. Sono figure geometriche derivanti dalle forme base, riconoscibili nel triangolo equilatero, il quadrato e il cerchio. Contestualmente, gli altri segni fondamentali del linguaggio e relazionati tra loro mediante la grammatica visuale, sono: il punto, la linea, la superficie, il volume, lo spazio, la luce, il colore. Alcuni di questi, dianzi detti, possono sembrare accostamenti impropri con la scultura e molto più affini alla pittura e al disegno, ma non è così. Oggi il linguaggio è un sistema di segni condivisi, non più riferito esclusivamente a quello verbale, ma comprende tutto un sistema di segni. E nonostante l'enorme portata comunicativa delle immagini è necessario acquisire tutti gli strumenti per interpretarle e leggerle se, gradualmente, si desidera scoprire la loro immensa potenzialità creativa. E' pur vero che ognuno di noi vede ciò che sa' e vi attribuisce un valore singolare, ma ci si può educare e imparare a saper leggere e interpretare. Nel contesto delle arti visuali si sappia almeno riconoscere le differenze elementari: ad esempio, per una scultura destinata agli spazi del territorio, si pensa che nella composizione si debba tener conto dei fattori esterni, quali la morfologia del territorio, il tessuto urbanistico, la preesistenza di vincoli naturali, rispetto ad altre inserite in contesti diversi. Dunque, se i segni utilizzati dal linguaggio si differenziano, in vari sistemi, allora è meglio chiarire subito che un segno è tale quando rimanda a qualcos'altro. Tali segni hanno una validità compositiva plurima, concorrono e si relazionano tra loro donandoci una sensazione di armonia; non a caso le opere figurative stimolano in noi una emozione estetica. Proviamo, nella scultura, a tracciare alcune parti con la gradina e/o la subbia, contrapposte ad altre levigate o lucide, il contrasto è evidente e non è molto dissimile dal tratteggio di un buon disegno. Oppure ricavare delle ombreggiature scavando nel marmo e accostandolo al chiaro dei rilievi. Così come si possono ottenere superfici texturizzate composte da segni organizzati, uguali o simili accostati, intrecciati in maniera casuale o disposti ritmicamente in modo da formare reticoli omogenei. Infine renderle morbide e sinuose, predisponendo linee sfuggenti, nel panneggio come in alcune o tutte le parti anatomiche. Il senso di questo nostro ultimo approfondimento è supportato dall'opera del ticinese Stefano Maderno, Santa Cecilia Roma, 1600. “Il marmo sembra privato della sua consistenza di materia, percorso in superficie da marcati andamenti lineari, continui e fluenti ( la Santa è coricata su un fianco, le braccia allungate lungo il corpo in linea con le gambe, seguono il panneggio ed il copricapo nel copioso defluire verso l'imbuto dei piedi, NDR ). I rilevi tracciati lungo i panneggi delle stoffe conferiscono all'insieme un senso di controllato dinamismo e sembrano segnare le linee di forza della figura.” Interagendo, arbitrariamente e fantasiosamente, solo da un punto di vista tecnico, sull'espressività della statua di Maderno, potremo interrompere detto fluire inserendo un tratto di plasticità, a contrasto, esclusivamente per dimostrare le molteplici possibilità segniche disponibili. Guai farlo!, è brutto anche come paradòsso.
LE FORME BASE
“ Le forme geometriche elementari sono state considerate depositarie di significati legati a concetti di equilibrio e di perfezione, assumendo per questo un elevato valore simbolico”.
Alle forme base, in vari periodi, hanno attinto varie figure professionali ( scultori, architetti, pittori, ecc. ). “ Poiché sentirono che le figure geometriche non sono soltanto astrazioni matematiche, ma che hanno una loro vita, un'intima dinamica estetica, perciò hanno affidato all'equilibrio di quelle il loro messaggio espressivo”. “ E soprattutto a quella perfezione formale che richiede rigorosamente l'uso della riga, squadra e compassi”.
“ La figura geometrica può essere considerata da tre punti di vista, per rispondere a tre diverse finalità: a) in funzione di calcolo matematico; b) ai fini della costruzione pratica di un oggetto, c) in funzione puramente estetica”. Poniamo l'esclusivo interesse su quest'ultima impostazione, interessati solo alla composizione, in particolare al movimento e alla forma. L'artista, lo scultore, quando progetta una statua, utilizza le figure geometriche sul piano estetico, seguendo delle regole compositive diverse secondo la tecnica e la materia trattata: il marmo, il gesso, la creta ecc... Su identica sintonia, le luci, le ombre, i volumi, sono organizzati aderendo ad una stessa logica e stile, in modo da consentire una lettura organica della composizione visiva, tale da percepire la totalità dell'assetto dell'immagine e la genuinità del messaggio dato. Sia esso di movimento o staticità, di tensione e drammaticità o di un equilibrio armonicamente costruito. Non è esclusa la grandezza o dimensione della figura umana in rapporto alla spazio stabilito che può dilatarsi o restringersi a seconda dei rapporti tra pieni e vuoti (nicchia , facciata , pareti di interni organizzati).
L'atteggiamento della figura, in questo contesto, ha il compito di affidare alle linee principali la definizione della struttura portante dell'opera, essenziale nel determinare l'impianto compositivo. Non a caso abbiamo inserito, per meglio precisare, il rapporto tra significato, la mera espressione geometrica, e significante, cioè i simboli universali: il cerchio = l'infinito; il triangolo=concretezza; il quadrato= doppio triangolo, molteplicità delle cose; i quali fin dall'antichità hanno ispirato l'impianto di grandiose decorazioni, di monumenti e templi. Perciò “l'atteggiamento del corpo umano ha un valore essenziale fissato da assi ( andamenti verticali, obliqui, orizzontali) da parallelismi e angolature”, nel contesto di un susseguirsi di regole compositive maturate nei secoli e secondo i costumi, le correnti e le mode, che hanno via via caratterizzato il messaggio visivo. Dialoghiamo con due esemplari pittorici (affreschi): - Giotto, San Francesco dona il mantello. “E' una sapiente costruzione delle principali linee oblique che hanno origine nel centro in corrispondenza della testa, dove massima è la forza della composizione, e conseguentemente il suo centro virtuale nella confluenza dei crinali delle montagne” ; - Paolo Uccello, Giovanni Acuto. “La prospettiva è duplice: Il basamento è visto dal basso e il gruppo equestre ha il punto di vista all'altezza dell'osservatore. Tutto è sottoposto ad una rigorosa geometria: il rettangolo della composizione è diviso dalle diagonali e dalle linee di mezzeria orizzontale e verticale, che convergono al centro, separando il gruppo equestre dal basamento. Le forme principali del cavallo sono racchiuse in cerchi, mentre le zampe si dispongono secondo le direttrici diagonali.”
I valori espressivi hanno valenza universale, poiché il valore dell'armonia è comune a tutte le arti, nel linguaggio della scrittura, come nella musica, parimenti a quelli già citati. Ogni opera poggia sulla costruzione interiore degli artisti, oltre ad essere presente anche nella natura e negli oggetti o cose che provochino una sensazione. Queste sensazioni sono associate al movimento e all'armonia che proviamo nella vita quotidiana, insieme al ritmo che ha un ruolo fondamentale nella creazione dell'opera espressiva. E' sufficiente gustare i passaggi di un genio, Michelangelo, lo Stradivari Rinascimentale che, oltre a suonare meravigliose composizioni, fornisce modelli per arrivare alla perfezione costruttiva ed espressiva. Rivediamoci ogni tanto due rilievi marmorei, entrambi rappresentativi: la Madonna con il Bambino e San Giovannino (il Tondo Taddei e il Tondo Pitti).
Al pari della proporzione, il ritmo dell'immagine, che è movimento, è dato da una successione di segni, o di colori, o di forme ( in musica di suoni, nella danza di gesti), che si ripetono ad intervalli regolari. Il ritmo che è alla base di molte delle nostre forme espressive, percepisce i segni di un andamento che può essere misurato o sfumare all'infinito ( una fila di alberi o di case dileguarsi in una strada; un colonnato che scorre in un ambiente ). Ma anche la facciata di una basilica, i bassorilievi di monumenti grandiosi, o gli ampi e lunghissimi corridoi dei palazzi d'epoca, possono ospitare opere scultorie di ragguardevoli dimensioni. Qui da un punto di vista estetico si può giocare con le composizioni, secondo l'armonia e l'estro: sperimentare L'ALTERNANZA, soggetti e atteggiamenti diversi. LA SIMMETRIA, tra le pareti opposte del corridoio, o intorno ad un elemento architettonico ritenuto importante. LA PROGRESSIONE, altezza, profondità e scorcio di un'opera. LA CONVERGENZA O LA DIVERGENZA, intorno ad un nucleo centrale ( di tipo statico o dinamico, come abbiamo più volte illustrato). La stessa fuga di piani che, nella prospettiva degradano verso l'orizzonte, sono una possibilità espressiva utilizzata anche da Michelangelo, nella Madonna della Scala con la tecnica del rilievo “stiacciato” e l'idea di un centro ( dalla torsione del giovane sulla scala incombente a quella del Bambino in grembo); ma sopratutto ispirata all'altra idea geniale di Donatello, suo Maestro ideale, quella del rilievo marmoreo del basamento per il San Giorgio.
Oltre a questi altri elementi concorrono ad aumentare il valore emozionale in ogni opera d'arte. Riconsideriamo quelli dianzi espressi, quali la “ripetizione, l'alternanza, la simmetria; la progressione e la convergenza o divergenza”. Non è necessario neppure uno sforzo di fantasia per intuire che in una statua la posizione delle varie articolazioni del corpo o il loro bilanciamento possono assumere tutte queste posizioni, compreso l'equilibrio di gruppi di figure intorno al personaggio centrale. Altresì quando il segno vuole andare oltre il normale significato ed assumere un valore connotativo. E' il caso della molteplicità dei segni grafici e plastici utilizzabili, progetti di texture e di atteggiamenti amplissimi, compresi in incisioni variamente modulate. E' il caso di una ricerca accurata sulle potenzialità della materia, oltre il trattamento delle superfici, dove l'impasto della stessa ed il rapporto tra materia - luce - spazio è in grado di generare tutti i passaggi desiderati: vibrazioni e modulazioni, porosità o ruvidezze; e nel migliore dei casi il sempre armonioso segno dei ferri.
Ma in quanti modi (stili) si possono esprimere il movimento e la dinamica in un'opera, se molteplici sono gli atteggiamenti possibili della figura umana?, anche volendo definire solamente il carattere di una persona, la sua interiorità, nonché lo spirito; oppure la situazione spettacolare , partendo solamente dalla descrizione di alcuni degli atteggiamenti espressivi del volto, in sintonia con la conseguente motivazione anatomica complessiva? Motivare il dramma, la disperazione, il dolore profondo, significa contagiare la dinamica muscolare complessiva adeguandola a tale atteggiamento. Il migliore dei modi, per descriverli è senz'altro quello dell'osservazione e studio dei corpi viventi.
Eppure si parla da tempo anche di un linguaggio del movimento inteso come organizzazione di segni gestuali o motori o corporei: “ LINGUAGGIO MOTORIO, DEL CORPO, GESTUALE.
sabato 27 agosto 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


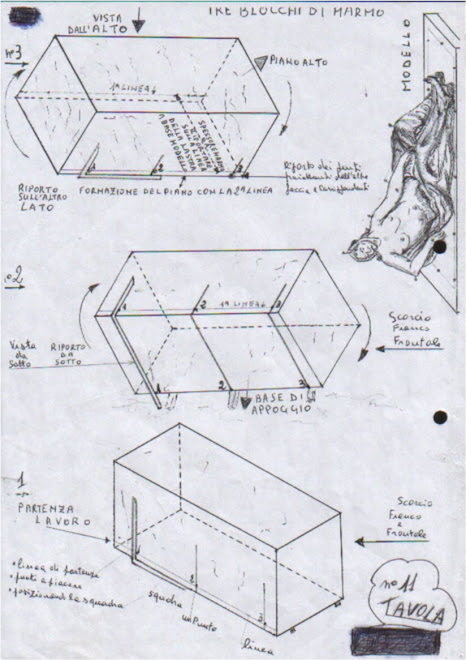


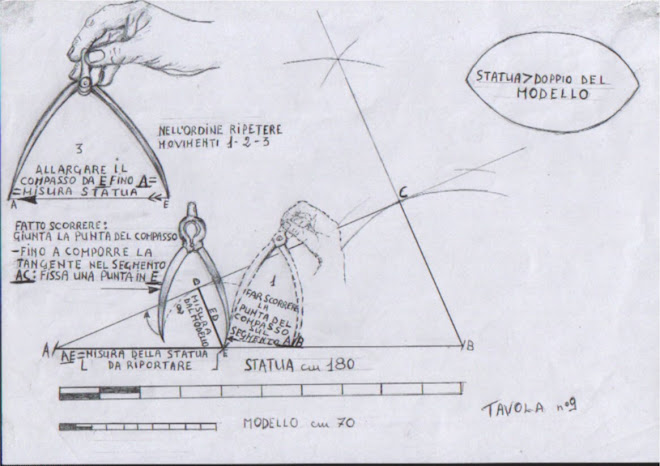
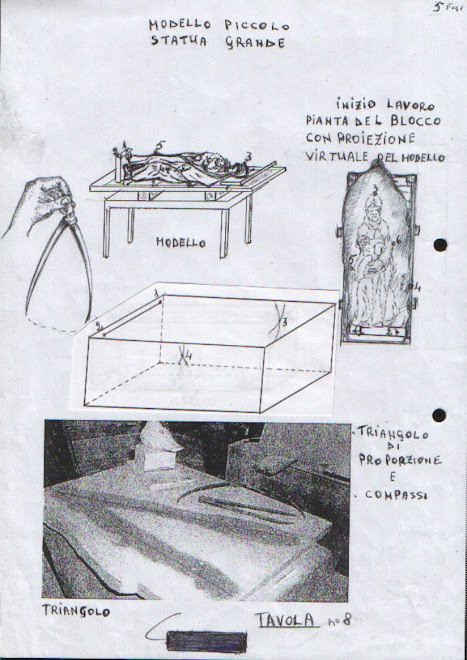
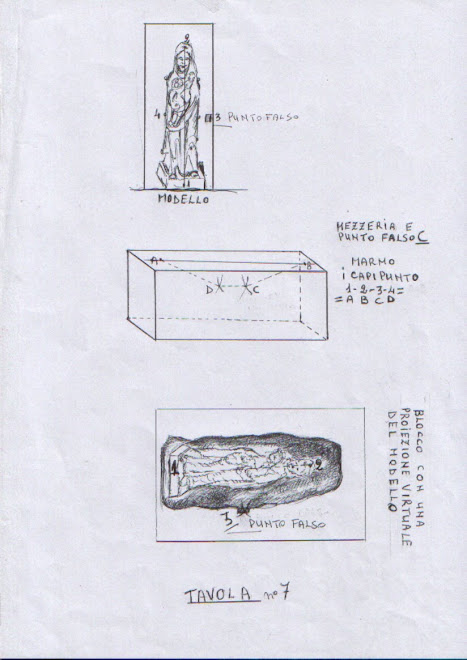


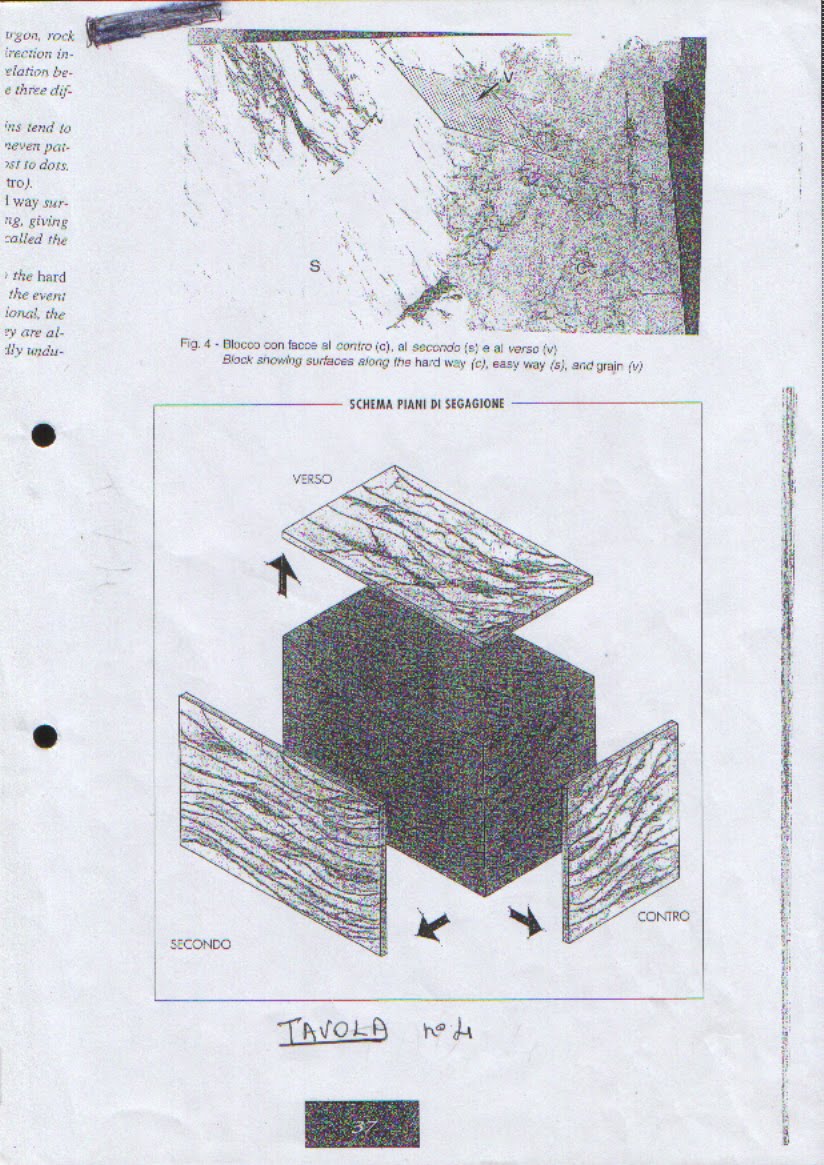


Nessun commento:
Posta un commento