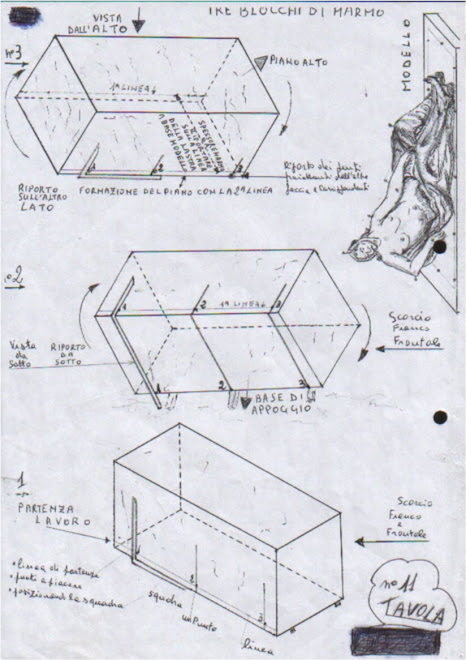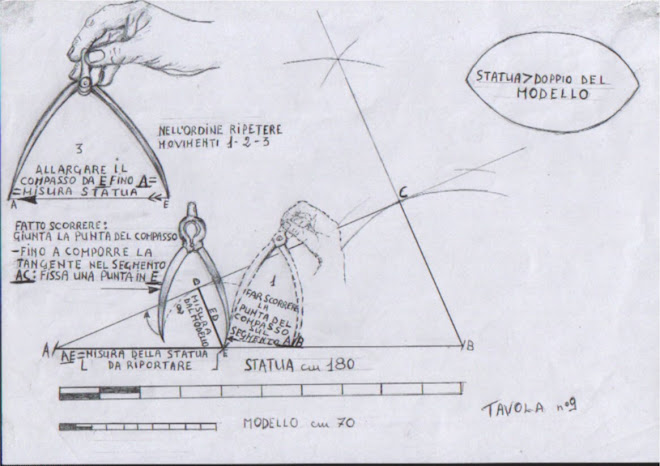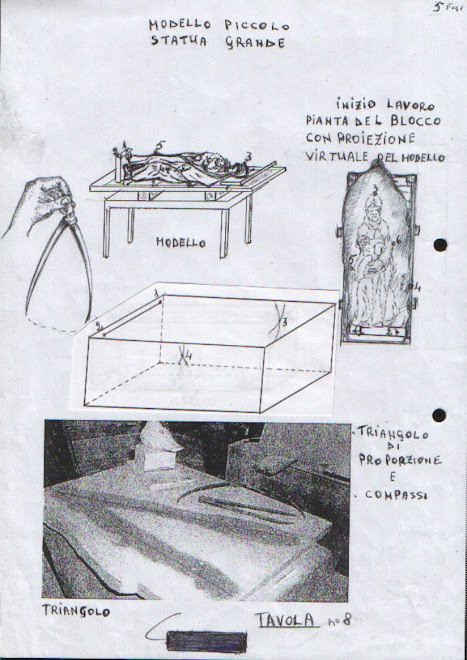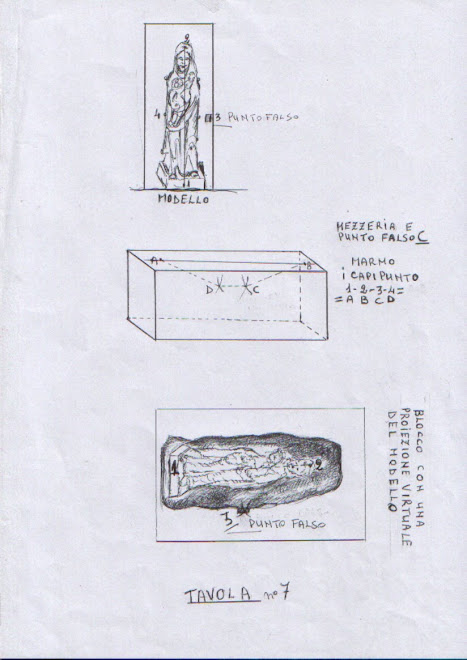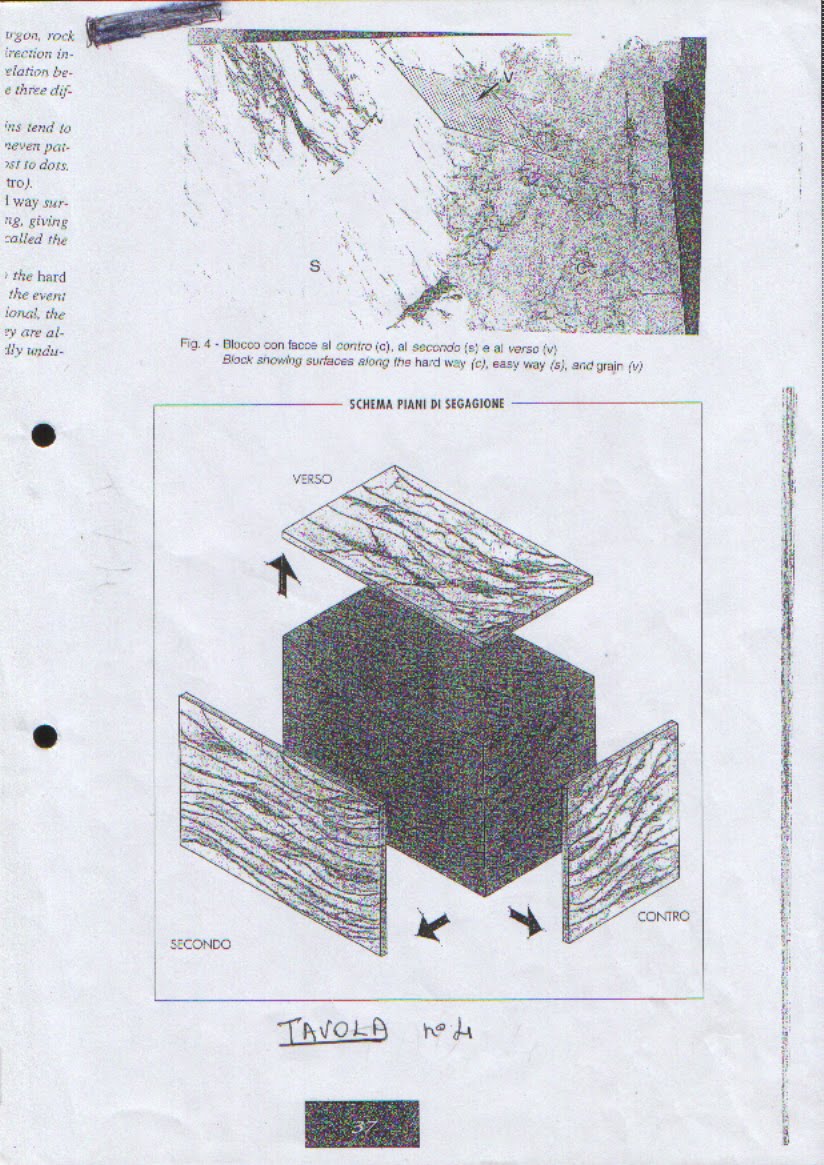IL BISOGNO ESTETICO DELL'UOMO.
Considerato il contesto primordiale nel quale si organizzò l'attività umana, non si esclude che essa si esplicò su innati bisogni essenziali: - nell'indagine sull'ambiente per assicurarsi migliori condizioni di vita ( conoscere per meglio corrispondere agli stimoli vitali ); - nello interrogarsi sulla propria esistenza, e su ciò che ha dato origine alla vita; sul significato della morte e dell'aldilà. Non è facile elencare una lista dei bisogni umani. “La psicologia caratterizza il bisogno nella carenza totale o parziale degli elementi di benessere innati e/o ambiti dalla persona. Alcuni di essi sono fondamentali e necessari alla sopravvivenza e sviluppo dell'essere individuale e sociale, quali l'alimentazione, la propria sicurezza e la miglior gradevolezza dell'esistenza; infine quella dell'affettività sessuale che costituisce l'essenza della prosecuzione della razza”.
Ma l'uomo non è soltanto istinto e pura animalità, se così fosse mai ci saremo evoluti. Perciò dobbiamo considerare l'emotività delle straordinarie bellezze dell'universo, le quali certamente lo hanno ispirato, quale grande protagonista e intermediario, abbagliato, tra l'immenso spettacolo della volta del cielo e la natura incontaminata circostante; quando non è il grande mare ad averlo stupito, con i suoi infiniti orizzonti.
Quali emozioni estetiche avranno provato quei primitivi? Quali pulsioni e facoltà spirituali si saranno attivate? La vita di allora certamente non piana, nella difficoltà di reinventarla, giorno per giorno, determinò la naturale reazione di alleviare l'esistenza con il bisogno estetico? Sicuramente il godimento contemplativo originò l'attività artistica, avendo come prima fonte la natura che è in grado di impressionare i singoli esseri, elevandoli spiritualmente, così come tutti gli aspetti più belli ancor oggi ci rasserenano. “ Il bello è qualcosa che ha forma, quindi tra perfezione e armonia” E. Kant. Fu grazie a questo appagamento che l'uomo poté superare la barbarie e percorrere più velocemente il binario della civiltà. Oltre a ciò, nell'epoca considerata, le prime esperienze espressive orbitavano, tutte, nelle misere pratiche del ristretto gruppo della tribù. Quindi le prime forme artistiche nascono con l'uomo stesso; nascono dalla realtà e dalla vita stessa, stimolando una spiritualità contaminante in tutti i luoghi abitati. Lo provano i numerosi oggetti a carattere estetico, quantunque modestissimi caratterizzati, sempre, dalla funzionalità e utilità del manufatto. Di fatto però, “ il sentimento del bello non va confuso con il piacevole, che è invece collegato alla reale esistenza dell'oggetto”. E. Kant. E' ovvio che la potenza produttiva, come il concetto del bello, segue lo sviluppo delle civiltà, indispensabili per il maturare delle condizioni di istruzioni, esperienza e, in determinate condizioni socio-economiche, il genio della mente e l'intelligenza della mano. Infine, “ il bello è ciò che piace universalmente, condiviso da tutti, senza che sia sottomesso a qualche concetto o ragionamento, ma vissuto spontaneamente come bello”. E. Kant.
Nasce così l'arte come espressione di regole genuine, si è tentati di dire artigianali, in continua lotta con l'innovazione. Il bello si ha quando nelle cose si trovano armonia e giuste proporzioni. “La bellezza è qualità percepite che suscitano sensazioni piacevoli che attribuiamo a concetti, oggetti, animali o persone nell'universo osservato, che si sente istantaneamente durante l'esperienza, che si sviluppa spontaneamente e tende a collegarsi ad un contenuto emozionale positivo, in seguito ad un rapido paragone effettuato consciamente od inconsciamente, con un canone di riferimento interiore che può essere innato oppure acquisito per istruzione o per consuetudine sociale”. E. Kant. “....l'ordine e l'armonia , mimesi naturalistica, valutabili per il piacere visivo che producono , valgono in quanto ripetono rapporti e leggi della natura e del corpo umano”. .. ..G.C. ARGAN. Diamo all'artigianato ciò che è dell'artigianato, che ha, da un lato, per sua destinazione e uso, almeno il privilegio di essere libero e affrancato da tutti quei condizionamenti che l'arte moderna impone, con tutte quelle sue astrusità espressive, che si nascondono dietro il nulla imposto dall'anarchia compositiva e “l'eccelso” materiale dello straccivendolo. Arte artigianale servile? Anche l'arte classica lo è, se comandata dalla religione, dal Principe, dal mercante? No! Perché l'artista puro non è mai stato asservito. E, non di rado, il buon artigiano, mediante la trasfigurazione, mantiene la capacità di trasmettere emozioni piacevoli, che costituiscono un vero linguaggio: attraverso l'esperienza, il mestiere, la stessa influenzabilità di più stili (scuola, tradizione, contesto storico). Poiché l'arte nel suo significato più ampio di espressione estetica, comprende ogni attività umana creativa, svolta singolarmente o collettivamente. Purtroppo, l'arte classica è la sola che è rimasta, in tutti i tempi, fonte inesauribile di emozione estetica. Oppure è considerata servile in quanto utile a qualcuno o a qualcosa nel risponde ad una precisa esigenza o rappresentazione di un ideale (“l'arte esprime la bellezza morale e spirituale mediante la bellezza fisica”. Cousin). Certo il pericolo è sempre incombente, anche quando un'opera è portata a buon fine con una tecnica impeccabile e rispondente alla commessa richiesta. Soprattutto se vincolata ad un qualsiasi "credo"; oppure se il committente fosse appunto “quell'idea” nata dai lombi di una delle tante divinità, oggi imperanti, e liberamente prigioniere solo dell'oligarchia dei galleristi e speculatori vari, quanto del “vile danaro per ogni moccio” , obbligatoriamente dato a chi, politicamente corretto, è contro l'arte servile. Una cosa è certa, escludendo l'arte con la - A - maiuscola, “ il buon artigianato rappresenta uno dei pochissimi attori di continuità culturale nella storia e nel costume di un popolo, proprio nell'espressione di una creatività che si fonda sull'intelligenza della mano abilitata e della quale la destrezza è parte; perché, il manufatto, ancora dipende dall'approvazione della sua qualità/funzionalità e dal senso estetico espresso: cioè dalla capacita di trasferire il messaggio emozionale dalla coscienza di un individuo a quella di un altro”.
La tecnica è utilissima sia per meglio governare la propria sensibilità ed ampliare la possibilità di riprodurre tutto ciò che è fonte di ispirazione, e costituisce la vera originalità di ogni artista nella sua personale distinzione. La troppa tecnica può guastare l'ispirazione? In un senso o nell'altro, ciò riguarda l'artista puro: senza tecnica come si difende l'originalità dell'ispirazione? Può nascere il prodigio, la cui emozione estetica e personalità sono supportate da una sufficiente e naturale espressione: naturale, come il canto dell'usignolo o il dono di sentire, in sé, rime che comporranno poi, l' innata poesia. Ma quale significato diamo all'esperienza umana che ci ha gratificato di immensi capolavori, irripetibili, e come interpretiamo il processo evolutivo dei tanti artisti che spesso ammiriamo? Gli è che si hanno prodotti, che vantano una qualche presunzione artistica, ma in realtà non sono altro che schizofreniche e paranoiche manifestazioni d'arte. E dobbiamo concionare di una scuola o civiltà artistica che produce e riproduce, a ripetizione, solo se stessa. Riproduzioni per lo più brutte, escludendo quell'abilissima tecnica che sa' perfettamente interpretare l'idea dell'artista e non ne mortifica né la libera espressione di lui né l'armonia e la sostanziale poesia dell'opera. La storia delle botteghe carraresi ne è una testimonianza storica inconfutabile. Il buon artigiano ha questo compito interpretativo, ma oltre al suo virtuosismo nessuno può negare anche il sorgere, tra essi, di alcune rare genialità. Nel bene e nel male, l'uomo tende a dare alle sue opere un senso, mutuandolo dalla natura e dal godimento contemplativo, fonti di ispirazione di ogni creatività artistica. Con ciò anche il modesto artigiano misura l'utilità del suo lavoro e del suo essere estroso, pur perpetuando, spesso all'infinito, modeste quanto utili/inutili riproduzioni.
Nel contesto delle attività umane, tutte queste rappresentano uno stile o la particolare realtà che le hanno ispirate, affidando loro la vocazione di rappresentare una funzione e di soddisfare bisogni, ma non sempre esprimono i gusti di un'epoca e ne rappresentano una concreta testimonianza.
Avanguardismo e astrattismo, nelle loro rappresentazioni di disordine e disarmonia, non rappresentano sempre un linguaggio compreso e condiviso; ciò non significa che non vi siano, in questi movimenti, anche opere pregevoli. Quindi, ritorniamo al punto di partenza, cioè nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un codice incomprensibile e ognuno di noi può darvi la sua occasionale e libera interpretazione. Riusciamo, invece, a condividere o comprendere quasi tutto, dei moltissimi studi del moderno linguaggio visivo, che sono studi della percezione visiva, del segno, delle superfici, il colore; il volume, il tutto tondo e la sua scomposizione in piani di luce; e poi lo spazio, la composizione, le tecniche, ecc. ecc.
L'anatema di oggi, è quello smisurato ego che disturba, quel “ solo concepimento dell'idea”, imperitura, universale, indiscutibile (perché, in alcuni casi, sfida solo i posteri); oppure l'emozione ed il godimento è solo del fautore. E' l'arte della provocazione che è un'arte al di sopra di tutto e di tutti: fuorché dalla pubblicità, che dà notorietà, che a sua volta dà successo; dal quale sorgono stima, onore, gloria e ricchezza. Gli Dei sono avvisati. La critica seria si adegui, il popolo pure.
E' quel Fiat, quel Deus: quell'attimo e quella luce Divina, che solo alcuni eletti possiedono, con lo “spotico” predominio delle idee: idee che, occasionalmente, però non si realizzano: “ se non vi sono quegli occasionali stradivari che mettono a posto le loro, tante, magagne “. Tant'è che, sovente, sono sufficienti screditati manovali, per sistemarle. Prezioso si è sempre rivelato il lavoro del mestierante o dell'artigiano, i quali con grande sensibilità e generosità, hanno saputo interpretare, spesso da piccoli modelli malfatti, grandiosi capolavori. E' questa l'autentica storia delle botteghe Carraresi.
La tecnica è indispensabile se ha il dono dell'umiltà e la capacità di immedesimarsi nell'idea dell'autore: ci riferiamo a quella sensibilità, anch'essa distinta forma d'arte che sa esprimere, con il linguaggio della poesia, l'originalità dell'ispirazione. Perciò non riusciamo a dimenticare, nell'ostinarci a renderla perfettibile, l'idea del “bello obiettivo”, così diffuso nella natura e nella vita. Così come è nella composizione dell'armonia cosmica e nell'ordine della disposizione del creato. Avvertiamo che questi equivalgono a serenità e bellezza; il contrario di ogni bruttura, al di là del tema religioso e dell'origine di ogni cosa. Diversamente l'arte moderna, in gran parte della sua infinita produzione, disdegna qualsiasi regola o canone compositivo. Disdegna altre sì ogni giudizio critico, quand'anche fosse quello che gli riconosce una piena libertà espressiva. Nel modo siffatto gli autori costringono l'universalità dell'arte a deformarsi, ad umiliarsi, spesso annichilendosi secondo le esigenze di fortuite e sgangherate originalità che rappresentano un eufemismo per non dire che trattasi solo di provocazione: o meglio un piegarsi della socialità universale all'opera di un LUI o di un LORO. L'individuo oggi ha la capacità di essere singolo individuo e contemporaneamente collettivo. L'uomo collettivo è giustificato a concepire l'arte come la nuova coscienza collettiva del nuovo mondo. Se avessimo la capacità di comunicare con un linguaggio comprensibile a tutti - un codice e realtà maggiormente condivise - oltre a migliorare le generali relazioni, avremo una coscienza globale nei confronti di comuni interessi. Il sapere collettivo consente di cogliere meglio ogni segno e movimento sociale o artistico. E' per questo che l'arte si gloria sempre del suo passato anche il più remoto ed è fonte inesauribile di emozione estetiche per tutti: archetipo e memoria a cui ricorrere nei periodi di decadenza.
L'ammirazione extra arte verso l'artigianato è benvoluta nei confronti di un oggetto ben fatto, funzionale ( utilizzo e gradimento primario ).
Riflettiamo su un qualsiasi oggetto utile, e anche alla sua forma che si ripete più volte, modulo, alla sua applicazione nella composizione modulare, che può assumere valore connotativo in progettazioni complesse ed eleganti design; ma può descrivere solamente l'oggetto nel suo uso comune, quotidiano, e quindi denotarsi. Abbiamo in mente il mortaio asservito al pestare, ma che il designer industriale ne ha colto tutte le suggestive forme elementari, riempiendo di stucchi colorati i vuoti e, giocando con l'accostamento delle forme, ha ben distinto la loro figura dallo sfondo, ottenendo le cosiddette figure ambigue, dove si percepisce ora una immagine ora un'altra, alternativamente, su delle superfici opportunamente progettate. Questa costruzione modulare è fatta nei muri degli edifici e ripetuta anche nei pavimenti e nei rivestimenti esterni e/o interni delle pareti divisorie.
E' sorprendente che Carrara, una città permeata da un'antica tradizione artigianale e con un passato artistico notevole, non abbia conservato una forte coscienza di sé, riducendosi ad una funzione marginale dell'arte e dell'artigianato d'arte: che è solo di appendice commerciale e mimesi meccanica. Salvo lodevoli eccezioni, si è passati dalle “botteghe” di un tempo agli odierni bottegai, venditori di brutte opere. Oltre l'innovazione, dove è finita quella cultura che sola è rappresentativa del futuro dell'artigianato. Artigianato come unico fattore di continuità culturale nella storia e nel costume di un popolo: di grande innovazione sì, ma contemporaneamente espressione di un creatività che tramanda di sé componenti etniche, sociali, estetiche, economiche e religiose; tutte espressioni di una società sinceramente rivoluzionaria e indomabile.
Nei momenti di grande sconforto non è facile ripensare Carrara e la sua gente, il ritmo materico dei laboratori sparsi nei vari borghi e ambienti (posti), veri luoghi della memoria ( quel ponte, quella chiesa, il particolare palazzo). Tutti ormai soggetti a mutazioni e monotonia e malinconicamente persi, persino dalle vivacità vocianti dei suoi “bardassi”. Serpeggiano, qua e là ombre, di una solitudine uggiosa senza neppure il conforto dei vecchi lampioni scomparsi nel tempo.
Riemergono, a contrasto, come fantasmi della memoria, le consunte immagini dello stuolo degli antichi lavoranti: scalpellini, ornatisti, scultori...., via via che il tintinnio dei ferri scema dentro di noi. Forti si sentono ancora i lazzi degli sfottò, che maturavano i novizi portandoli alla padronanza del mestiere. La restante arte prova ad affacciarsi dai vicoli bui, oscuri perché senz'anima; ché devitalizzati e senza più identità: dove lo storico non è più storico ed il Centro non è più tale.
Allora lo sguardo volge lassù, verso quella montagna imponente e diafana che da sempre ha segnato il destino delle sue genti. Volge lassù verso quello storico compendio di blocchi sparsi: informi, abbozzati, squadrati, che ancora portano dentro di sé il risuonare di martelli e scarpelli. Una Carrara ricca dei suoi tanti mestieri, gelosa dei suoi saperi e delle sue scuole-bottega, è amata per la visibilità delle sue opere ben fatte (a regola d'arte). Una grande città perché ha dotato, di una superiore intelligenza, la mano di un esercito di artigiani.
Fuori dalle gelosie e dalla concorrenza, una risposta gli artigiani sono tenuti a darla:alla tradizione al centro storico, alla loro sopravvivenza.
C'è bisogno di condividere esperienze, visibilità, minori costi ed un "cartello" che rappresenti le produzioni lapidee presenti nel territorio.
Una vetrina nel Centro Storico, con esposizioni qualificate e permanenti, abbinate ad un turismo selezionato, potrebbero essere una prima risposta.
Mi ha colpito un sunto di E.Repetti : “Nella maggior parte dei comunelli , il complesso dei quali forma la comunità di Carrara, i principali abitanti riunironsi in società sotto il nome di VICINANZA,
acquistarono in comune degli agri, frantoi, e molini, ne affidarono l'amministrazione ad un agente amovibile, e si obbligarono ciascuno verso tutti, e tutti verso ciascuno.....”.
Artigianato, Commercio e Turismo potrebbero unitariamente, con l'aiuto di contributi Europei Nazionali ecc..ecc...UNIRSI? RIUNIRSI?
sabato 7 luglio 2012
Iscriviti a:
Commenti (Atom)